
ROMA
QUATTROCCHIO CAPORIONI E CONSERVATORI
FARMACIA QUATTROCCHIO 1537
CAMPIDOGLIO
CASE
DEI QUATTROCCHIO
DONAZIONI DI FLAMINIO
QUATTROCCHIO
VILLA QUATTROCCHI
BEATI
MARIA E LUIGI BELTRAME QUATTROCCHI
ELENCO
FAMIGLIE NOBILI ROMANE
MP3-LE-COLLINE

Cartari Febei - Archivio di Stato di Roma:

Quattrocchio di Roma e d'Amelia. Arma: "D'oro con un'aquila nera ed un triangolo partito in canaletto, la parte superiore d'oro con quattro occhi umani dei propri colori, l'inferiore rombeggiata di rosso e d'oro". Antichi e nobili Signori di Roma - (come da Catalogo Romani de Calvis di Alphonsus Ceccarelli - ex libro manoscritto di Guglielmo Cardelli e Fanutio Campana in Biblioteca Vaticana "Paulus de Quattuor Oculis" in registro Nicolai Laurentij de seguacibus tribunij - Papa Urbano VI - (anno 1382) e Nobili moderni di Amelia.
Titolo nobiliare:Antichi e Nobili Signori di Roma- Conti Palatini - Cavalieri Aurati.
Notizia della Famiglia Boccapaduli patrizia romana ordinata e distesa da Marco Ubaldo Bicci Censore dell'Accademia Teologica dell'Arciginnasio Romano - Roma 1762
CRACAS - DIARIO DI ROMA - 1890 (cose vecchie e nuove)1408-1410
Dello Rione de ponte (id.). Notasi un figlio
« de menico 4 occhi », cioè
Quattrocchi.
A proposito del Cerimoniale delle pompe ufficiali del ludum in Agone 1°
andava sempre Trastevere, ultimo Monti. Partecipavano 10 cavalieri dai 10 rioni
fra i quali si trova un figlio di Domenico Quattrocchi.
Archivio della R. Società
romana di storia patria - Pagina 84
di R. Società romana di storia patria - 1891
Trovo Cecchus (Francesco) Quatuoroculi in questa lista proveniente dall'Archivio della R. Società Romana di storia patria del 1891.
ARCHIVIO CAPITOLINO "IL CREDENZONE ROMANO"
FAMIGLIA QUATTROCCHIO - 1495 - 1580
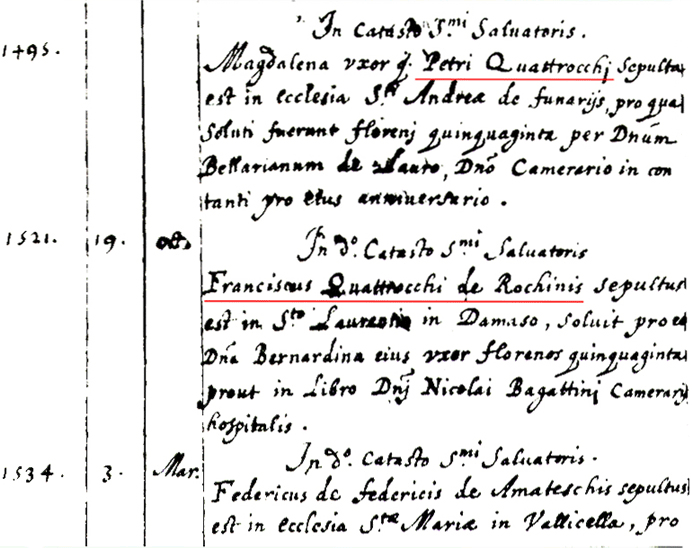
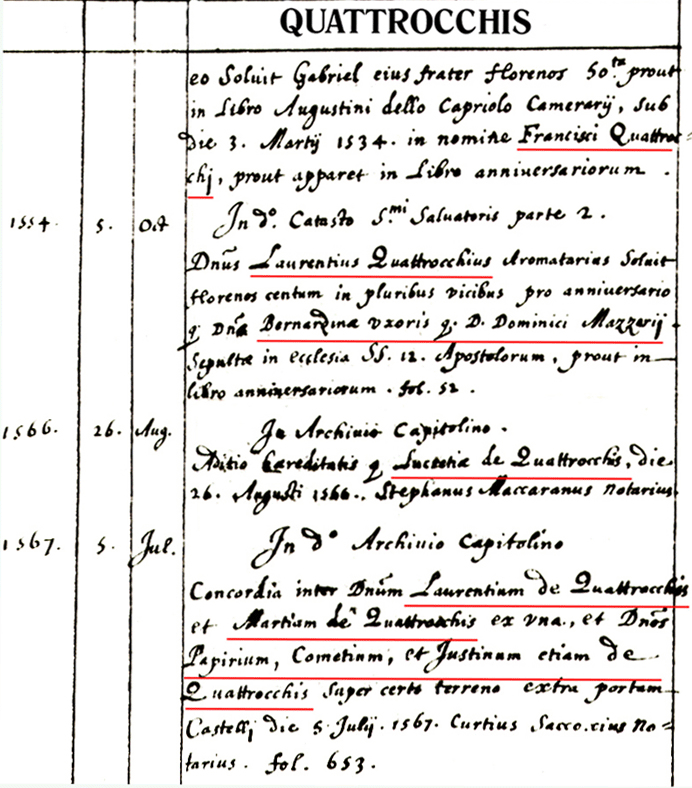
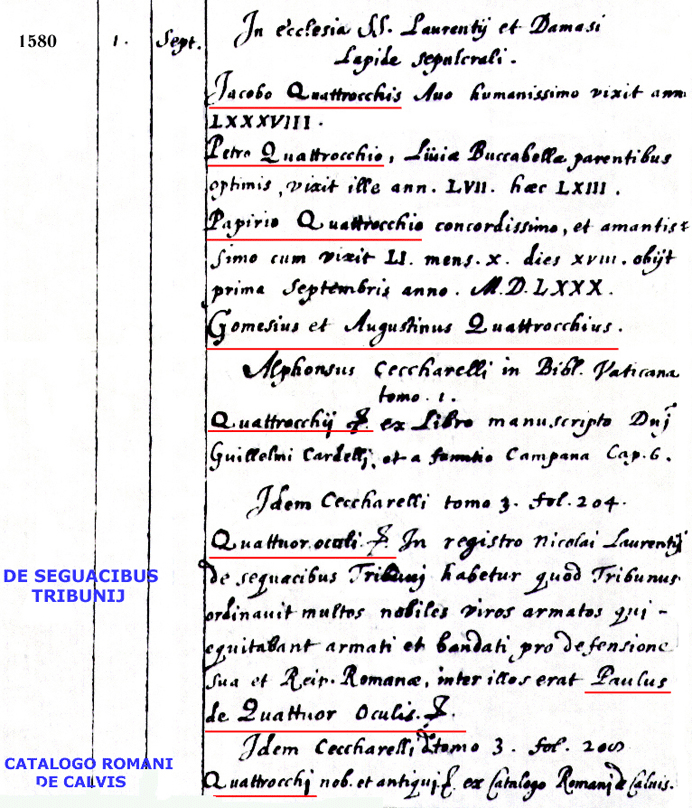
LE NOTE DEL CREDENZONE SONO RIPORTATE ANCHE NELLA BIBLIOTECA VATICANA: ALPHONSUS CECCARELLI - TOMO 1
"Quattrocchij Signori" ex libro manoscritto D.nj Guillelmi Cardelli, et Fanutio Campana - cap. 6
idem Ceccarelli - tomo 3 - foglio 204 - idem Ceccarelli tomo 3 - foglio 209 "Quattrocchij nobili et antiqui Signori" Catalogo Romani De Calvis.
In altro libro, manoscritto, di Gulielmi Cardelli e' riportato: "Romano tempore Massimi".V.pp et Sigismundo Cesare Germano Imperatore ordinem alphabeti sic notata aut nobilium romane nomina et sic ad litteram resempsimen: Quattrocchij a pag. 80.
Fanutio Campana sempre in sopraddetto manoscritto riporta il nome Quattrocchij in un elenco di famiglie nobili romane - pag. 71
N.B.: dal Ceccarelli tomo 3 foglio 209 e' riportato quanto ricavato dal Catalogo Romano De Calvis - pag. 206 "Catalogus Nobilium Familiare Romane" facta tp e pp. Urbani VI circa anno domini 1382".
Queste notizie sono ricavate dalla "Cronica di Pietro Caffarello".
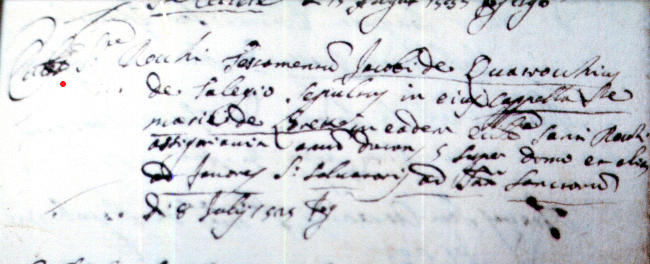
Chiesa di S.Rocco - Testamento di Iacobi de Quatrocchius de Talegio
Tratto da: "Storia delle famiglie romane" Amayden

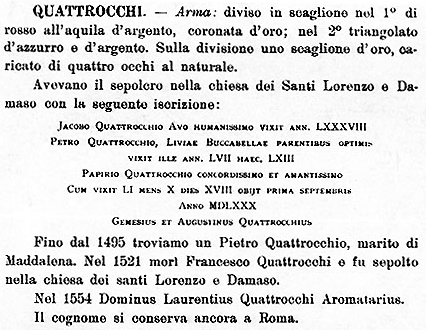
Repertori di Famiglie. di Domenico Jacovacci - tomo 5 -ottoboniani lat. 2552- Biblioteca Vaticana:1521 - 19 ottobre - ----In detto catasto S.mi Salvatoris.
Franciscus Quattrocchj de Rocchinis ...... in San Lorenzo in Damaso (all'ingresso secondario ex entrata principale, lato destro, appena si entra) si trova la lapide sepolcrale, ivi ubicata in seguito al restauro del pavimento della Basilica con la seguente scritta: FRANCISCUS ROCHINUS COLLECTOR PLUMBI PA. ROM. QUI CUM OB SINGULAREM VIRTUTIS INTEGRITATEM A BERNARDINA DE ANULO CONGIUNTI CARISSIMA DILIGERENTUR HOC TUMULO DECORATUS EST ANNO LV EGIT DIE VERO XXVII DECEMBER IN VITAM REDUT MDXX.



Fino dal 1495 troviamo un Pietro Quattrocchio, marito di Maddalena. Nel 1521 morì Francesco Quattrocchio de Rocchino e fu sepolto dalla moglie Bernardina (Altoviti? lo stemma inquartato di Francesco ricorda l'arma degli Altoviti) nella chiesa dei Santi Lorenzo e Damaso.Nel 1554 Dominus Laurentius Quattrocchio Aromatarius.
Dall'Archivio Capitolino
risulta che Giacomo
Quattrocchio fu seppellito nella cappella
di San Rocco nella Chiesa
di S. Rocco l'8 luglio 1525 - quando la Chiesa
di S. Rocco ha cessato di essere Chiesa parrocchiale i registri sono
stati trasferiti in S. Lorenzo in Lucina.
NOTA: San Rocco, a cui è vicino l'ospedale fondato dal cardinale Antonmaria
Salviati per le vergognose partorienti. Nella Chiesa di
S. Rocco si riuniva l'Ordine dei Farmacisti
e Speziali.
Il giorno 1 settembre 1575, a causa delle frequenti esondazioni del Tevere, Jacopo - Giacomo fu trasferito nella nuova cappella sepolcrale dei Quattrocchio presso la Chiesa dei Santi Lorenzo e Damaso di fronte all'altare di S. Carlo Borromeo.
Pietro Quattrocchio, Livia Buccabella ( Boccabella o Boccapaduli ) parentibus optimis vixit ille anno LVII. Hac LXIII
Notizia della Famiglia Boccapaduli patrizia romana ordinata e distesa da Marco Ubaldo Bicci Censore dell'Accademia Teologica dell'Arciginnasio Romano - Roma 1762
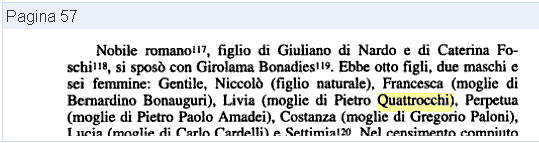
Altro Pietro Quattrocchio, è marito di Livia Di Nardo Imparentati con i Bonadies , i Bonaguris , gli Amadei , i Paloni , i Cardelli e i Foschi .
S. BENEDETTO IN PlSCINULA
"PERSONAGGI SEPOLTI A S. BENEDETTO IN
PlSCINULA" DEL P. ABBATE D. COSTANTINO CAETANI
"..li'6 Giugno 1598 morse Madonna Livia Boccabella in casa del Signor Tarquinio Santa Croce di febre et vecchiezza, fu sepelita in Santo Benedetto li 13 Febraro 1600.." Vedova di Pietro Quattrocchio morto nel 1557
Papirio Quattrocchio concordissimo, et amatissimo cum vixit annos LI mesi dieci e giorni 18. obijt prima septembria anno MDLXXX da "Repertori di famiglie" di Domenico Jacovacci - tomo 5.
In Santa Maria del Popolo - Lapide Moscabuffi (Mactabuffi)- anno 1435 - una Quattrocchio.
Tratto da "Repertori di Famiglie" di Domenico Jacovacci - Tomo 5 De Quattrocchij - In catasto S.mi Salvatoris.
- Maddalena, moglie di Pietro Quattrocchio e' sepolta in S.Andrea de Funarijs. Da questa unione nacquero due figlie: Virginia e Lucrezia. Pietro si sposa in seconde nozze con Livia Boccabella (Boccapaduli). Da cui naquero 3 figli :Papirio ,Gomezio e Agostino.Muore nel 1557 come da testamento del notaio Gasparre Raisdettus - tomo 596 della prima sezione.
Informazioni tratte da "Roma nel '500-Rione Ponte" II volume pag. 14 autore: Pietro Fornari conservato nella Sala Manoscritti e Scritti Rari della Biblioteca di Stato di Roma Vittorio Emanuele II
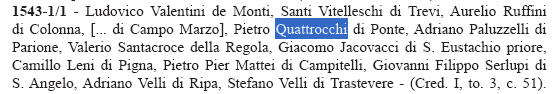
Famiglia Quattrocchio
- Furono caporioni (Rione di Ponte S. Angelo): Pietro
nel 1543 - Mario nel
1558 - Gometio nel 1559/1565 e Primo Conservatore
nel 1583- Agostino (Ripa) nel 1570 e Secondo
Conservatore nel 1586 - Patrizio Caporione
nel 1586 - Papirio fu Sindaco del Senato
e Popolo Romano nell'anno 1570 e Maestro Giustiziere nel 1572.
1561 - Conservatori: Luca Peto, Giacomo Staglia, Marsilio Cafani, Papirio
Quattrocchio.
Le fontane di Roma - di Cesare D'Onofrio
- 1986
A pag. 195:.. Consiglio comunale: il negozio
della conduzione a Roma dell'acqua da Pantano alle fontane pubbliche sulla Piazza
delle Terme di Diocleziano. " Gometio Quattrocchio,
uno dei due Conservatori che avevano partecipato alla seduta della Congregazione,
il giorno seguente riferiva in Campidoglio in sede di Consiglio segreto:.....
Considerazioni storiche, fisiche, geologiche, idrauliche,..- di Carlo Fèa - 1827
DALL' ARCHIVIO CAPITOLINO .
Num. 1.
- Resolutio Congregationis super fontibus de insinuanda ex mente SSmi Populo
Romano conductione aquae ab ejus origine pro constituendis publìcis fontibus
in platea Capitolina, et alii. Die 26. maii 1583
- .Apud sedes ill.mi , et r.mi d.ni card. Maffei : ill.mus , et r.mus d.nus
cardinalis Maffaejus , ill.mus, et rr.mus cardirnalis sancti Sixti, ill.mus
et r.mus d.nus cardinalis Medices, illmus dnus Rodulphus Bonfiolus Thesaurarius
generalis. Illmi DD. Cometius Quattrocchius , Vincentius
Americus conserv. Alexander Juvenalis prior, rmus dnus Mutius Passamontius illmi,
et rmi domini Camerarii locumtenens , Hieronymus Alterius , Paulus Bufalus viarum
magistri , Hortentius Frangepanius , Stephanus Paparonius , Fabius Sanctacrucis
, Mutius Matthejus deputati , Fulvius Amadejus commissarìus generalis
fontium . DECREVERUNT : omissis etc. Tandem, quod illmi dd. Cons. EX MENTE ssmi
D. N. populo Romano insinuent , conductionem aquae e pantanis Griphii, faciendam
, illique exponant , ut declarent pro FONTIBUS PUBLÌCIS in montibus ,
et PLATEA CAPITOLINA conficiendis , quantam quantitatem aquarum recipere intendant
- ut conductores certam habeant spem illius erogationis , postquam super plateam
b. Virginis Mariae Angelorum conducta fuerit . Duosque probos viros insistentes
nominent juxta seriem literarum apostolicarum etc. Resolutio consilii secreti
magistratus et consiliarìorum pop. Romani de emendis centum unciis aquae
, de qua num. 1 pretio scuti 5oo. pro qualibet uncia , ad effectum de quo supra
. 27. maii 1583. - Consilium secretum , per mandatarios
publicos , dimissis cedulis , pro secunda vice , ad VI. kal. junii convocatum
, nobisque Horatio Fusco , et Vincentio Martholi sacri senatus scribis , apud
Lovium palatii Capitolini relatum , in quo intervenere :
Capita Regionum. Alexander Juvenalis prior , Pompejus Rubeus , Ludovicus
Albertonius , Annibal Corona , Gregorius Nichilchinus , Fabius Figliucius ,
Julius Soderinus ,Officiales , Dominicus Heruccius , Jo. Baptista Vallatus ,
Paulus Mutianus , Antonina Sanctius , Nicolaus Pirotus . Consiliarii, Hieronymus
Alterius , Paulus Bufalus , viarum magistri, Antonius Maccantius , Balthaxar
Cincius , Jacobus Rubeus etc. Et denique sequuntur alii usque ad numerum 15.
consiliarorum .Quibus considentibus illmus dominus Cometius
Quattrocchius primus cons. cum praesentia , et voluntate illmorum dd.
Ascanii Bufali , et Vincentii
Americi ejus collegarum sic proposuit : Magnifici signori . Jeri illmi
, e rmi signori Cardinali sopra le fonti , ne dissero nella congregazione, che
N. S. desiderava grandemente , che si conducesse l'acqua di pantano di Griffi
, la quale secondo la livellazione fatta , viene alta sopra la piazza di Termine
più di 15. palmi; e che si sono trovati mercanti , ed altri , quali a
tutte loro spese vogliono condurre detta acqua : il che conosciutosi da N. S.
quanto sia utile al publico, ed al privato, e col tempo causerà l'abitazioni
nel detto , ed altri luoghi della città ; e che si è convenuta
con l'appaltatori , che condotta , che sarà detta acqua , la possano
vendere 5oo. scudi l'oncia , e non più, siccome nel breve sopra ciò
spedito si contiene ; ma perchè l'appaltatori non possono , nè
vogliono condurre quest'acqua , se non veggono il smaltimento di essa ; per
questo detti illmi , e rmi signori Cardinali visto tanto utile evidente a questa
città ne esortano a prendere una buona quantità , e far 4. o 5.
fonti pubbliche , e una principalmente nella piazza di Campidoglio per utile
pubblico : il che abbiamo voluto riferire alle signorie vostre , acciò
risolvino quello , che sia d'utile , ed onor pubblico in questo negozio. Quibus
auditis , et mature discussis ex s. c. una omnium sententia decretum est , quod
facta hujusmodi aquae conductione per appaltatores in lite nominatos , super
platea Thermarum Diocletianarum , beatiss. Virginis Mariae Angelorum nuncupata
pro fontibus publicis , et praecipue in regione Montium arbitrio extruendis
, capiantur per Romanum pop. ex aqua praedicta unciae centum , pretio in litteris
apostolicis desuper expeditis expresso pro usu publico, et publicis plateis,
et non alias applicandi , et convertendi : quodque pretium et pecunia in dictis
unciis ceutum aquae erogandum ( de licentia tamen , et voluntate praelibati
S.D.N. ) , cui etiam populi Romani nomine de praemissis humiliter supplicetur
, sumantur ex venditione quingentorum locorum super monte, et gabella carnium
urbis , erigendor. et per pop. ut moris est vendendorum , et prout in conductione
Aquae virginis fact. extitit : et quod juxta seriem , et tenorem dictarum litterarum
, deputentur duo,qui operi, et conductioni praedictae insistant : conductor
, impensis remunerand. : idque publico consilio ( cui remittitur) insinuetur
.
Omissis etc. firmati : Cometius Quattrochius
Conserv. Vincentius Americus Conserv.

pag. 21:nel nostro rione le famiglie nobili non disdegnavano l'esercizio farmaceutico e bancario.
A pagina 22: quasi tutte le farmacie erano distinte da un'insegna.
Cosi' quelle dei Quattrocchio. (Atti del Notaio Tuffi 20 novembre 1537)
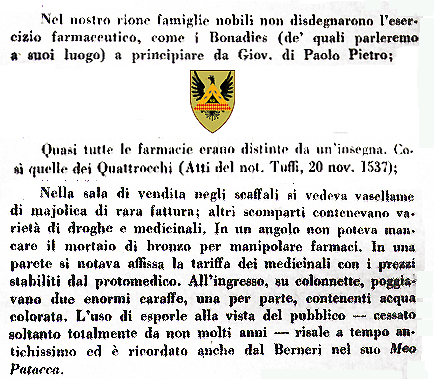
The Nobility of Rome, 1560-1700
Di Richard Joseph Ferraro
Laurentius Quattrocchio Aromatarius compare nell'anno 1545 sul libro:
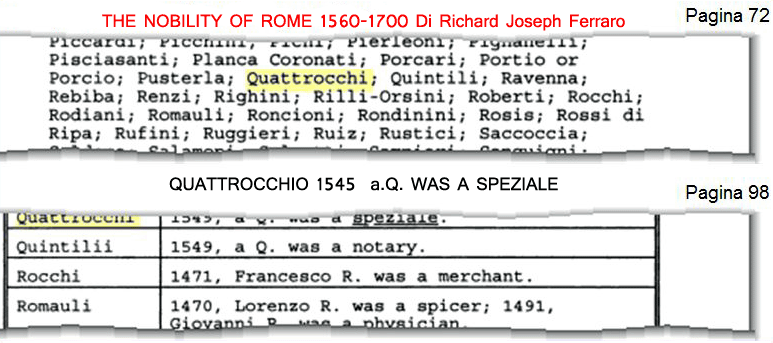
LES COLLECTIONS D'ANTIQUES
DES MEDICIS. - Mémoires de l'Institut impérial de France, Académie
des inscriptions
di Académie des inscriptions & belles-lettres (France) - 1833
Firenze, 5 febb. 1579. Lorenzo Quattrocchi (alias Dominus Laurentius Quattrocchio Aromatarius a Roma anno 1554) spedisce a M. Lorenzo Spinelli un mortaro di porfido col suo pestello. Pagina 163



Dal Primo volume "Iscrizioni delle chiese e di altri edifici di Roma" pubblicato da Vincenzo Forcella nell'anno 1869 e' riportato: "al termine della grande scala che immette alla Piazza del Campidoglio, alla base della Statua di Polluce vi e'una lapide con sopra scritti i nomi dei Conservatori in carica nell'anno 1583: GOMETIO QUATTROCCHIO - ASCANIO BUBALO - VINCENTIO AMERICO . Gli stemmi dei Conservatori sono stati conservati fino al 1956 nella Cappella del Palazzo dei Conservatori.
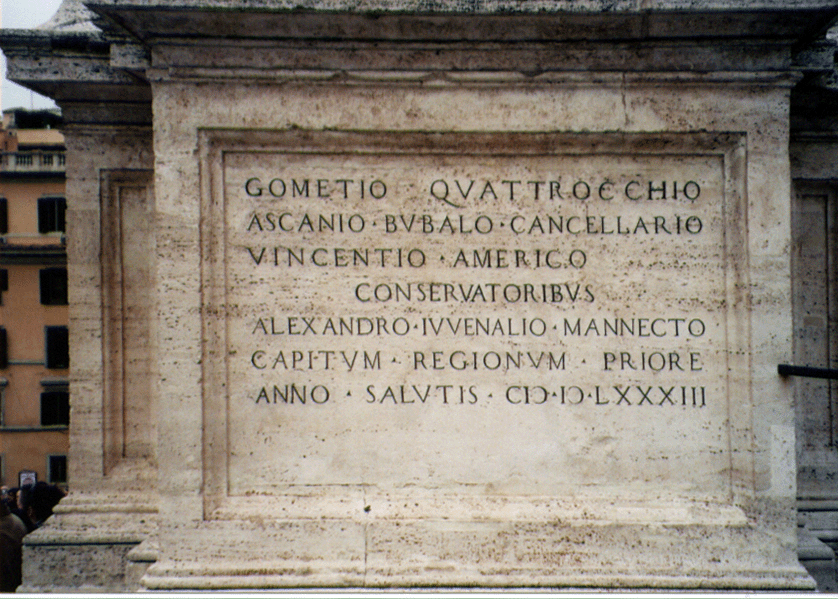
ISCRIZIONE ALLA BASE DEL PILASTRO DEL DIOSCURO POLLUCE IN CAMPIDOGLIO (Roma)
Foto di Paolo de Manincor
In biblioteca del Campidoglio, dal libro delle "Iscrizioni delle chiese ed altri edifici di Roma" pubblicate da Vincenzo Forcella - volume 1 - anno 1869, e' riportato:
"Al termine della grande scala che immette alla Piazza del Campidoglio, alla base della statua di Polluce, vi e' una lapide con sopra scritti i nomi dei Conservatori in carica nell'anno 1583 - Gometio Quattrocchio - Ascanio Bubalo Cancellario - Vincentio Americo".
GUIDE RIONALI
DI ROMA - CAMPITELLI - PRIMA PARTE
a cura di Carlo Pietrangeli
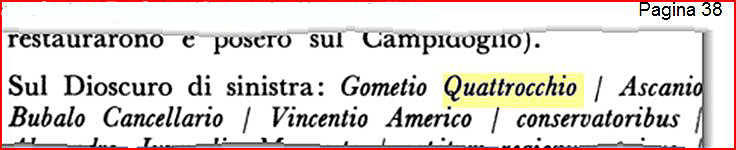
Sopra l'ingresso della Cappella nel Palazzo dei Conservatori. Gli stemmi appartengono agli stessi tre conservatori.
Nota: i sopraddetti stemmi segnalati dal Forcella, in seguito ai restauri eseguiti intorno agli anni '50, sono stati sostituiti con stemmi di altri Conservatori...
Sempre da "le iscrizioni delle chiese" del Forcella viene segnalato uno stemma del Conservatore Gometio Quattrocchio nel Palazzo Senatorio in Campidoglio.
STEMMA DI GOMETIO (GOMEZIO) QUATTROCCHIO DESCRITTO NEL LIBRO DEL CAMPIDOGLIO
CHE RACCOGLIE GLI STEMMI DI TUTTI I CONSERVATORI
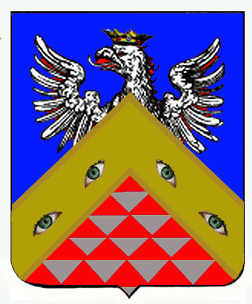
Arma: diviso in scaglione nel primo di azzurro all'aquila d'argento, coronata d'oro; nel secondo triangolata di rosso e d'argento. Sulla divisione uno scaglione d'oro caricato di quattro occhi al naturale.
Anche il bassorilievo dello storione riporta i tre stemmi dei Conservatori del 1583.
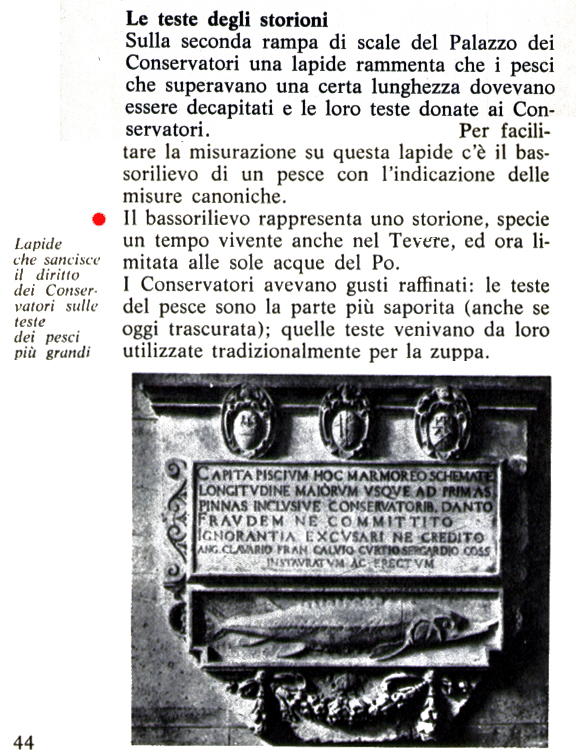
BIBLIOTECA VITTORIO EMANUELE II
STORIA DIPLOMATICA DI SENATORI DI ROMA
DI FRANCESCO VITALE
Nel secondo volume e' riportato lo Statuto emanato da Papa Gregorio XIII nell'anno 1583 (da allora rimasto sempre in vigore) col quale era imposto al Senatore (candidato) di giurare nelle mani dei tre conservatori e poi nelle mani del Papa. Poiche' nello stesso anno era in carica come Primo Conservatore Gometio Quattrocchio fu il primo a ricevere nelle proprie mani il giuramento del prescelto Senatore Conte Segni che, in seguito, lascio' tale investitura perche' eletto Vescovo.
Libro d'oro del Campidoglio (Roma edizione 1893)
Nell'elenco dei Conservatori di Roma sono riportati: Gomezio Quattrocchio Primo Conservatore nell'anno 1583 e Agostino Quattrocchio Secondo Conservatore nell'anno 1586.
RODOLFO LANCIANI - STORIA
DEGLI SCAVI DI ROMA E NOTIZIE INTORNO LE COLLEZIONI ROMANE DI ANTICHITÀ
Volume Secondo (a. 1531-1549) ROMA
ERMANNO LOESCHER & C.o (bretschneider e regenberg)
Librai-Editori di S. M. la Regina d'Italia 1903
Nel 1583, seduta dell'8 marzo decretum est prò perfectione palati! Capitolini
et ornamento statuarum perficiendo capessendas esse duas figuras marmoreas per
dnum Vincentium Stampam et alteram per dnum Hieronimum Picum oblatas «
. Si propone una Commissione per esaminare e riferire. Ambedue questi personaggi
sono noti come appassionati collettori o negozianti di opere d'arte, e di antiche
iscrizioni. Avrò occasione di descrivere i loro antiquari nella seconda
parte del terzo volume. Nel terzo trimestre dello stesso anno i Conservatori
Quattrocchi, del Bufalo
e Americi collocarono « in museo
capitolino colosseas protomes Traiani et Antonini Pii « (Forcella, 77).
Pare che in questi ultimi anni di Gregorio XIII si fosse manifestata tra i gentiluomini
romani la stessa epidemia del vendere ad ogni costo, della quale abbiamo avuto
tanti altri casi nei tempi nostri. Il Comune di Roma, non sapendo a quale santo
rivolgersi, prende un provvedimento alla moderna, il più inefficace fra
tutti: nomina cioè (20 giugno 1583) una Commissione d'inchiesta composta
di Tommaso Cavalieri, Andrea
Velli, Girolamo Paparoue, Paolo
Fabi, e Pier Tedallini, raccomandando loro
« quod statuas et marmoreas figuras magci dìii Octavij Capranica
et aliarum particularium personarum vendere volentium videant, perspiciant,
et considerent » Della Commissione e del suo operato non si trova altra
traccia nei documenti del tempo. Nella seduta seguente del 19 dicembre 1584
Ottavio Formicini, anche a nome di Orazio
Bongiovanni e Angelo del Bufalo, propone
che sia condotto a termine il restauro del Castore e del Polluce, in capo alla
Cordonata, restauro sospeso da qualche tempo per mancanza di fondi. Propone
sopperirvi coi proventi dell'affitto del protonotariato di Ripa. La proposta
è approvata nel Consiglio pubblico del 20. Tuttociò dimostra che
le iscrizioni Forcella, tomo I, p. 42, n. 78, incise nei piedistalli dei Dioscuri,
non dicono il vero, o piuttosto dicono che i Conservatori
Quattrocchi, del Bufalo
e Americi fabbricarono quei pesamenti
nel 1583, ma non vi misero sopra i colossi. Molto più che ho trovato
nelle carte del notaio Gerolamo Arconio (A, S. C. IV, tomo 104, e. 161) l'atto
ufficiale di consegna « di uno delli Giganti
ciò di Castore e Polluce
in cima della scala del foro del Camp." » a. M° Gio : Ant*' :
Valsoldi, fatto il 12 d'agosto 1594, perchè egli lo restaurasse al prezzo
pattuito di scudi 450. Pure nel 1584 fu collocata
sulla balaustrata della piazza « columnam milliariam primi ab urbe lapidis
indicem » (Forcella, n. 81-82). Le serviva di piedistallo l'ara di Adriano
CIL. VI, n. 967 a, sui fianchi della quale furono due volte incisi i nomi dei
consiglieri Magarozzi, Gualtieri
e Capocci. A costoro si deve anche l'acquisto e
il trasferimento della statua di Baccante
(Forcella, n. 83), che ora si trova sulla sinistra del vestibolo del palazzo.
Nel seguente anno 1585 i Conservatori domandarono al card. Guastavillani, ca-
merlengo, il permesso di scavare dalla parte del clivo capitolino in cerca di
materiali da costnizione. La « licentia effodiendi
prò Pop.® Rom.*> et diìo lohanne Margano museo capi- fu
rilasciata il 12 settembre, ed è del seguente tenore: Dno loanni Margano
Rom. "Humilibus nomine Incliti S. P. Q. R. nuper nobis moti etc, eidem
populo Romano specialem gratiam facere uolentes De mand** in ascensu Montis
Capitolini prope palati um 111.' D. Senatoris (citra lesionem d. palatij) eiusdem
P. R. nomine effodere et quoscimq. lapidea marmoreos Tiburtinos offiticos (?)
porfireticos et alteriiis cuiuscunq. speciei eia- uare ac in seriiitiiim Palatij
et fabrice Capitoline conuertere libere possis harum serie facult.'" impertimur.
Volumus tamen quidquid inuentum fuerit Dflo Horatio Boario Commissario a nobis
deputato fideliter denunciare tenearis » . (Provv. Camerl. a. 1585, e.
175' A. S.). Il 13 ottobre 1586 apparisce per la prima volta nei verbali la
faccenda delle statue di mons. Adriano Fusconi,
vescovo di Aquino, il nome del quale rimarrà sempre legato a quello del
Meleagro Vaticano. Pare che questo illustre raccoglitore
avesse conceduto al pò. ro. per testamento un non so quale diritto sulla
propria raccolta vincolata in fidecommesso: ma l'espressione dei verbali non
è chiara: « Confirmatum fuit decretum secreti consilii super fidei
commisso statuarum d. Adriani Fusconij episcopi Aquinatensis et data fuit potestas
Conseruatoribus eligendi duos nobiles qui diligenter curent uidere inuentarium
forsan factum " La più antica memoria di casa Fusconi
e del suo primo rappresentante in Roma, il dottor Francesco, si trova nel prot.
94 dell'Amanni a e. 251. « Ciim fuerit et sit quod als prò ampliatione
platee de farnesìo site ante palatium illmi dni petri aloisii de farnesio,
fuerint demolite due domuncule egregii artium et medecine doctoris Magistri
Francisci fusconi de Nursia » cet. Egli è
forse a causa di questa vicinanza di domicilio e di queste relazioni d'affari
che il Fusconi, già in fama per avere curato
Benvenuto Cellini (Vita, lib. I e. 84),
divenne archiatro di Paolo III. Vedi Marini, « Archiatri » tomo
I, p. 325. La posizione della casa, dove tanti tesori d'arte dovevano essere
col tempo raccolti, è indicata in un documento del 1554 in questi termini:
» Domus Amatorii de Penna sita prope plateam Farnesio rum, cui ab antea
est ipsa platea ab uno latere via queadicta platea tendit ad campum Flore, ab
alia parte coherent bona dui Ioannis Angeli Crivelli
et in conspectu habet palatium heredum quondam magistri Francisci
Fusconi de Nursia phisici (Not. Reydet, prot. 6165 e. 102 A. S.). Pare
che Francesco avesse un fratello di nome Vespasiano,
il cui testamento del 1557 (not. Amadei, prot. 33 e. 531) contiene notizie preziose
per la storia della famiglia. Il vescovo Adriano
era divenuto padrone del palazzo « in platea et conspectu palatii de Farnesio
« o nel 1554, o poco prima, poiché in una carta del 9 maggio di
quell'anno si fa già chiamare rev. d. Adrianus
Fusconus electus aquinatensis heres bo: me: magistri Francisci
Fusconii fisici eius patrui » (not. Amadei
prot. 29 e. 465 A. S.). Nel libro del monaco Celestino
Fortunato Ciucci, « Historie dell'antica città di Norsia
» a. 1650, p. 65 trovo questo passo: « Delli Fusconi
. . . Siasi come si vuole in ogni tempo uscirono da essa famiglia, segnalatissime
persone tanto nelle armi come nelle lettere .
AEDES CASTORUM - AEDES CASTORIS et POLLUCI o TEMPIO dei DIOSCURI
Il culto dei Dioscuri
nel Lazio è molto antico, come
ha rivelato il ritrovamento di una lamina a Lavinio
con dedica a Castore e Polluce.
lo stile fortemente grecizzante del reperto ha fatto supporre che il culto fosse
arrivato da una città della Magna Grecia,
probabilmente Taranto. Come in Grecia,
i due fratelli erano protettori dei cavalieri, che a quell'epoca erano composti
dalla sola aristocrazia.Fu sempre legato alla classe degli equites e probabilmente
dal tempio partiva la tradizionale parata degli equites (transvectio
equitum), istituita da Quinto Fabio Massimo
Rulliano nel 304 a.C. e che si teneva ogni anno il 15 luglio, anniversario
della battaglia. Le fonti citano che a Roma
un Tempio dedicato ai Dioscuri,
Venne promesso in voto dal dittatore Aulo Postumio Albo Regillense
nel 499 o 496 a.C. in seguito all'apparizione dei Dioscuri, che avevano
abbeverato i loro cavalli presso la fonte di
Giuturna dopo la battaglia del lago
Regillo. Venne dedicato nel 484 a.C. dal figlio di Postumio, nominato
duoviro per sovraintendere alla sua erezione. Situato nella zona del Circo
Flaminio, probabilmente collocato tra questo e la riva del Tevere:
in questa zona infatti, presso la chiesa di San
Tommaso ai Cenci, vennero ritrovate le due
statue dei Dioscuri attualmente collocate sulla balaustra
della piazza del Campidoglio.A
partire dal 160 a.C. fu adoperato come luogo di riunione del Senato e nello
stesso periodo davanti al tempio venne istituito un importante tribunale. Per
tutto il I secolo a.C. ebbe una funzione più di edificio pubblico, legato
alla vita politica, che di edificio religioso. Negli ambienti
aperti nel podio erano conservati i pesi e le misure ufficiali e alcuni di essi
erano utilizzati come "banche" o depositi. A causa dello stretto
spazio disponibile ebbe una pianta con cella disposta trasversalmente (come
il tempio di
Veiove sul Campidoglio
e il tempio della Concordia
nel Foro Romano). Secondo le ipotesi degli studiosi il tempio potrebbe
essere datato tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. e la sua costruzione
essere forse attribuibile a Quinto Cecilio Metello
Pio, dopo il suo trionfo sulla Spagna
(71 a.C.): questa attribuzione sembrerebbe confermata dallo stile delle statue
attualmente conservate sul Campidoglio.
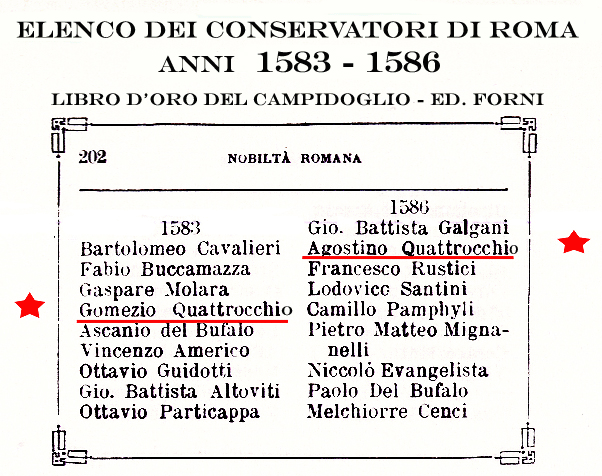
Tratto dall'elenco degli antichi Conservatori: 1561- Luca Peto, Giacomo Staglia, Marsilio Cafani, Papirio Quattrocchio.
STORIA DEGLI SCAVI DI ROMA E NOTIZIE INTORNO LE COLLEZIONI ROMANE DI ANTICHITA'
Rodolfo Lanciani - 1903
Nel 1583, seduta dell'8 marzo decretum est pro
perfectione palatii Capitolini et ornamento statuarum perficiendo capessendas
esse duas figuras marmoreas per dnum Vincentium Stampam et alteram per dnum
Hieronimum Picum
oblatas . Si propone una Commissione per esaminare e riferire. Ambedue questi
personaggi sono noti come appassionati collettori o negozianti di opere d'arte,
e di antiche iscrizioni. Nel terzo trimestre dello stesso anno i conservatori
Quattrocchio, del Bufalo
e Americi collocarono in museo capitolino colosseas
protomes Traiani et Antonini Pii (Forcella, 77). Pare che in questi ultirni
anni di Gregorio XIII si fosse manifestata tra
i gentiluomini romani la stessa epidemia del vendere ad ogni costo, della quale
abbiamo avuto tanti altri casi nei tempi nostri. II Comune di Roma, non sapendo
a quale santo rivolgersi, prende un provvedimento alia moderna, il piu inefficace
fra tutti: nomina doe (20 giugno 1583) una Commissione d'inchiesta composta
di Tommaso Cavalieri, Andrea Velli, Girolamo Paparone, Paolo Fabi, e Pier Tedallini,
raccomandando loro quod statuas et marmoreas figuras magci dfii Octavij Capranica
et aliarum particularium personarum vendere volentium videant, perspiciant,
et considerent . Della Commissione e del suo operate non si trova altra traccia
nei documenti del tempo. Nella seduta seguente del 19 dicembre 1584 Ottavio
Fornicini, anche a nome di Orazio Bongiovanni e Angelo del Bufalo, propone che
sia condotto a termine il restauro del Castore e del Polluce, in capo alia Cordonata,
restauro sospeso da qualche tempo per mancanza di fondi. Propone sopperirvi
coi proventi dell'affitto del protonotariato di Eipa. La proposta e approvata
nel Consiglio pubblico del 20. Tutto ciò dimostra che le iscrizioni Forcella,
tomo 1, p. 42, n. 78, incise nei piedistalli dei Dioscuri, non dicono il vero,
o pinttosto dicono che i Conservatori Quattrocchio,
del Bufalo e Americi
fabbricarono quei posamenti nel 1583, ma non vi misero sopra i colossi. Molto
piu che ho trovato nelle carte del notaio Gerolamo Arconio (A. S. C. IV, tomo
104, c. 161) l'atto ufficiale di consegna di uno delli Giganti cioè di
Castore e Polluce in cima della scala del foro del Camp. a. M Gio : Ant : Valsoldi,
fatto il 12 d'agosto 1594, perche egli lo restaurasse al prezzo pattuito di
scudi 450. Pure nel 1584 fu collocata sulla balaustrata della piazza columnam
milliariam primi ab urbe lapidis indicem (Forcella, n. 81-82). Le serviva di
piedistallo l'ara di Adriano C1L. VI, n. 967 a, sui fianchi della quale furouo
due volte incisi i nomi dei consiglieri Magarozzi, Gualtieri e Capocci. A costoro
si deve anche 1'acquisto e il trasferimento della statua di Baccante (Forcella,
n. 83), che ora si trova sulla sinistra del vestibolo del palazzo. Nel seguente
anno 1585 i Conservatori domandarono al card. Guastavillani, camerlengo, il
permesso di scavare dalla parte del clivo capitolino in cerca di materiali.
Nota.: Le sigle A. S- significano Archivio di Stato - A. S. C. Archivio Storico Capitolino - A. S. V. Archivio Segreto Vaticano A. S. R. S. P. Archivio della Società Romana di Storia Patria - CIL. Corpus Inscriptionum Latinarum.
Il debito pubblico del Campidoglio: finanza comunale e circolazione dei ...di Francesco Colzi - 1999
... 5 M' 1597 Piccolomini Erasmo Silverio abate 4 D 1644 Profana Elisabetta 10 -1 B 1629 Quattrocchi Felice 1 V 1593 Pierleoni Mario 3 G 1609 Quattrocchi.
MEMBRI DEL SENATO DELLA ROMA PONTIFICIA Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d’oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX)
FONDAZIONE MARCO BESSO Claudio De Dominicis
CONSERVATORI
s.d. - Serie Cronologica de Consoli di Roma creati doppo li Re’ di Roma.
- (Cred. IV, to. 130).
1583-1/4 - Gomesio [Gomezio] Quattrocchio di S.
Angelo, Ascanio del Bufalo di Colonna, Vincenzio Americi della Regola - (Cred.
I, to. 28, c. 161v)
1586-1/1 - Avv.to Giovanni Battista Galgani di Campo Marzo,
Agostino Quattrocchio di Ripa, Francesco Rustici di S. Eustachio (tennero
anche il senatorato) - (Cred. I, to. 29, c. 14).
CAPORIONI e PRIORI s.d. - Nota distinta
del circuito de’ Rioni di Roma. - (Cred. VII, to. 1, c. 104)
1543-1/1 - Ludovico Valentini de Monti, Santi Vitelleschi di Trevi, Aurelio
Ruffini di Colonna, [... di Campo Marzo], Pietro Quattrocchio
di Ponte, Adriano Paluzzelli di Parione, Valerio Santacroce della Regola, Giacomo
Jacovacci di S. Eustachio priore, Camillo Leni di Pigna, Pietro Pier Mattei
di Campitelli, Giovanni Filippo Serlupi di S. Angelo, Adriano Velli di Ripa,
Stefano Velli di Trastevere - (Cred. I, to. 3, c. 51).
1558-1/1 - Marcello Alberini de Monti, Vincenzio Calvi di Trevi, Alessandro
Crescenzi di Colonna priore, Giulio Staglia di Campo Marzo, Papirio
Quattrocchio di Ponte, Fulvio Amodei di Parione, Giacomo Santacroce della
Regola, Curzio Toscanella di S. Eustachio, Gregorio Subattari di Pigna, Francesco
Paparoni di Campitelli, Ascanio Mattuzzij di S. Angelo, Giacomo Ciamponi di
Ripa, Muzio Farinacci di Trastevere - (Cred. I, to. 20, c. 156v).
1559-1/4 - Giovanni Battista Salviati de Monti, Antonio Mattei di Trevi, Giuliano
del Forno di Colonna, Domenico Jacovacci di Campo Marzo, Gomesio
Quattrocchio di Ponte, Andrea Velli di Parione, Alessandro Giovenali
della Regola, Ludovico Lante di S. Eustachio, Orazio Muti di Pigna, Francesco
Paparoni di Campitelli, Vincenzio della Vetera di S. Angelo, Ottavio Teuli di
Ripa, Aurelio Mattei di Trastevere priore - (Cred. I, to. 3, c. 82; Cred. I,
to. 20, c. 184v).
1561-1/10 - Antonio Macarozzi de Monti, Gondisalvo Alveri di Trevi, Cola Jacovacci
di Colonna, Pietro Soderini di Campo Marzo, Papirio Quattrocchio
di Ponte, Silvestro Pichi di Parione, Paolo Incoronati della Regola, Ascanio
Caffarelli di S. Eustachio priore, Patrizio Patrizij di Pigna, Giacomo de Rossi
di Campitelli, Vincenzio Bonatti di S. Angelo, Francesco Paparoni di Ripa, Camillo
della Cetera di Trastevere - (Cred. I, to. 21, c. 122v).
1563-1/10 - Camillo Contreras de Monti, Alessandro Vitelleschi di Trevi, Giacomo
Maria Pallavicini di Colonna, Paolo della Riccia di Campo Marzio, Paolo Lancellotti
di Ponte, Fabrizio Massimi di Parione, Ranuccio Ranucci della Regola, Ascanio
Caffarelli di S. Eustachio priore, Paolo Binzoni di Pigna, Giacomo de Rossi
di Campitelli, Papirio Quattrocchio di S. Angelo,
Camillo Pignanelli di Ripa, Pompeo Ruggieri di Trastevere - (Cred. I, to. 22,
c. 17v).
1567-1/10 - Sebastiano Bolognini de Monti, Ottavio Muti di Trevi, Antonino Cioci
di Colonna, Alessandro Grandi di Campo Marzo, Pietro Antonio Bandini di Ponte,
Giovanni Lomellini di Parione, Fabio Sergardi della Regola, Ascanio Caffarelli
di S. Eustachio priore, Enea Gabrielli di Pigna, Marco Curzio Siconcelli di
Campitelli, Gomesio Quattrocchio di S. Angelo,
Silvio Velli di Ripa, Giovanni Giacomo Coleine di Trastevere - (Cred. I, to.
23, c. 80).
1570-1/4 - Domenico Ruffi de Monti, Rutilio Pini di Trevi, Valerio Antracini
di Colonna, Fausto Ventura di Campo Marzo, Bernardino Mazzei di Ponte, Vincenzio
Boccabella di Parione, Camillo Mancini della Regola, Domizio de Cavalieri [di
S. Eustachio] priore, Gregorio Subattari di Pigna, Mario Fani di Campitelli,
Agostino Quattrocchio di S. Angelo, Alessandro
Ridolfi di Ripa, Bernardino Mattei di Trastevere - (Cred. I, to. 24, c. 180v).
1580-1/4 - Bartolomeo Bonsi de Monti, Marco Antonio Vitelleschi di Trevi, Papirio
Sordi di Colonna, Alessandro Cardelli di Campo Marzo, Fabrizio Ferri di Ponte,
Eleno Mangoni di Parione, Giulio Pamfilij della Regola, Roberto Roberti di S.
Eustachio, Cesare Muti di Pigna, Giovanni Battista Gottifredi di Campitelli,
Gomesio Quattrocchio di S. Angelo, Biagio Capisucchi
di Ripa priore, Agostino Colacci di Trastevere - (Cred. I, to. 28, c. 30v).
1582-1/10 - Vincenzio della Fonte de Monti, Ortenzio Vitelleschi di Trevi, Rutilio
Pini di Colonna, Alfonso Soderini di Campo Marzo priore, Francesco Mazzei di
Ponte, Antonio Tronsarelli di Parione, Giulio Cambij della Regola, Alessio Alessij
di S. Eustachio, Lorenzo Altieri di Pigna, Pietro Margani di Campitelli, Agostino
Quattrocchio di S. Angelo, Lorenzo Peti di Ripa, Cosmo Stefanelli di
Trastevere - (Cred. I, to. 28, c. 124v).
LISTA D’ORO DELLA MAGISTRATURA CAPITOLINA
Dopo il cognome, tra parentesi, gli anni estremi nei quali è presente
nella Magistratura capitolina (conservatori e priori dei caporioni). Vengono
trascritte anche le forme diverse nelle quali il cognome si può trovare
ed i rimandi (v.) alle forme miste con altri cognomi. QUATTROCCHI
(1583-1586)
CRONOLOGIA DELLA LISTA D'ORO - QUATTROCCHIO
PIETRO 1543
QUATTROCCHIO
PAPIRIO 1558,
1561, 1563 .
QUATTROCCHIO GEMESIO
1559 GOMESIO
(Gomezio) 1567,
1580, 1583 -QUATTROCCHIO
GOMETIO (1583-1586)
QUATTROCCHIO AGOSTINO 1570,
1582, 1586 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verso la fine del Rinascimento
Roma rimaneva – nonostante alcune recenti innovazioni edilizie e
prestigiose costruzioni - sostanzialmente una città caotica d’aspetto
Medioevale. Proprio tra la seconda metà
del ’400 e il ‘500 si attua, grazie alla volontà di alcuni
pontefici e alla legislazione emanata per regolamentare i lavori pubblici, un
indirizzo politico teso a diminuire l'interesse di privati a favore di una maggiore
utilità pubblica.
MAESTRI DI STRADE E EDIFICI. A tale scopo si precisano
e sostanzialmente si rafforzano le funzioni dei Maestri delle strade e di edifici.
Questa magistratura era stata istituita dal comune capitolino in periodo medioevale
proprio per dirimere le questioni collegate al disordinato sviluppo urbanistico
di Roma, che avveniva senza regole ed era troppo
legato ad interessi privati. I Magistri sono già
attivi a Roma dai secoli XIII
e XIV. Il loro operato ci riporta ad una Roma
particolarmente caotica e litigiosa, dove si litiga spesso per problemi collegati
a confini, alle mura, agli scoli e ai deflussi delle acque. E così, in
quest'epoca, l'attività prevalente dei Magistri è proprio quella
di giudici nel dirimere tutte queste controversie. A ciò si aggiunge
anche una facoltà ispettiva sulla viabilità e nettezza urbana
di Roma. I pontefici comunque si appoggiano a questa magistratura, a cui progressivamente
verrà attribuito un ruolo decisivo nello sgombrare la città dall'invadenza
dell'abusivismo privato. La storia collegata alla politica urbanistica di Roma
è un intricato intreccio di provvedimenti pro e contro questi magistrati,
sia per porre rimedio alla inadempienza e negligenza spesso dimostrata nello
svolgimento dei loro incarichi, sia per questioni attinenti alle volere dei
pontefici. Il percorso lungo e travagliato iniziato all'epoca di Martino
V, si completa solo nel corso del '400 prima
con Niccolo V (1447-55) e poi con Sisto
IV (1471-1484) quando i Maestri di edifici e strade entrano definitivamente
a far parte dell'organigramma delle magistrature dipendenti dall' autorità
pontificia. In quanto tali gli vengono riconosciuti compiti e responsabilità,
e vengono dotati di strumenti idonei a perseguire la volontà pontificia.
AUDIO
Cronache e fioretti del monastero di San Sisto all'Appia - di Raimondo Spiazzi - 1994
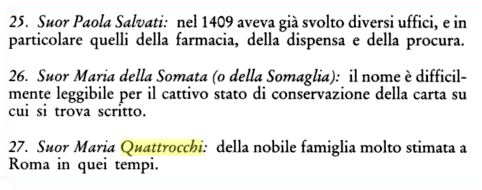
Anno 1409 - Suor Maria Quattrocchi: della nobile famiglia molto stimata a Roma in quei tempi.
DOMENICANE: INDICE DELLE FAMIGLIE - ROMA
I 656
stemmi qui riprodotti riguardano i Casati
delle religiose del monastero dei Ss. Domenico e Sisto
(Roma) che, per decreto di Papa Onorio III, per
esservi ammesse, dovevano appartenere alla nobilta' romana o, eccezionalmente,
a quella forestiera.
QUATTROCCHI CON STEMMA-ROMA
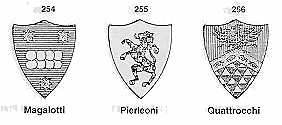
ARCHIVIO STORICO ARALDICO ITALIANO
Cognome QUATTROCCHIO
Dimora principale: Possedimenti vari - Titolo nobiliare: Nobile - Conti
Palatini - Cavalieri Aurati
Fonti bibliografiche: Archivi St Arald
Cognome QUATTROCCHI
Dimora principale: Con piu' dimore - Fonti bibliografiche: Albo D'Oro Nob. It.
Parentele LI DESTRI - Parentele PATERNO'
Fonti bibliografiche: Archivio FaRom - Titolo nobiliare: Nobile - Conti Palatini
Quattrocchi Nobili
Laziale
Quattrocchi Nobili Piemontesi
Archivio di Società romana di storia patria - 1920
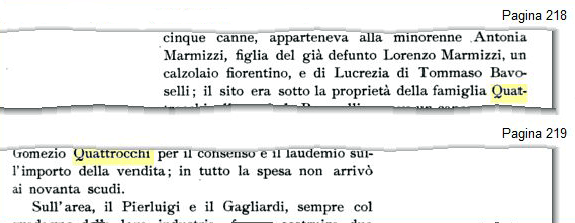
PARTE 1------------------------------------------------------------PARTE 2
PARTE 3--------------------------------------------------------------PARTE 4
INSULA QUATTROCCHIO
DA PIAZZA FARNESE - A CAMPO DE' FIORI
DOVE ERA SITUATA L'ANTICA FARMACIA QUATTROCCHIO
"PALAZZO FUSCONI-PIGHINI"OGGI"DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE"

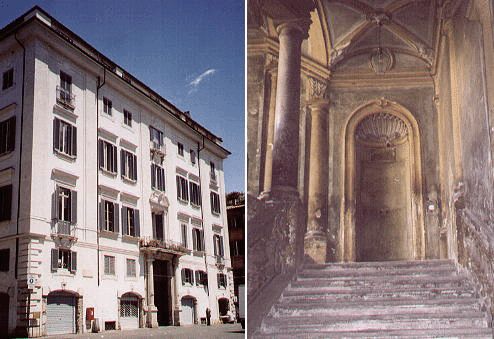
L'attuale Palazzo fu ceduto dai Quattrocchio verso l'anno 1520-21 ad Ugo de Spina. Baldassare Peruzzi fu incaricato della renovatio dell'insula Quattrocchio in un palazzo che completò verso il 1525-27 quando era già di proprietà di Francesco Fusconi di Norcia, archiatra di Clemente VII e Paolo III; passò nel 1554 al nipote Mons. Adriano Fusconi Vescovo di Aquino, morto nel 1579 e da questi ai suoi nipoti Pighini. Dai Pighini passò ai marchesi Sparapani di Camerino. Alla fine del '700 apparteneva al monatero di S. Cosimato che fu soppresso nel 1810 dal governo francese e venduto nel 1811 all'asta. Fu allora acquistato dal marchese Curti Lepri. Nel 1872 passò in proprietà della marchesa Giulia del Gallo di Roccagiovine e appartiene tuttora (anno 1984) alla famiglia. La famiglia Quattrocchio sembra aver lasciato Roma per Viterbo nel periodo 1525-1529.
BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II
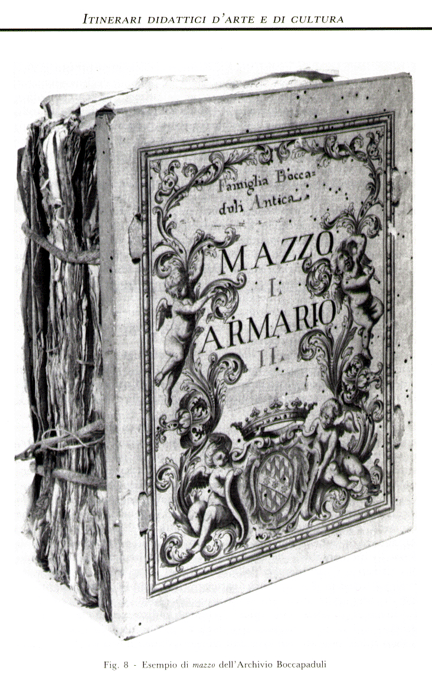
OPERA DI BICCI UBALDO
"NOTIZIE STORICHE
DELLA FAMIGLIA BOCCAPADULI NOBILE ROMANA"
--Anno 1372 - Domenica di Carnevale Festa dei tori in sfilata dal Campidoglio a Piazza Navona con 13 carri trionfali trainati da tori. fra i 10 giocatori a cavallo per ogni Rione si riporta "il figlio di menico 4 ochi del Rione Ponte". Alla festa hanno partecipato 32mila persone ben selezionate e ben vestite. ----------------------------------------------------------------- --Anno 1536 - 21 maggio - Testamenti che riguardano il matrimonio di Prospero Boccapaduli ed Ersilia Leni, e insieme l'intero pagamento della dote promessa: "specialiter et expresse quandam domum sitam Roma in Contrada della Vacca regionibus Parionis cui ab uno latere est ospitium sive taberna della Vacca, ab alio bona illorum de Quattrocchio ante est Via Publicola ved si qui." traduzione: "nello specifico ed immediato circa la casa situata in Roma - Contrada della Vacca - Rione Parione - a un lato della quale si trova la "Taverna o Locanda della Vacca" e all'altro lato le proprietà di Quattrocchio , di fronte c'è Via in Publicolis".
Der Buon Governo des
Pompeo Ruggieri.
Die Fresken von Cherubino und Giovanni Alberti im Palazzo Ruggieri
in Rom Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der
Philosophie der Philosophischen Fakultäten der Universität des Saarlandes
vorgelegt von Susanne Hoppe M.A. aus Mannheim Saarbrücken, 2015
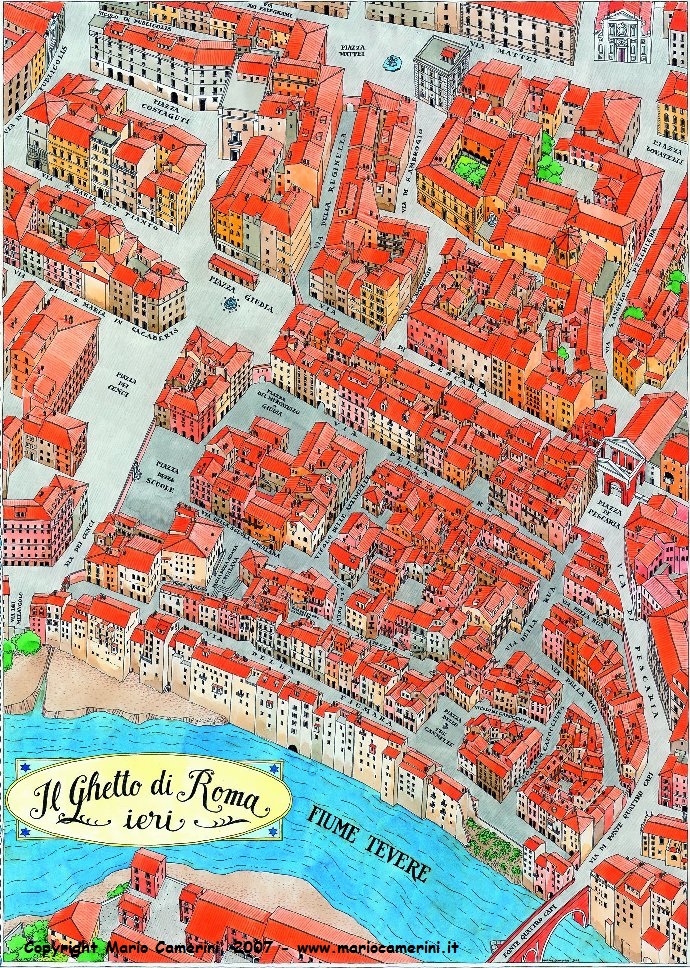


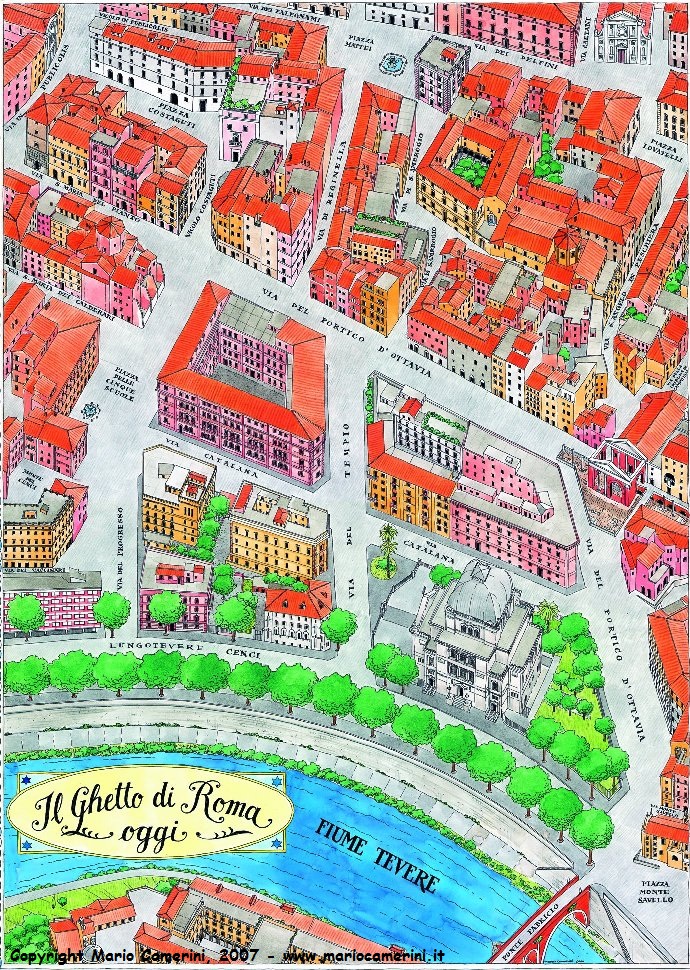
Diese Beobachtungen lassen sich auf die Dekoration der Sala dei Mesi des Palazzo Costaguti (Abb. 151-152) übertragen, der wenige Jahre vor den Fresken des Palazzo Ruggieri entstanden sein muss.(nota 392).
392 Über den Palazzo Costaguti erstmals ausführlich: Luigi Lotti, I Costaguti e il loro Palazzo di Piazza Mattei in Roma, Rom 1961. Der Autor schreibt die hier besprochenen Fresken Taddeo Zuccari zu und datiert sie aufgrund dessen Todesdatum vor 1566. Zuletzt wurden die Fresken der Sala dei Mesi von Cappelletti Antonio Tempesta und seiner Werkstatt in Zusammenarbeit mit Mathijs Brill zugeschrieben und in die zweite Hälfte der 70er Jahre datiert, s. Francesca Cappelletti, Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580–1630, Rom 2005–2006, S. 18f; Dies., Roma 1580–1610. Una traccia per il contributo fiammingo alle origini del paesaggio, in: Silvia Danesi Squarzina (Hrsg.), Natura morta, pittura di paesaggio e il collezionismo a Roma nella prima metà del seicento. Italia, Fiandre, Olanda il terreno di elaborazione dei generi, Città di Castello 1996, S. 177-200, hier S. 183f. Der Palazzo war ab 1581 im Besitz der Quattrocchi, gelangte ab 1598 in den Besitz der Patrizi und erst 1624 in den der Costaguti. Stilistische Merkmale und dekorative Details, wie beispielsweise ein mit Edelsteinen besetzter Lambrequin über den Monaten Februar, Mai und November, an dem kleine Glaskugeln befestigt sind, die wie im Palazzo Ruggieri Schlagschatten an die Wand werfen, verweisen auf eine Entstehungszeit in den 80er Jahre des 16. Jahrhunderts, d.h. in eine Zeit, in der der Palazzo den Quattrocchi gehörte. Auch Guerrieri Borsoi hält eine Datierung in diese Zeit für wahrscheinlich. Für die Figuren schlägt die Autorin Baldassarre Croce als verantwortlichen Künstler vor, s. Guerrieri Borsoi 2000 b, S. 86, hier auch der Verweis auf weitere Literatur.
Traduzione: Queste osservazioni portano alla decorazione della Sala dei Mesi di Palazzo Costaguti ( fig . 151-152 ), che doveva essere fatta alcuni anni prima gli affreschi del Palazzo Ruggieri muss. (nota 392)
392 Forse per la prima volta Palazzo Costaguti nel dettaglio: Luigi Lotti, I Costaguti e il Loro Palazzo di Piazza Mattei in Roma, Roma, 1961. Le scritture dell'autore sui discussi affreschi di Taddeo Zuccari e datato a loro perché data la sua morte prima di 1566. Ultima Sala dei Mesi degli affreschi di Cappelletti Antonio Tempesta erano e suo laboratorio attribuito in cooperazione con Mathijs Brill e nella seconda metà degli anni '70 datata, Francesca Cappelletti nella monografia "Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630", Roma 2005-2006, p 18f. Roma 1580-1610. Una traccia per il contributo fiammingo alle origini del paesaggio, in: Silvia Danesi Squarzina (Hrsg.), Natura morta, pittura di paesaggio e il collezionismo a Roma nella prima metà del seicento. Italia, Fiandre, Olanda il terreno di elaborazione dei generi, Città di Castello 1996,, pp 177-200, qui p 183f. Il Palazzo era dal 1581 di proprietà di Quattrocchio è venuto dal 1598 in possesso di Patrizi e prima nel 1624 di Costaguti. Stilemi e dettagli decorativi, come un gioiello.Lambrequin sono fissati nei mesi di febbraio, maggio e novembre nelle piccole sfere di vetro, come in Palazzo Ruggieri, a gettare ombre sul muro, fa riferimento a una origine negli anni 80 del 16 ° secolo, che è il momento in cui il Palazzo apparteneva ai Quattrocchio. Guerrieri Borsoi ritiene che un incontro di questo periodo è probabile. Per le figure, l'autore propone come Baldassarre Croce artisti responsabili prima, s. Guerrieri Borsoi 2000b, p 86, anche qui il riferimento ad altra documentazione.
Palazzo Quattrocchio Patrizi Costaguti 1581-98 Roma Affresco Cavalier d'Arpino
video
Giovane con Canestra di Frutta di Caravaggio 1593-94
Caravaggio raccontato da Federico Zeri
ARCHIVIO della Reale Società Romana di Storia Patria Volume XLIV.MARGHERITA ALDOBRANDESCA E I CAETANI
Il Palestrina e il suo commercio
di Pelliccerie : La vedova Marmizzi aveva cominciato
a costruire dei muri per erigervi una casa; ma non bastandole il danaro per
continuare la fabbrica, determinò di rivendere il tutto. Lo stesso giorno
17 aprile 1589, nel quale il Pierluigi estinse il censo con la Pasquali -Rosari
e creò quello in favore di sua moglie, i due soci procedettero all'acquisto
del terreno (2), pagato quindici scudi, e delle ventotto canne di muro già
fabbricato, valutate. È noto che i Borghi Nuovi,
Sant'Angelo, Pio, Vittorio e Angelico corrono e correvano paralleli da Castel
Sant'Angelo al Vaticano; il corridoio seguiva
il borgo S. Angelo, le mura urbiche costeggiavano quello Angelico : il terreno
era forse situato in una delle vie attraversanti questi borghi. (2) Atti Compagni,
prot. 583 a ce. 463-69. I consensi dei confinanti e del Quattrocchio
furono stabiliti negli atti 20, 21 aprile e 7 giugno 1589; la misura
e la stima dei muri furono fatte — da Lucantonio Ricari — il 29 maggio.
Altri cinquantadue scudi : i confinanti, per i muri in comune, ebbero altri
venti scudi ed uno scudo ebbe Gomezio Quattrocchio
per il consenso e il laudemio sull'importo della vendita; in tutto la spesa
non arrivò ai novanta scudi. Sull'area, il Pierluigi e il Gagliardi,
sempre col guadagno della loro industria, fecero costruire due case, spendendovi
in tutto circa 1210 scudi e ricavandone ventisei scudi annui di affitto. Questo
affare pare risvegliasse le simpatie del Gagliardi verso la vedova Marmizzi,
perché qualche anno dopo, nel 1592, essi si sposarono (2); e il matrimonio
non ebbe davvero scopo di lucro, perché la Lucrezia non portò
in dote che 175 scudi, compreso il ricavato della vendita del terreno!
REPERTORIO DEI NOTARI ROMANI DAL 1348 AL 1927 Elenco di Achille Francois a cura di ROMINA DE VIZIO
De Pugnatoribus Hieronymus 1526
De Pusinis Paulus 1470
De Quarantottis Thomas 1568
De Quattrocchis Rocchinus Petrus 1523-1555
De Quattrocchis Petrus, et Sergasperis Michael 1523-1544
De Quintiliis Johannes Baptista senior 1509-1532
De Quintiliis Jo.Baptista junior 1586-1596
Riccobonus Jacobus Antonius 1569-1575
Ridulphus Georgeus 1501-1536
Rigotius Johannes 1577
Robertus Caesareus 1545-1559
Rocca Ludovicus 1540
Rocchinus Petrus alias de Quattrocchis 1523-1555
Rochus Alexander 1614-1626
Rogier Antonius 1522-1524
Collegio de' Notari Capitolini:
Notaio Pietro Rocchino alias Quattrocchio negli anni 1523-1525 (usava il Simbolo della Fenice)
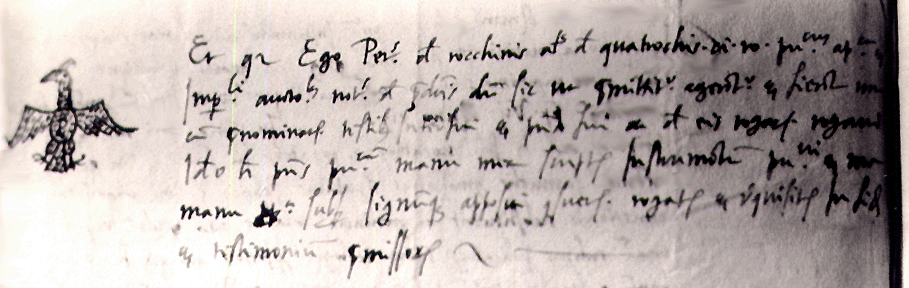
Atti del Notaio Pietro Quattrocchio negli anni 1529-1555 (usava il Simbolo della Fontana)
Atto di nomina degli Eredi di Pietro Quattrocchio anno 1557
Notaio Gaspare Raisdettus
Studi di Paleografia Diplomatica
Storia e Araldica (saggi) 241 L 915
Si trova il nome di Valeriano Quattrocchio
1659-1660.
Studi di Paleografia Diplomatica Storia e Araldica - (saggi) 241 LE 914
Anno 1554 – Renzo Quattrocchio (Bianca) aveva la casa, in Rione Ponte, al n. 6 di quella che e' attualmente Via del Banco di S. Spirito, di fronte a Palazzo Strozzi.
27 marzo 1563. I registri camerali contengono nota di scudi 237 spesi per acconciare la strada da Castello Sant'Angelo al Belvedere. - Scudi 16 a B. Tagliacozzo per saldo del fosso dietro la cortina di Borgo Pio. Si e messo a fare la fossa et nettare sotto il ponte dove passa l'Acqua della Sposata dietro alle case de Quatrochi. (storia degli scavi di Roma e notizie di collezioni romane di antichità di Rodolfo Lanciani - pag.64 - Quattrocchi)
- Achivio capitolino: 5 luglio 1567 - accordo per un terreno fuori Porta Castella tra Laurentio e Martia de Quattrocchij e Papirio, Gometio e Giustino (o Agostino) anche loro de Quattrochij. (Notaro Curtius Saccoccius)
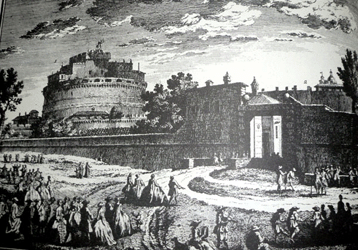
stampa: Porta Castella (scomparsa)
CASTEL SANT'ANGELO.
Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità di Rodolfo Amedeo Lanciani, Leonello Malvezzi Campeggi, Carlo Buzzetti, Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Italy), Paolo Liverani - 2002
Pagina 84 - Palazzo Quattrocchi in Borgo 3, 72 Palazzo Radici (Pietro) in Borgo 3,51 Palazzo Ronconi (Cola) in rione Ponte 2, 51 Palazzo Rondinini al....

Il Gregorovius, nei Diari Romani, racconta l’episodio
dell’incontro (1355) tra il re di Boemia Carlo IV e il Papa proprio presso
la Chiesa di Santa Maria Maddalena, e sempre qui avevano sostato in precedenza
Enrico III (1046), Enrico IV (1084), Enrico V (1111), Federico I Barbarossa
(1155), Federico II con la moglie Costanza d’Aragona (1220). E’ comunque
certo che la piccola chiesetta sconosciuta a molti romani, fu una sosta obbligatoria
per i potenti della terra che venivano a Roma o per rendere omaggio al Pontefice
o per esservi incoronati Imperatori del Sacro Romano Impero. Qui venivano accolti
dai Cardinali, qui in questa chiesetta doveva fermarsi per indossare gli abiti
pontificali un papa che fosse stato eletto fuori Roma.
Anzi va ricordato il solenne giuramento al popolo di Roma che
gli Imperatori rendevano in prossimità del Borgo, precisamente prima
di passare il ponticello sul Fosso della Sposata ( doveva trovarsi all’incirca
dove è oggi il Mercato dei Fiori) che proveniva dalla Valle dell’Inferno
ed andava a gettarsi nel Tevere all’altezza di Ponte Cavour. Era a Borgo
San Lazzaro che il Pontefice, o un Suo Legato, andava incontro al “Potente”.
Qui dovevano fare atto di sottomissione al Pontefice, da qui partivano per andare
in San Pietro.
- Anno 1583 - Domenico Quattrocchio de Quattordio de Monferrato - speziale - coniugato con una Altoviti - aveva possedimenti presso Porta S.Giovanni verso S.Croce in Gerusalemme. Possedeva vari locali di spezie vicino al Pantheon, una fabbrica di candele in zona Banchi e il diritto di riscuotere i dazi sulle carni. (Archivio Segreto del Vaticano).
ARCHIVIO DI STATO DI ROMA - FORCELLA: ISCRIZIONI DELLE CHIESE DI ROMA
Quattrocchio
Giacomo - vol. 5 - pag. 182 - n. 512
Quattrocchio Gometio - vol. 1 - pag. 41 n. 77 -
pag. 42 n. 78 - vol. 5 - pag. 182 n. 512
Quattrocchio Pietro - vol. 5 - pag. 182 - n. 512
Quattrocchio Papirio - vol. 5 - pag. 182 - n. 512
- vol. 7 - pag. 210 - n. 434
Quattrocchio Virginia - vol. 7 - pag. 210 - n.434
Quattrocchio Lucrezia - vol. 7 - pag. 210 - n.434
Quattrocchio Alessandro - vol. 7 - pag. 210 - n.434
Quattrocchio Consalvo - vol. 7 - pag. 210 - n.434
Quattrocchio Agostino - vol. 5 - pag. 182 - n.512
- vol. 7 - pg. 210 - n.434 - pag. 240 - n.490 - vol. 9 - pag. 137 - n.273
Quattrocchio Flaminio - vol. 7 - pag. 210 - n.
434 - pag. 240 - n. 490 - vol. 9 - pag. 137 - n.273 - vol. 10 - pag. 219 - n.342
Quattrocchio Nicola Antonio - vol. 7 - pag. 240
- n.490
DONAZIONI DI FLAMINIO QUATTROCCHIO
Anno 1648 – Eredita' di Flaminio Quattrocchio – Fascicolo di suppliche bollo, pagamenti ed altro relativo all’Ufficio Collettoria del Piombo, di Cubiculario Apostolico e di Scudifero.
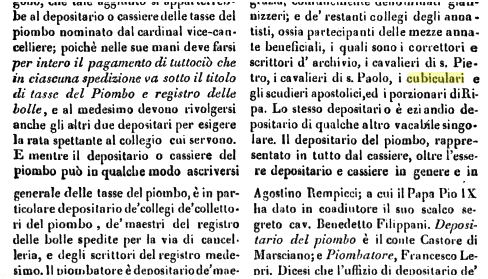
BOLLA DI NOMINA DI FLAMINIO QUATTROCCHIO
Flaminio Consalvo Quattrocchio - Nominato in S. Maria Maggiore "Referendario e Reggente di Cancelleria e Canonico di San Pietro Cubiculario Apostolico e Votante di Segnatura" da Papa Urbano VIII nel settembre dell'anno 1633. Atti del Notaio Giovanni Francesco Rosolino, cancelliere apostolico. Aveva gia' ricoperto la carica di "Scudifero".
TRADUZIONE DELLA BOLLA DI NOMINA A FLAMINIO CONSALVO QUATTROCCHIO
CUBICULARIO DI PAPA URBANO VIII
Angelo Andosilla referendario nell'una e nell'altra "Signatura del Santissimo Signore nostro il Papa e nella Cancelleria signore, giudice ed esecutore al posto dell'eminentissimo e reverendissimo signore cardinale Francesco Barberini Diacono di San Lorenzo in Damaso chiamato Sire Vice Cancellario, deputato in modo speciale dalla sede apostolica alle cose infradette ai venerabili e considerati uomini, signori Cubiculari apostolici secondo il numero dei partecipanti e a loro collegio ed ai difensori di questo e a tutti e a ciascuno degli altri ai quali interessa ,interessera' o possa interessare e che l'infradetta carica tocca e possa toccare in futuro a qualsiasi titolo siano valutati o di qualsiasi dignita' rifulgano, salute nel Signore. Ci (giungono) per parte del venerabile e considerato uomo, signor Flaminio Consalvo Quattrocchio, chierico romano e viterbense principale nominato nelle medesime lettere apostoliche, le lettere apostoliche del Santissimo in Cristo, Padre e Signore nostro per divina provvidenza Urbano VIII, con sue vere bolle plumbee: una e' una "littera gratiosa" con cordicella di seta di colore rosso e giallo, l'altra e' una "littera executoria" con cordicella di canapa pendente secondo il costume della Curia,(..) bollate, sane ed integre, non viziate, non cancellate ne' in alcuna parte sospette e mancanti di ogni vizio e sospetto. Noi con la dovuta reverenza abbiamo ricevuto e conservato tali lettere di tal contenuto: Urbano, Vescovo servo dei servi di Dio, al diletto figlio Flaminio Consalvo Quattrocchio, chierico romano e viterbense, cubiculario apostolico, nostro servitore, salute ed apostolica benedizione. I lodevoli meriti di probita' e virtu' riguardo ai quali,per testimonianza degna di fede, sei raccomandato presso di noi, ci inducono a trattarti con speciale simpatia e favore. Quindi la carica di cubiculariato apostolico, secondo il numero dei partecipanti, che il tuo Orazio Manilino cubiculario apostolico, secondo il detto numero, ricopriva, essendo stata vacante ed essendo attualmente vacante per la morte del detto Orazio, volendo trattarti con benevolo favore, in considerazione dei tuoi meriti premessi e da qualsiasi scomunica,sospensione ed interdetto e da altre sentenze ecclesiastiche, censure e pene (ricevute) dal diritto o dagli uomini in qualsiasi occasione o per qualsiasi causa, tuttavia se in qualunque modo sei coinvolto in queste cose per raggiungere la realizzazione delle cose presenti, assolvendoti e decretando che sarai assolto, ti concediamo ed assegniamo, per autorita' apostolica, la predetta carica, attualmente vacante, con tutti e ciascuno dei suoi onori, impegni, compensi e profitti consueti e ti sostituiamo e nominiamo al posto del detto Orazio per quel che riguarda la carica predetta, nonche' ti aggreghiamo favorevolmente al numero ed al consorzio degli altri diletti figli cubiculari apostolici secondo il detto numero, deliberando che tu, a partire da adesso, dovrai e devi essere ricevuto ed ammesso e sei ricevuto ed ammesso a tale carica nonche' agli onori, impegni, compensi e profitti predetti al posto del detto Orazio e che a te si risponda integralmente degli emolumenti predetti. Non opponendosi disposizioni ed ordini apostolici ed altre qualsivoglia cose contrarie. A nessuno, dunque, in generale, sia lecito infrangere questa pagina di nostra assoluzione, concessione, assegnazione, aggregazione e decreto o opporsi ad essa con temerario atto di audacia. Se tuttavia qualcuno, presumesse di attentare cio', consideri che andra' incontro all'indignazione di Dio onnipotente e dei beati Pietro e Paolo suoi apostoli. Dato a Roma, presso S. Maria Maggiore, l'anno dell'incarnazione del Signore 1633, il 1° settembre, undicesimo anno del nostro Pontificato.Urbano Vescovo servo dei servi di Dio al diletto figlio maestro Angelo Andosilla, nell'una e nell'altra signatura referendario, salute ed apostolica benedizione. Oggi al diletto figlio Flaminio Consalvo Quattrocchio, chierico romano e viterbense, cubiculario e servitore nostro, abbiamo concesso ed assegnato, per decreto apostolico, la carica di cubiculariato apostolico, secondo il numero dei partecipanti, in questo momento in modo certo e chiaro vacante, con tutti e ciascuno dei suoi onori, impegni, compensi e profitti consueti, come nelle nostre lettere redatte, e' contenuto in modo piu' completo. Di conseguenza, tenendo tu nella Cancelleria apostolica il posto del nostro diletto figlio il Cardinale Francesco Barberini, diacono di S. Lorenzo in Damaso, chiamato Sire Vice Cancellario, diamo incarico alla tua discrezione, per mezzo di scritti apostolici che e se dopo che le dette lettere ti siano state presentate, tu faccia per mezzo tuo o di altro, o di altri, per nostro decreto che il detto Flaminio o il suo procuratore a suo nome, sia ammesso a detta carica, nonche' agli onori, impegni, compensi e profitti predetti, secondo il contenuto ed il tenore del nostro decreto apposto in queste lettere, come e' usanza e che a lui si risponda integralmente riguardo agli emolumenti predetti, reprimendo coloro che si oppongono al nostro predetto decreto, con la dichiarazione che segue. Non opponendosi tutte quelle cose che nelle dette lettere, vogliamo non opporsi o se c'e' da parte della Sede apostolica una concessione ai diletti figli ed al Collegio dei cubiculari apostolici secondo tale numero o per chiunque altro insieme o separatamente, non possa essere interdetto, sospeso o scomunicato per mezzo di lettere apostoliche che non facciano piena ed espressa menzione, parola per parola, di tale concessione. Dato a Roma presso S. Maria Maggiore, l'anno dell'incarnazione del Signore 1633 - 1° settembre - XI anno del nostro pontificato. Dopo la presentazione ed accettazione di queste lettere apostoliche preinserite,fatte da noi e per mezzo nostro,come e' premesso,ci e' stato richiesto con dovuta saldezza, a difesa della parte del detto signor Flaminio, principale nominato nelle lettere apostoliche preinserite,di voler procedere alla esecuzione delle preinserite lettere apostoliche e del loro contenuto,secondo la forma a noi trasmessa e diretta per mezzo di esse dalla sede apostolica. Noi dunque Angelo Andosilla giudice ed esecutore predetto, ponendo bene attenzione che tale richiesta sara' giusta e consona alla decisione e volendo che l'ordine apostolico in questa parte a noi diretta,sia eseguita rispettosamente,come siamo tenuti,per questo motivo con l'autorita' apostolica concessaci e per la quale sorgiamo in questa parte,le predette lettere apostoliche e questo nostro procedimento e tutte le cose in essa contenute,a voi tutti sopradetti ai quali il nostro procedimento e' diretto ,insieme o separatamente, annunciamo e facciamo conoscere ,vogliamo che sia portato a conoscenza vostra e di chiunque di voi per mezzo delle presenti mantenga in solido ed ammoniamo in modo perentorio, insieme o divisi, ed ordiniamo che, immediatamente, presa visione ed accettate le presenti (lettere), accettiate ed ammettiate e facciate che sia accettato ed ammesso lo stesso signore Flaminio principale o il suo legittimo procuratore a suo nome, alla carica predetta ed al libero esercizio della sua carica, nonche' agli onori, impegni, compensi e profitti predetti al posto del detto Orazio e che rispondiate a lui riguardo ai profitti di tale carica, per quanto vi riguarda,insieme o separatamente e facciate che sia rispettata integralmente da altri quanto e' o sia stato globalmente deciso. E se per caso non disporrete di adempiere inflessibilmente a tutte e ciascuna cosa premessa, per quanto riguarda a voi e chiunque di voi in solido e se non obbedirete agli ordini ed ammonizioni e a tali nostri "brevi " apostolici, noi realmente e ufficialmente (siamo) contro voi tutti e singoli che vi sarete resi colpevoli delle cose premesse e generalmente contro qualsiasi oppositore e contro i ribelli e chi di per se' impedisce gli onori, l'aiuto, il consiglio o favore, pubblicamente o nascostamente, in modo diretto o indiretto, con qualsivoglia straordinario motivo o congettura e di qualsiasi dignita' , grazia, grado siano, da ora come da allora, contro, individualmente, contro i singoli, per il canonico avvertimento premesso del quale diamo notizia in questi scritti e senza dubbio promulghiamo le predette lettere apostoliche e questo nostro procedimento e vogliamo che le singole competenze di carica rimangano presso il detto signore principale e che non sia in qualunque modo ostacolato per mezzo vostro o di alcuno di voi o di qualsiasi altro o di altri, per forza o contro la sua volonta' e vogliamo che coloro che fanno il contrario ricadano, immediatamente, nelle nostre predette sentenze.come in questi scritti sono promulgate per mezzo nostro e riserviamo a noi comunque e solamente ad un nostro superiore l'assoluzione di tutti coloro che siano incorsi nelle nostre predette sentenze o in qualcuna di esse. A riprova e testimonianza di tutte queste e singole cose premesse abbiamo ordinato che le presenti lettere e questo presente pubblico documento del procedimento sia poi fatto e per mezzo del notaio infrascritto, sottoscritto e pubblicato e munito del peso del nostro sigillo che e' usato in tali occasioni. Dato e fatto a Roma, nella Cancelleria apostolica, nell'anno dell'incarnazione del Signore 1633, indizione prima, giorno (..) del mese di ottobre, XI anno del Pontificato del Santissimo Cristo Padre e Signore nostro, per divina provvidenza, Papa Urbano VIII, alla presenza dei rev.mi signori Muzio de (..) ed altri "abbreviatores maiores" delle medesime lettere apostoliche che presiedono, chiamati e richiesti come testi alle cose premesse. E queste cose, io Francesco Rosolino, notaio della Cancelleria apostolica, fui richiesto riguardo alle cose premesse, per questo ho sottoscritto e firmato il presente pubblico documento del procedimento.
Morto nel novembre 1645 Flaminio Consalvo Quattrocchio fu sepolto nella Chiesa della SS Trinita' dei Pellegrini davanti all'altare della Madonna. La Lapide per ordine testamentario doveva essere messa nel luogo di sepoltura. Al momento si trova nella parete destra della Sacrestia.
SS.TRINITA' DEI PELLEGRINI
TRADUZIONE DEI TESTAMENTI DI FLAMINIO QUATTROCCHIO

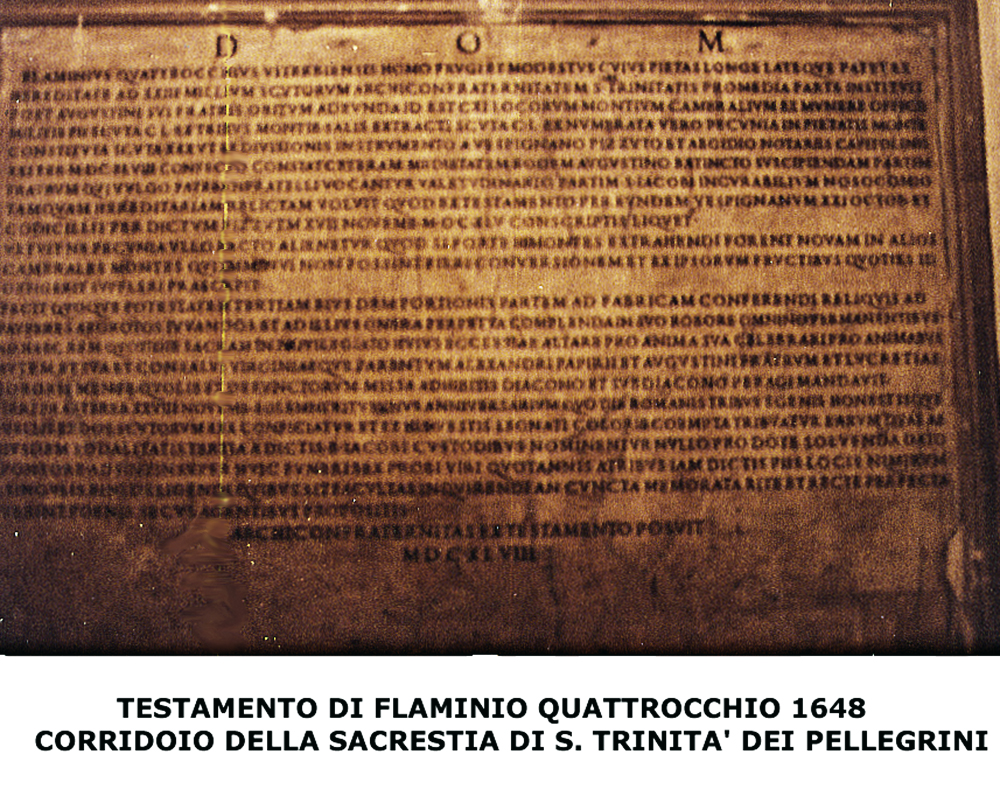

ALL’ARCICONFRATERNITA DI S. MARIA DELLA TRINITA’ DEI PELLEGRINI
AI FRATI DETTI "FATEBENEFRATELLI"
ALL'OSPEDALE SAN GIACOMO DEGLI INCURABILI
Flaminio Quattrocchio di Viterbo, di cui e' nota in ogni luogo la pia generosita', lascio' all’Arciconfraternita di S.Maria della Trinita' 23.000 scudi della sua eredita' cui aggiunse, dopo la morte del fratello Agostino, scudi 91, poi altri 90 che gli derivavano dai suoi incarichi militari ai monti camerali, poi altri 90 che gli derivavano dai monti del sale e altro, poi 30 in moneta corrente, come si puo' verificare dall’istrumento rogato da Vespignano ed Egizio Pizzuto, notai capitolini. L’altra meta' dell’eredita' del fratello Agostino la dono' ai frati detti Fatebenefratelli e all’ospedale di S. Giacomo degli incurabili, com'e' scritto nel suo testamento rogato dal Vespignano il 21 ottobre e dal codicillo rogato dal Pizzuto il 17 novembre 1645 in cui vengono indicate queste beneficenze. Di quei beni non frazionabili derivatigli dal reddito dei monti fece tre parti che destino' alla Fabbrica di Santa Maria della Trinita', ai poveri bisognosi e al soddisfacimento di obblighi perpetui che dovevano essere ottemperati perpetuamente e cioe' la celebrazione quotidiana di una messa per se' ad un altare privilegiato di quella chiesa e una messa mensile per l’anima di tutti i suoi defunti parenti. La cerimonia funebre fu celebrata in forma solenne il 28 novembre e nello stesso giorno furono elargiti a tre oneste e povere fanciulle una dote di 30 scudi, il beneficio del rimborso delle spese di culto dalla dote in favore del futuro marito per una, e per altre due la confezione di abiti di colore giallo dorato. Dei tre luoghi pii beneficiati, due hanno verificato gli adempimenti delle volonta' testamentarie. Come da testamento l’Arciconfraternita pose nell’anno 1648.
La Tomba di Flaminio era sita nell'Altare privilegiato della chiesa stessa.
Archivio di Stato di Roma - Le Chiese di Roma del Forcella
Nell'elenco dei Benefattori di SS. Trinita' dei Pellegrini e' riportato il Lascito di una Casa da Flaminio e Agostino Quattrocchio nell'anno 1641. Mentre Nicola Antonio Quattrocchio Dona 1 Luogo di Monte 622 scudi (Vincolato) nell'anno 1698.
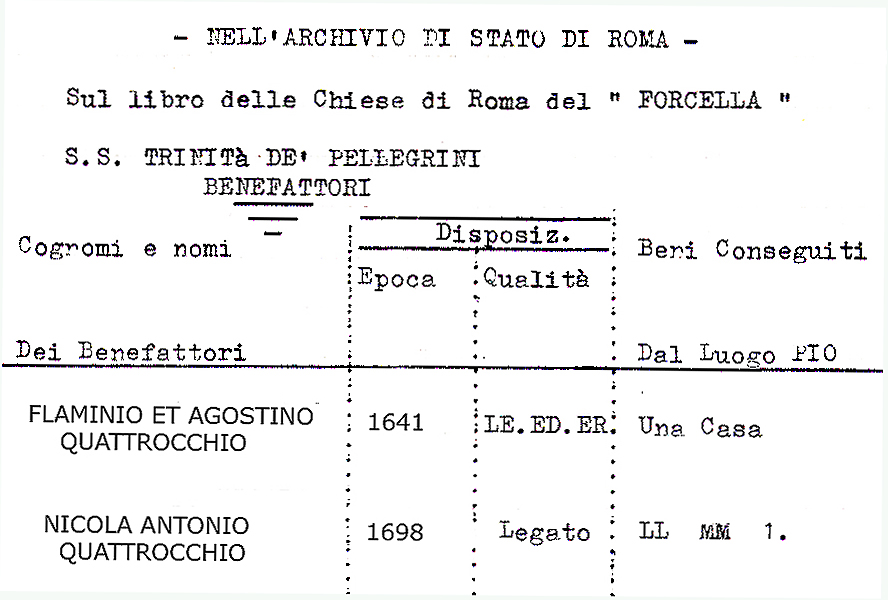

ISOLA TIBERINA - OSPEDALE FATEBENEFRATELLI


LE CHIESE DI ROMA
ILLUSTRATE - DI L. HUETTER
R.U. MONTINI - "SAN GIOVANNI CALIBITA"
La breve permanenza dei preti spagnoli nell'Isola si ricollega alle iscrizioni, ora nella cripta, di tre nobili conerranei: Annibale Moncalvi avvocato curiale, 1552; G.B. Lari e suo figlio Andrea, 1572 e 1578: Nello stesso sotterraneo, iscrizione del tempo delle monache: Annibale Balista de Notariis, ferrarese, "dux militum", 1569; altre più tarde di Flaminio Quattrocchio da Viterbo, Benefattore dell'Ospedale, 1645 e del portoghese Diego de Silva Caldeira, 1742, fratello di fr. Antonio Maria ex provinciale dei religiosi, il quale gli dedicò tale memoria, che oltre a vari legati pii istituì l'ospedale stesso erede universale delle sue sostanze.
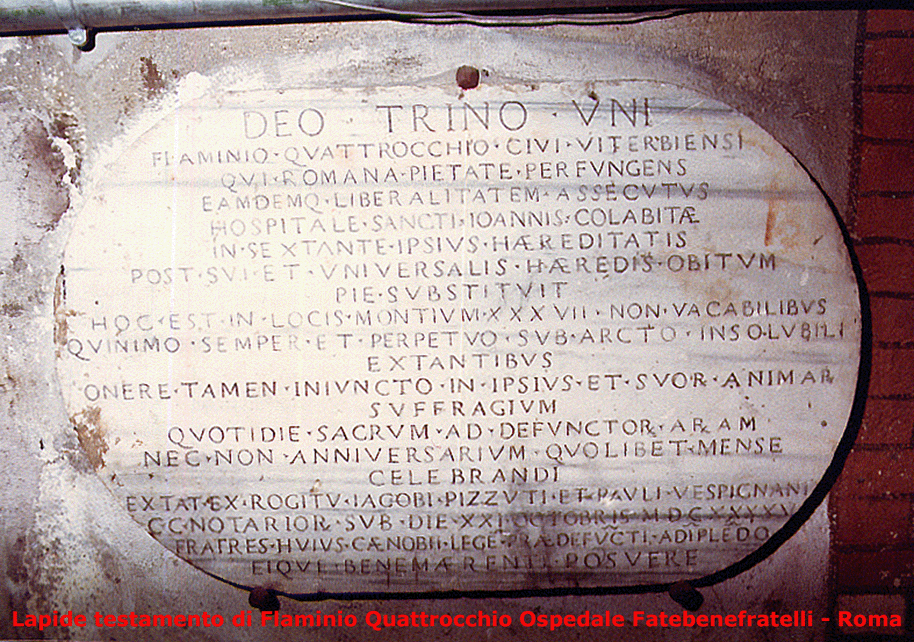
TRADUZIONE DELLA LAPIDE COMMEMORATIVA
OSPEDALE FATEBENEFRATELLI–SAN GIOVANNI CALIBITA DI ROMA
A FLAMINIO QUATTROCCHIO
CITTADINO DI VITERBO IL QUALE ADEMPIENDO PER DEVOZIONE ROMANA E PER SUA GENEROSITA’
PAREGGI0’ L’OSPEDALE DI SAN GIOVANNI CALIBITA CON LA SESTA PARTE
DELLA SUA EREDITA . DOPO LA MORTE SUA E DELL' EREDE UNIVERSALE LI FECE PROPRI
EREDI.QUESTO SI TROVA NEI 37 “LUOGHI DI MONTE” (*)
CHE RISULTANO NON LIBERABILI (VINCOLATI) SENZA CHE SEMPRE CON PERPETUO E CONGIUNTO
IMPEGNO DI SACRO SUFFRAGIO QUOTIDIANO PER L’ANIMA SUA E DEI SUOI, ALL’ALTARE
DEI DEFUNTI. DA CELEBRARE NON OGNI ANNO, NON DOVUNQUE, NE’ MENSILMENTE.
ESTRATTO DAL ROGITO DI GIACOMO PIZZUTO E PAOLO VESPIGNANO CO-NOTARI NEL GIORNO
21 OTTOBRE 1645. I FRATELLI DI QUESTO CENOBIO POSERO BENEMERITI, ISPIRATI
AI DIRITTI DEI DEFUNTI.”
(*) Il luogo di monte puo' essere paragonato al titolo di credito. Il valore potrebbe corrispondere a circa 622 scudi. Uno scudo d'oro ha il valore numismatico di mille euro. Riportato al costo della vita nel 1648 di 2000 euro

TABELLA VALORE MEDIO ANNUO DELLE ENTRATE DELLE DOGANE DEL XVII SECOLO
Dogana di Ripa - scudi 83.408,34
Dogana di Terra - scudi
85.789,70
Dogana Grascia -
scudi 150.340,38
Dogana di Ripetta
- scudi 8.481,01
Altre dogane - scudi
137.381,50
Totale entrate:
scudi 465.400,93


ARCHIVIO DI STATO DI ROMA - LIBRO DELLE CHIESE
DI ROMA DEL FORCELLA
S.GIACOMO DEGLI INCURABILI - SEC. XVII A. 1648
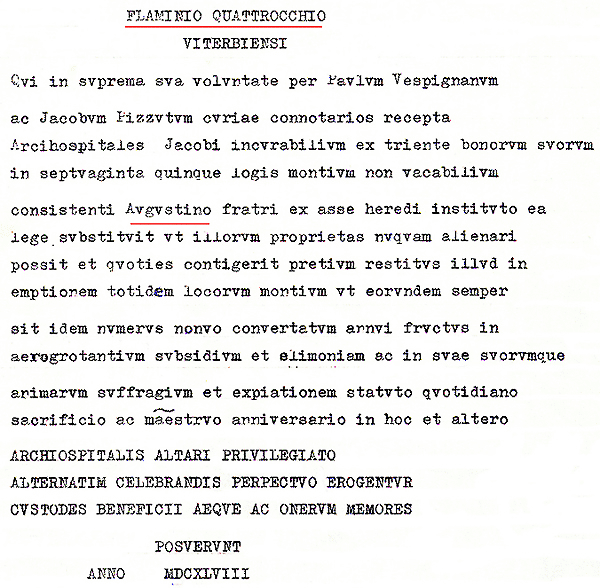
TRADUZIONE DELLA LAPIDE TESTAMENTARIA DI FLAMINIO QUATTROCCHIO OSPEDALE SAN GIACOMO DEGLI INCURABILI - ROMA - PAVIMENTO DELLA CAPPELLA DI S. GIACOMO
A FLAMINIO QUATTROCCHIO VITERBENSIS, IL QUALE, IN PIENO POSSESSO DELLE SUE FACOLTA', PER MEZZO DI GIACOMO PIZZUTO E PAOLO VESPIGNANO CO-NOTAI DELLA CURIA (PER PRESA VISIONE) SOSTITUI' IL FRATELLO AGOSTINO (MORTO) CON L'OSPEDALE DI SAN GIACOMO DEGLI INCURABILI NELL'ASSE EREDITARIO PER LA TERZA PARTE DEI SUOI BENI CONSISTENTI IN 75 LUOGHI DI MONTE (TITOLI DI CREDITO) AFFICHE' LA PROPRIETA' DI QUELLI (AGOSTINO) NON POSSA MAI ESSERE CEDUTA. E TANTO QUANTO TOCCASSE DI PREZZO (RENDITA) VENGA RESTITUITO IN ACQUISTO DI ALTRETTANTI LUOGHI DI MONTE AFFINCHE' LA NONA PARTE DELLA RENDITA ANNUA FOSSE CONVERTITA IN AIUTO E ASSISTENZA AGLI AMMALATI. IN SUFFRAGIO PER L'ANIMA SUA E DEI SUOI CON L'ESPIAZIONE DI UN SACRIFICIO QUOTIDIANO E UNA MESSA SOLENNE MENSILE CELEBRATA IN QUESTO E IN UN ALTRO ALTARE PRIVILEGIATO DI QUESTO OSPEDALE CHE DEVONO ESSERE CELEBRATI ALTERNATIVAMENTE IN PERPETUO. I CUSTODI DEL BENEFICIO EROGATO EQUAMENTE E MEMORI DELL'IMPEGNO POSERO NELL'ANNO 1648.
IL PAVIMENTO DELLA CAPPELLA DI S.GIACOMO E' STATO SMANTELLATO PER RESTAURO FRA IL 1943 E IL 1959.
NEL CORTILE DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELL'OSPEDALE S. GIACOMO - VIA A. CASANOVA - ESISTE UNA GROSSA LAPIDE COMMEMORATIVA CON LA QUALE SI ANNOVERA IL NOME DI FLAMINIO QUATTROCCHIO FRA I BENEFATTORI DELL'OSPEDALE.
Dall'archivio dell'Ospedale
S.Giacomo degli Incurabili
busta 226 - Domenico Quattrocchio de' Quattordio
de' Monferrato foglio 1: anni 1538-1607 - foglio 2: anni 1541-1574 -
foglio 3: anni 1554-1568
busta 227 - Flaminio Consalvo Quattrocchio foglio
1: anni 1619-1660.
Mons.Gaetano
Quattrocchi: Sacerdote per 29,4 anni un Vescovo per 7,3 anni
Vescovo Emerito di Mazara del Vallo Arcivescovo Titolare di Serra
16 giu 1850 Nato Mazarino
20 Dic 1873 23.5 Ordinato Sacerdote Sacerdote di Mazara del Vallo , Italia
11 Feb 1896 45.6 Designato Vescovo ausiliare di Mazara del Vallo , Italia
11 Feb 1896 45.6 Designato Vescovo titolare di Europus
16 Feb 1896 45.6 Ordinato vescovo Vescovo titolare di Europus
15 Giu 1900 49.9 Designato Vescovo di Mazara del Vallo , Italia
1 Apr 1903 52.7 Rassegnato Vescovo di Mazara del Vallo , Italia
1 Apr 1903 52.7 Designato Arcivescovo titolare di Serra
8 giu 1903 52,9 Morto Vescovo emerito di Mazara del Vallo , Italia
Arcivescovo Don. Gaetano Quattrocchi (nato 16 Giu 1850 È morto 8 giugno, 1903)
Mons.Can.co Don Vincenzo Quattrocchi, Cameriere Segreto di S.S.Pio X, Vicario Foraneo, fratello di Gaetano
Camerieri d'Onore in abito Paonazzo
del Santo Padre Pio XI:
9 febbraio 1925. Monsig. Alfonso Frattari, della diocesi La Piata.
11 febbraio 1925 Monsig. Egidio Quattrocchi, della
diocesi di Veroli.
Monsig. Pietro Quattrociocchi(Quattrocchi),
della medesima diocesi.
Monsig. Giuseppe Novelli, della medesima diocesi.
Quattrocchi Aegidius, 119.
Quattrocchi Petrus, 119,
Quattrocolo Henricus, 74-79, 81-83. Vinculi Defensor
S. Romana Bota
AMATESCHI - LA SOCIETA' ROMANA DALLA FEUDALITA' AL PATRIZIATO- 1816
Il Gregorovius dà il prospetto, ancora
insperato, delle maggiori famiglie intorno al 1500 dimoranti nei singoli rioni
di Roma. II prospetto del Gregorovius può bene essere trascritto per
il raffronto con l'elenco delle famiglie delle rinunce feudali, essendo l'uno
fonte e riferimento originario dell'altro.
"Intorno al 1500 le famiglie più illustri del rione Ponte erano
queste: Aczoti, Alexii, Andreozzi, Bartolomei, Bernabei, Bonadies, Bonaventura,
Cambii, Castelli, Cesarini, Capo de Ianni, Clodii, Lancellotti, Laurenti-Stati,
Lelli, Maffei, Martelli, Malglottii, Dello Mastro o De Magistris, Mercante,
Mosca, Nardi, Orsini, Parisii, Petroni, Pontani, Quattrocchio,
Sassi, Sanguigni, Lo Schiavo, Serruberti, Simeoni, Steccati, Surdi, Tebaldeschi,
Tocii, Tolomei, Vaiani."
Gli Studi in Italia: periodico
didattico, scientifico e letterario.Pubblicato da 1882: v. 5 (Jan.-June 1882).
Originale disponibile presso la la Biblioteca Pubblica di New York
...Nel Rione Ponte presso s. Andrea degli acquariatri
formicolavano le cortigiane che ambivano a frequentare le case dei nobili come
Boccapaduli, dei Mosca, dei Casali, dei Vannetti, dei Quattrocchi:
Il personaggio più importante era Fiammetta de Micaelis fiorentina di
nascita, svolge dal 1478 la sua professione a Roma, dove approda tredicenne,
con la madre anche lei meretrice, ed è l´amante en titre del cardinale
Jacopo Ammannati per un anno e mezzo. Il porporato, morendo nel 1479, la lascia
erede dei suoi beni nel testamento. Fiammetta riceve quattro proprietà
immobiliari. Una vigna con casino presso la Porta Viridaria del Vaticano; una
casa con torre nello scomparso vicolo della Palma, presso la chiesa dei Santi
Simone e Giuda, che oggi sorge sul vicolo di San Simone, una traversa di via
dei Coronari; una seconda casa in via dei Coronari 157 ancora esistente; e un
palazzetto con loggia ancora in piedi in via Acquasparta 16, ad angolo con la
piazza intitolata alla cortigiana. La fama di Fiammetta cresce con gli anni
e nel 1493 è l´amante en titre del cardinale Cesare Borgia.
INCONTRI NEL MEDIOEVO di Arsenio Frugoni
Quattrocchi, p. 300). ... avrebbe giurato, alla presenza di Bonifacio VIII, di aver partecipato al precedente Giubileo, parlano MA Flaminio (1498-1550) e ...
ARCHIVIO DELLA R. SOCIETA' ROMANA DI STORIA PATRIA
pag. 218 - Marmizzi, figlia del già defunto
Lorenzo Marmizzi, un calzolaio fiorentino, e di Lucrezia di Tommaso Bavoselli
: il sito era sotto la proprietà della famiglia Quattrocchi,
alla quale la Bavoselli pagava un canone annuo... I consensi dei confinanti
e del Quattrocchi furono stabiliti negli atti 20,
...
pag. 320 - Da un codice del secolo XIV, conservato nell'archivio Capitolare
della Basilica Vaticana il Signor D. Quattrocchi,
procustode dello stesso archivio, ha tratto il testo per una nuova edizione
dell'opera del Cardinal Jacopo Gaetano Stefaneschi sul Giubileo del 1300.
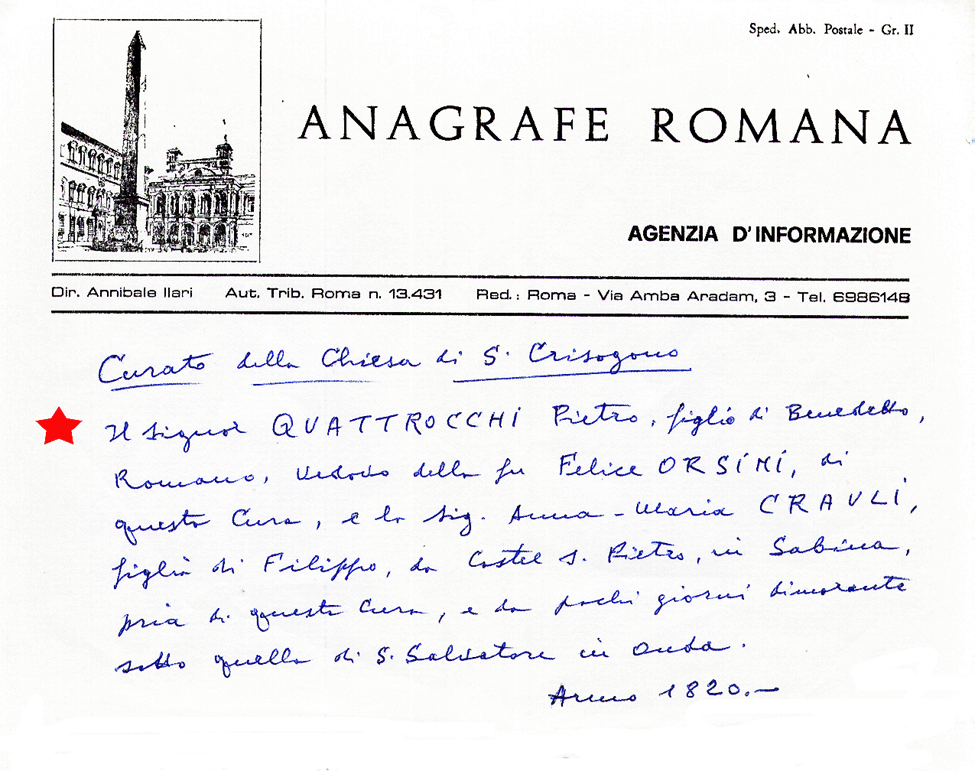
Quattrocchi Pietro, figlio di Benedetto Romano, vedovo della fu Felice Orsini, di questa curia, e la sig.ra Anna Maria Crauli, figlia di Filippo di Castel S. Pietro, in Sabina. Anno 1820 (notizia del Curato della chiesa di S. Crisogono). Forse e' un atto di matrimonio.
Quattrocchi Felice - figlio del fu Francesco e della fu Lucia. mori' il 2 gennaio 1811 e fu sepolto nella Parrocchia di San Lorenzo in Lucina.
Quattrocchi Anna Maria - figlia di Joacchino - moglie di Guglielmi Francesco - Sono i genitori di Guglielmi Gaspare.
Quattrocchi Sante - di Francesco Romano (Parrocchia di S. Marcello) - sposa la Signora Bufalini Elisabetta di Paolo Romano in San Lorenzo in Lucina. Anno 1807.
Quattrocchi Angelo - nato ad Alatri - figlio di Fortunato - ad anni 22, nel 1834, sposa Faraja Rosa figlia di Agostino Rosa, nata a Cascia.
Quattrocchi Giuliano - figlio di Giuseppe di Velletri, vedovo della fu Maria Rosati - sposa Gertrude Amici, figlia dell'illustrissimo Prospero Romano della curia di Santa Maria sopra Minerva. Anno 1807
Quattrocchi Stanislao - di Roma, ivi combattente nel 1849 - fascicolo 12921 del fondo militare Archivio di Stato di Torino.
DELLA PORTA E BASILICA DI S. LORENZO - DELLE CATACOMBE DI S. CIRIACA - DELLA BASILICA DI SANTA STEFANO - DELLE CATACOMBE DI S. IPPOLITO SOLDATO E DEL CAMPOSANTO DI ROMA - di Fabio Gori
IL CAMPOSANTO - Or facendo il giro delle pareti si rimarcano i sepolcri di Luigia Modelli De Angelis , Giuseppe De Angelis di Civitavechia , Niccola Pieri, del fanciullo Vincenzo Fasani, di Maria Dimario fidanzata a Piacentini, di Giacomo Poscelli, Marianna Tarnassi, Federico Bouruet (di stile bizantino), di Giuseppe Alciati di Velletri, Catarina Chialastri, delle famiglie Agostini Recchia e Adsenti, di Teresa Mattei, Simone Proferisce, di Elena Scarpini, di Maria Anna Adelaide Samat (col suo ritratto scolpito e con pittura, nella quale è dessa presentata alla Vergine ed al Bambino), Gian Battista Brancadoro, Pacifico Battistelli; del principe Casimiro Czetwertynski Komargrodi nato in Podolia e morto nella età di anni 34 nel 1839 (con bassorilievo indicante la Religione presso il busto del principe ed una donna afflitta allattante un pargolo e reggente colla manca un fanciullino , il quale mesto riguarda I' effigie di Casimiro) ; di Virginia figlia del marchese Gaetano Pizzardi bolognese, della virtuosa pittrice Fauslina Armellini a cui fu avo il chiaro scultore cav. Pietro Bràcci; del cav. Pietro Giuntotardi (nel bassorilievo alla Religione si presentano la Scienza e la Carità ) ; di Odoardo Anselmi ; di Domenico Mannucci e Chiara Salvi; della famiglia di Girolamo Salviati; del giovane studente di filosofia Filippo Sisco; di Antonio Garulli da Fermo, Maria Antonia Monti, Teresa Monarchi sposa di Michele Rossi Danielli da Viterbo, di Adelaide Scarafoni, del negoziante di lana e tela Carlo Francioni, di Francesca Bràcci, di Vincenzo Pacetti, del cav. Luigi Armellini scrittore vaticano e segretario del card. ministro dell'interno, del giovane scultore Luigi Vannutelli e famiglia, di d. Pietro Alessi filosofo teologo e professore di lingua ebraica defunto nel 1847, del viaggiatore spoletino Vincenzo Savi, della fam. Malfatti, di Napoleone Francesco Godard caporale nell'armata francese morto nel 1860, di Clementina Colonna, del fanciullino Alzemiro Rane, di Costanza de'conti Carradori, di Teresa Filippo ed Irene De Dominicis, della famiglia del cav. Marini, di Agostino Carini fanciullo, dello spagnolo D. Salvatore Borrell Margenat, di Francesco Sabbatini Quattrocchi, Carolina Sereni, Giacinta Gauttieri, Pietro Ranzi Ramolini, Domenico Montanari nativo di Fano procuratore di collegio, del giudice nella curia innocenziana avv. Giuseppe Tordi e di Palmira Manni.
VILLA QUATTROCCHI - VIA NOMENTANA
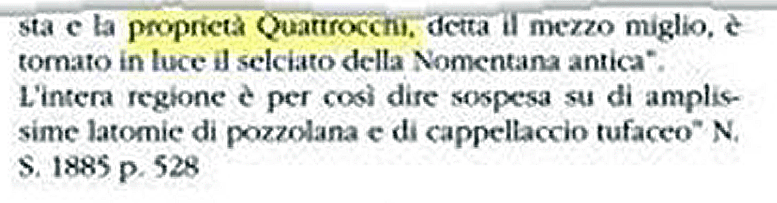
LA CAMPAGNA ROMANA: ANTICA,
MEDIOEVALE E MODERNA
di Giuseppe Tomassetti, Luisa Chiumenti, Fernando Bilancia, Francisco Tomassetti
Pagina 107 - Sulla via Nomentana, a mezzo miglio dalla porta, nella proprietà
Quattrocchi - confinante con la Villetta Torlonia
- è stata rinvenuta una epigrafe scritta su una lastra sepolcrale rettangolare
di marmo...

Di Giovanni Quattrocchi, proprietario della Villa dal 28 agosto 1884 all'8 aprile 1895, so solo che era figlio di Vincenzo, e che era "romano". Nel 1895 , quando il Protettorato di S.Giuseppe acquista formalmente Villa Quattrocchi, Giovanni Quattrocchi faceva parte del Consiglio di Amministrazione del Protettorato. Cosa che provocò l'annullamento della delibera e la necessità che Quattrocchi si dimettesse perchè il Consiglio potesse assumere una seconda delibera, valida.
Ringrazio il Signor Eugenio Sacco, studioso e ricercatore, per la gentile informazione su Villa Quattrocchi.
Opera pia Protettorato di S.Giuseppe
Il Protettorato di San Giuseppe, avente sede in Roma - via Nomentana, 341, trae la sua origine dalla fusione di due distinte istituzioni di assistenza e beneficenza disposta con regio decreto 2 dicembre 1909: il Protettorato di San Giuseppe e l'Opera pia nazionale. Il Protettorato di San Giuseppe nacque nel 1883 per iniziativa della signora Ledieu De La Ruadière, continuata poi dalla marchesa Cecilia Serlupi e da suor Maria Raffaella della Croce, coadiuvate da filantropi. L'istituto fu eretto in ente morale con regio decreto 31 dicembre 1893 e, con gli artt. 14 e 21 dello statuto organico 1 settembre 1893, alla prima fu conferita la carica di presidente a vita ed alla seconda la carica di direttrice a vita, ad entrambe con diritto di nominare il proprio successore. Il protettorato di San Giuseppe, dopo aver peregrinato in diverse abitazioni, per la necessità di allargarsi in proporzione del crescere dei ricoverati (via S. Stefano Rotondo, via Tasso), in seguito all'acquisto della villa Quattrocchi in via Nomentana, vi stabilì definitivamente la sua sede principale.
Giovanni Quattrocchi appare in una lapide sulla facciata del Palazzetto in Via Capolecase a pochi metri dalla Chiesa e cimitero di S. Giuseppe.
Almanacco romano, ossia Raccolta dei primari dignitari e funzionari - 1854
Eustacchio 15. Pomela Felice, Banco s. Spirito 4ó.
Putti Urbino, Quattrocchi Teresa, Campo Marzo 54.
id.in Lucina 27.
L'Archivio della Direzione
generale delle antichità e belle arti 1860-1890 di Italia.
Direzione generale per le antichità e belle arti, Matteo Musacchio, Archivio
centrale dello Stato - 1994
... Viterbo, 328 Frodo, Orvieto, 213 Promessi Sposi, del Cianfanelli, ... 529, 552 Quarto, Firenze, 729 Quatrini Nicola, 307 Quattrocchi Giovanni, stagnaro Palazzo dei Cesari.
Monumenta histórico-augustiniana de Iquitos Di Isacio R. Rodríguez, Jesús Alvarez Fernández
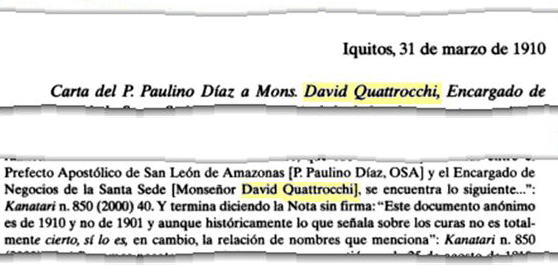
ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA
Direzione generale delle biblioteche e accademie, Italy Ufficio
centrale per i beni librari e gli istituti culturali - 1931
A pag. 160 troviamo: Cav. Arrigo Goffredo Quattrocchi,
Direzione Generale Accademie Biblioteche, Ministero Educazione Nazionale, Roma.
AIB - Associazione Italiana
Biblioteche
ARRIGO GOFFREDO QUATTROCCHI
(Carpineto Romano RM 12 gennaio 1890 - Roma 3 novembre
1945)
Laureato, dopo il servizio militare (1916-1919) entrò
nella carriera amministrativa del Ministero dell'educazione nazionale, come
vicesegretario, nel 1920. Lavorò presso la sezione che si occupava delle
biblioteche governative e passò alla Direzione generale delle accademie
e biblioteche alla sua costituzione, nel 1926, occupandosi soprattutto del personale.
Promosso caposezione al principio degli anni Trenta e ispettore superiore nel
1938, successe ad Apollonj, nel 1941, come direttore di una delle due divisioni
della Direzione generale. Nel febbraio 1944 venne arrestato, con altri funzionari
che non avevano accettato il trasferimento del Ministero a Padova, ma subito
rilasciato.
Poco prima della morte era passato alla Direzione generale degli affari generali,
amministrativi e del personale del Ministero. Socio
dell'Associazione italiana biblioteche probabilmente dal 1932, prese parte già
nel 1931 al suo primo Congresso nazionale e poi a quelli del 1932, 1937, 1938
e 1940. Collaborò inoltre alla Statistica delle pubblicazioni italiane
curata dall'AIB in quegli anni. Per qualche tempo fu forse socia anche la moglie
Maria, insegnante nella Scuola elementare "E. Pistelli" di Roma, che
partecipò col marito ai congressi del 1937, 1938 e 1940.
L'ITALIA FORESTALE E MONTANA - di Accademia Italiana di Scienze Forestali - 1963
Giovanni Quattrocchi nacque a Roma, da famiglia romana, il 9 ottobre 1908; si laureò in scienze agrarie presso l'Istituto Superiore di Perugia a 24 anni ...Tornato a Roma fu comandato presso l'Istituto centrale di Statistica ebbe modo di farsi apprezzare per l'inteligente lavoro e le publicazioni di studi statistici e forestali. Successivamente nel 1949 fu chiamato alla Direzione Generale delle foreste addetto al servizio sistemazioni idraulico-forestale dei bacini montani e poi capi divisione fino al 1956.
Gli sposi Beltrame Quattrocchi, un Magnificat della vita coniugale
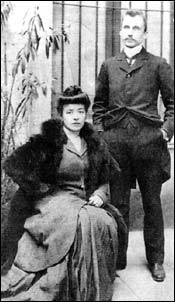
È la prima coppia dell’età moderna a essere
innalzata agli onori degli altari: modello, segno e profezia di una Chiesa protesa,
sotto la guida di Maria, alla santificazione di ogni famiglia cristiana. Non
hanno fondato Congregazioni. Non sono partiti missionari per terre lontane.
Semplicemente hanno vissuto il loro matrimonio come un cammino verso Dio, facendosi
santi. Il Papa li ha beatificati il 21 ottobre scorso, nel ventesimo anniversario
della Familiaris Consortio. In quell’occasione, per la prima volta nella
storia della Chiesa, abbiamo visto elevata alla gloria degli altari una coppia
di sposi, Luigi e Maria Luisa Beltrame Quattrocchi,
beati non "malgrado" il matrimonio, ma proprio in virtù di
esso. Luigi Beltrame Quattrocchi (Catania, 12 gennaio
1880 – Roma, 9 novembre 1951) e Maria Corsini (Firenze, 24 giugno 1884
– 26 agosto 1965) furono una coppia di sposi, proclamati beati dalla Chiesa
cattolica nel 2001. Luigi nasce a Catania il 12 gennaio 1880 da Carlo Beltrame
e Francesca Vita. Il doppio cognome viene aggiunto quando Luigi viene cresciuto
(e poi adottato) dagli zii Stefania e Luigi Quattrocchio.
Frequentato il ginnasio ad Ancona, si trasferisce a Roma, dove vive fino alla
morte, nella zona dell'Esquilino. Qui si laurea nel 1902 discutendo una tesi
in Diritto Penale su "L'errore di fatto nel Diritto penale" con relatore
Enrico Ferri. Nonostante l'impegno del lavoro e della famiglia, Luigi si prodiga
in un proficuo apostolato e prende parte all'associazionismo cattolico. Dal
1916 si impegna nello scautismo e coopera con l'Associazione Scautistica Cattolica
Italiana (ASCI), divenendo nel 1917 Presidente del riparto Roma V e nel 1918
membro del Commissariato Centrale. Nel 1919 fonda con l'amico Gaetano Pulvirenti
un oratorio festivo nella basilica di Santa Pudenziana, poi Reparto Scout Roma
XX, diretto da lui stesso fino al 1923. Nel 1921 viene nominato Consigliere
generale dell'ASCI fino al 1927. Collabora ancora con il Prof. Luigi Gedda nell'Azione
Cattolica Maschile e nei Comitati Civici, appoggia come consigliere amministrativo
il sorgere dell'Agenzia ORBIS; coadiuva con gli onorevoli Reggio d'Aci e Jacini
al Centro Studi Politici; opera nella GIAC, nel Movimento di Rinascita Cristiana
e nel Fronte della Famiglia. Dopo il matrimonio con Maria Corsini, la fede di
Luigi si ravviva: insieme vanno a Messa tutte le mattine e la loro giornata
è contrassegnata da momenti di preghiera in comune, come il Rosario serale.Lui,
amico di Don Sturzo e di De Gasperi, testimonia la sua fede nel laico ambiente
di lavoro; lei, scrittrice di libri educativi, è crocerossina durante
la guerra, inoltre realizza come catechista corsi per fidanzati, una novità
per l'epoca.Insieme partecipano all'attività di associazioni come il
Movimento di Rinascita Cristiana; collaborano anche all'attività dell'UNITALSI,
come barelliere lui e infermiera lei; diventano inoltre terziari francescani.
Maria Luisa Corsini nasce a Firenze il 24 giugno 1884; colta e sensibile,
incontra Luigi essendo il padre amico di famiglia dei Quattrocchi;
il matrimonio unisce i due giovani il 25 novembre 1905, nella basilica di Santa
Maria Maggiore a Roma.Trascorso qualche mese la sposina è in attesa del
primo figlio, che dà alla luce nel 1906. Battezzato con il nome di Filippo
sarà poi Don Tarcisio. Una seconda ravvicinata gravidanza si conclude
con la nascita, nel 1908, di Stefania, in seguito Suor Cecilia. Nel 1909 arriva
il terzogenito Cesare, poi monaco Benedettino e poi ancora monaco Trappista
con il nome di P. Paolino. Nel 1913 l'annuncio di una quarta gravidanza porta
una nuova grande gioia, che sfocerà con la nascita, il 6 aprile 1914,
di Enrichetta. Dopo un forte deperimento organico, Maria si riprende dimostrando
di possedere una ricchezza e profondità spirituali maggiori, che la porteranno
ad impegnarsi in una indefessa attività apostolica. Già nel 1914,
a seguito del terremoto di Avezzano, si prodiga nell'assistenza ai feriti. Nello
stesso anno inizia le catechesi alle donne presso la parrocchia di S. Vitale.
Nel 1915 soccorre moralmente e spiritualmente i soldati della Prima Guerra Mondiale
ricoverati nei diversi ospedali di Roma. Nel 1917 diventa Terziaria Francescana
e nel 1919 è accolta nella Congregazione delle Dame dell'Immacolata.Nel
1920 entra nelle file del Consiglio Centrale dell'Azione Cattolica Femminile
e diviene membro effettivo del Segretariato Centrale di Studio. Nel 1936 diviene
accompagnatrice dei malati sui treni dell'UNITALSI diretti a Lourdes e a Loreto.
Un anno dopo segue e termina un corso per infermiere della CRI e si specializza
in malattie tropicali. Nel 1945 collabora nell'opera di Ristoro alla Stazione
Termini e nel 1946-1947 aderisce all'iniziativa dei P. Lombardi e P. Rotondi
"Mondo Migliore". In questi stessi anni entra a far parte del Movimento
Fronte della Famiglia, del quale sarà Vice-Presidente del Comitato romano.
Altro campo d'azione è Rinascita Cristiana. Riguardo alla sua attività
di scrittrice, inizia con la pubblicazione nel 1920 di articoli su "Fiamma
viva", "Il Solco", "In Alto" e sul Bollettino della
FUCI. Dal 1922, anno in cui in casa Beltrame Quattrocchi si annunciano ben tre
vocazioni, Maria seguirà fino al suo ultimo respiro, con un vero sacerdozio
materno, la scelta di vita consacrata dei tre figli Filippo,
Cesare e Stefania. Dall'epistolario scambiato con loro, nel 1924 vede
la luce "Voce di Madre". Nel 1936 dà alle stampe "Il libro
della giovane" e nel 1937 compone un opuscolo dal titolo "I nostri
ammalati". Nel 1940 escono "Il fuoco ha da ardere" e "Mamma
vera". Nel 1943 scrive "Fiore che sboccia", con la collaborazione
del figlio P. Paolino. Nel 1952 nascono "Lux
vera" e "Vita coi figli". Nel 1953, ripercorrendo la vita in
comune trascorsa col marito Luigi, pubblica "L'ordito e la trama",
in seguito ristampato con il titolo "Radiografia di un matrimonio".
L'ultimo suo componimento è del 1955 "Rivalutiamo la vita".
Durante la guerra, Filippo, divenuto Don Tarcisio,
scampa il 13 agosto del 1942 al siluramento della nave dove è imbarcato
(Incrociatore Montecuccoli); il 13 agosto dell'anno successivo Cesare, cappellano
militare con il nome di Padre Paolino, sfugge ai colpi di un cecchino mentre
raccoglie le spoglie di un soldato caduto; nello stesso giorno Stefania, che
ha preso il nome di Madre Cecilia, esce dal convento poco prima che questo venga
colpito da un bombardamento. Luigi muore a Roma il 9 novembre 1951, il 26 agosto
1965 anche Maria muore, poco dopo aver recitato l'Angelus insieme ai figli.
Espressamente voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana, nasce nel 1999 la
Fondazione Luigi e Maria Beltrame
Quattrocchi, con lo scopo di promuovere la formazione
e l'evangelizzazione nel campo del matrimonio e della famiglia. La causa di
beatificazione di Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi
viene aperta il 25 novembre 1994, mentre il 21 ottobre 2001 Giovanni Paolo II
innalza la coppia agli onori degli altari. Il 28 ottobre 2001 i corpi dei coniugi
vengono trasferiti nella loro cripta presente nel Santuario della Madonna del
Divino Amore a Roma !!! Il miracolo che ha consentito la loro beatificazione
riguarda Gilberto Grossi, colpito da una malattia invalidante fino dall'età
di dieci anni; fra l'incredulità dei medici, nonostante la malattia rimanga
in tutta la sua gravità, conosce una completa remissione dei sintomi,
grazie all'intercessione dei Beati , e può realizzare il suo sogno: diviene
neurochirugo, si sposa e conduce una vita normale. La Chiesa ricorda i Beati
Luigi e Maria rispettivamente il 9 novembre e il 26 agosto, ed è
viva l'eco delle parole di Giovanni Paolo II: "Non
può più essere accettabile venga negato il giusto riconoscimento
alla santità silenziosa e normale di tanti padri e madri".

AUDIO
Tratto da "Calligrammi" Le Colline - Apollinaire - Inno a Roma
Interpretato da Paolo de Manincor - Musica Gilberto Quattrocchio (free download mp3)
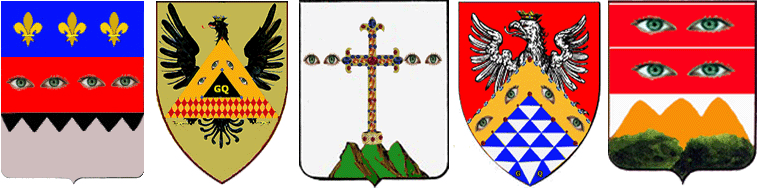
"Notizie degli Scavi
di Antichità" COMUNICATE ALLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI PER ORDINE
DI S.E.IL MINISTRO
DELLA PUBB. ISTRUZIONE 1895. S. Angelo in Capoccia, Oggi Sant'Angelo Romano
"Avanzi di una Villa Romana".
Regione I (Latium et Campania). Il sig. Pietro Cornacchia,
utilista del fondo detto Colle Lungo, proprietà del principe D. Francesco
Borghese, duca di Bomarzo, e gli altri vicini, nel fare lo scassato per le viti
si sono imbattuti in un complesso di avanzi antichi, che li ha invogliati a
continuare le ricerche. Si tratta senza dubbio di una villa signorile dei tempi
romani, come risulta chiaro dalla descrizione dei trovamenti. Dimore di questo
genere sembra che fossero assai frequenti in quei paraggi, ove l'amenità
del luogo e la vicinanza della capitale erano condizioni favorevoli ad attrarre
i ricchi a villeggiare ('). Era già nota la villa Maria sopra un altro
poggio a poca distanza dalla collina di Sant'Angelo, luogo che con assai probabilità
è identificato colla città latina di Medullia.
E invero le colline di Sant'Angelo, e di Monte
Celio hanno tutti i caratteri adatti per lo stabilimento di una città
antichissima, e alcuni avanzi di mura poligonali, che sono situati sulle pendici,
confermano questa ipotesi. Nel punto più elevato di Colle
Lungo, che è un poggio a dolce pendio, il quale si allunga a sud-ovest
di Sant'Angelo, adibito in gran parte ad uso di vigna, esistono gli avanzi di
una grandiosa costruzione in mura reticolate di piccoli pezzi di travertino
connessi con calce. Si riconoscono delle stanze di un palazzo con pavimenti
di musaico bianco e nero, di lavoro accurato, ma con ornati semplici di figure
geometriche. Alcuni ambienti verso ovest e verso sud, sono rivestiti da intonaco
idraulico solito ad usarsi nelle cisterne : una piccola vasca rettangolare di
simile costruzione, ha una scaletta per discendervi ; presso a questa si veggono
le tracce di un grande muro semicircolare, aperto verso ovest, del quale non
è ben chiaro l'uso, se appartenga cioè alle terme e sia l'avanzo
di una grande vasca. In altri ambienti, ora ricoperti dal terreno, sono state
rinvenute in gran numero anfore e dolii ; erano le cellae che confermano la
destinazione a villa del complesso degli edifici. Nel centro di tali costruzioni
era una sala abbastanza ampia, rivolta verso sud e allungata verso nord, con
una o più nicchie od absidi. Essa era forse la galleria o il museo del
palazzo, perchè quivi sono state rinvenute in maggior numero le antichità.
Vi abbondano i frammenti di incrostazioni di marmi orientali, le terrecotte
decorative e non mancano tracce d'intonaco dipinto sulle pareti. Nel mezzo di
quella che potrebbe essere la nicchia centrale, è stata rinvenuta una
statua togata. Nell'angolo nord-ovest si raccolse una testa di adulto sbarbato
del I secolo dell'impero, e nelle vicinanze altri frammenti di statue che non
si completano (un piede e parte del corpo d'un cerbiatto, un frammento di statuetta
di Diana ed altri frammenti). Nei dintorni esistono due capitelli dorici in
travertino dall'echino quasi piano, rozzamente lavorati. Tutto mostra adunque
che questo era il luogo più nobile e ricco dell' edificio. Circa l'epoca
cui rimontano tali fabbriche e circa il proprietario di esse, abbiamo alcuni
indizi nelle iscrizioni e nello stile delle sculture. Queste sono opere un po'
decorative, ma di lavoro abbastanza buono, del tempo dei Claudii. Nella vigna
Quattrocchi, confinante a nord con quella
del Cornacchia, è stato rinvenuto un cippo di travertino o stele piramidata,
arrotondato un poco al di sopra, dell'altezza originaria di un uomo, oggi ridotto
alla sua sola estremità superiore (larghezza m. 0,45, alt. 0,40) colla
seguente iscrizione in caratteri (a. 0,045) di forma rozza, ma dell'epoca suddetta:
TI CLAV AVG L lALYSO EXCEPTO IVGERO IN PRONTE PC SIC IN AGRO P CL Le dimensioni
vaste dell'area indicata, farebbero supporre il cippo che si riferisca ai confini
del fondo, anziché ad un sepolcro. E forse ci dà il nome del proprietario
della villa, che era un Liberto di Claudio. Ai
tempi di quest'ultimo è noto quale potenza avessero acquistata i liberti
imperiali ; e non disdirebbero la sontuosità della villa e la statua
togata ad un simile personaggio. I bolli de' mattoni sono tutti rettangolari.
Il primo, noto per altri esemplari (cfr. C. I. L. XV, n. 2378) dice: L ALLIDI
il secondo, pure conosciuto, ed in forma meno incompleta (ib. n. 2390) reca:
NOM il terzo mostra chiaramente : C CORINE t. Si b il quarto finalmente dice:
L SCANI poir. Sono stati puro rinvenuti alcuni pezzi di fistulae aquariae, (è
una conduttura idrica solitamente in piombo, ma anche, più raramente,
in terracotta. Era usata già nell'antica Roma,) ma non ho potuto constatare
se avessero iscrizioni, essendo stati squagliati. In mezzo agli avanzi di questa
villa sono stati riconosciuti moltissimi sepolcri. Da quel poco che resta ancora
visibile non ho potuto acquistare un'idea chiara, se questi appartenessero ad
una necropoli distinta o fossero i sepolcri dei servi della villa, benché
quest'ultima mi sembri l' ipotesi più probabile. Nessun oggetto della
suppellettile è stato conservato: mi si disse che questa consisteva in
vasetti ed in lucerne. Le tombe nella vigna Cornacchia sono a piccola profondità,
formate da tegoloni appoggiati a tetto sul cadavere. Nella vigna a nord è
stato invece rinvenuto un grande ossario, senza caratteristica di epoca alcuna,
e forse non è che il cimitero dei tempi posteriori. (') Nibby, Analisi
II, p. 309.
L. Mariani.

Sant'Angelo Romano (fino al 1885 denominato Sant'Angelo in Capoccia)
Sorge sul Monte Patulo (400 metri s.l.m.) e prese il nome attuale in onore di San Michele Arcangelo. Nel territorio comunale nasce il Pratolungo, piccolo affluente dell'Aniene. STORIA : Nel 1174 a.C. il paese risulta menzionato, chiamato all'epoca Medullia dagli antichi Romani che in seguito lo conquistarono. Sulla cima più alta sorgeva un'antica fortezza romana forse adibita anche a prigione. Con la caduta dell'impero romano divenne rifugio per molti abitanti delle ville romane vicine. Successivamente dalle ceneri della fortezza, nacque la rocca già nell'XI secolo circondata di cinta muraria. Essa prima appartenne ai Capoccia e poi agli Orsini che ne fecero un castello fortificato. Nel 1594 il feudo venne acquistato dai Cesi, e fu in questo periodo che conobbe il suo periodo di massimo splendore. Nel 1612 Papa Paolo V ne fece un Principato con a capo Federico Cesi (1585-1630), fondatore nel 1603 della celebre Accademia dei Lincei, la più antica d'Italia con sede nella Capitale. Nel 1678 il castello con tutto il feudo venne ceduto ai Borghese sempre come principato. Nel 1886 il paese assunse il nome attuale abolendo il precedente Sant'Angelo in Capoccia (dato in precedenza in onore della famiglia che aveva preso possesso del castello, i capocci) con Regio Decreto n° 3150 del 28 maggio 1885. Nel 1989 il comune acquistò il castello e nel 1993 iniziarono i restauri e le ristrutturazioni per l'apertura al pubblico. I Santi patroni sono San Michele e Santa Liberata. La chiesa di Santa Liberata. Questa chiesa è del XIV secolo, distante all'epoca della fondazione di trovava a circa 500 metri dell'abitato, ma in seguito inglobata dallo stesso. Fu restaurata nel 1695, e nel 1737 fu ampliata insieme all'annesso convento da Giovanni da Evora. All'interno vi è un coro ligneo del XVIII secolo e, al centro dell'altare maggiore un dipinto, tempera su tavola, di metà del XV secolo, raffigurante la santa titolare rivolta verso l'Eterno, opera di artista anonimo nell'ambito di Antoniazzo Romano. La chiesa sembra fosse stata consacrata da Bernardo da Chiaravalle (Viene venerato come Santo dalla Chiesa Cattolica. Canonizzato nel 1174 da Papa Alessandro III, fu dichiarato Dottore della Chiesa, da Papa Pio VIII nel 1830. Nel 1953 Papa Pio XII gli dedicò l'enciclica Doctor Mellifluus. Colui che redasse la Regola dell'ordine dei Cavalieri Templari). La chiesa di San Michele. La tradizione locale la vuole consacrata da Papa Eugenio III. Secondo vari dati la chiesa originaria si trovava in un luogo non ben identificato ma distante. È certo però che il campanile venne inaugurato il 10 aprile del 1677 dal Vescovo di Tivoli. Utilizzata per sepolture e riti funebri fino agli inizi del XX secolo, nel 1867 divenne dormitorio dei Garibaldini. Venne restaurata nel 1935 e nel 1997. All'interno si trovano una tela ad olio e una statua dell'Arcangelo Michele. - Nota tratta da Wikipedia.
Atti - 1827 - Camera dei Deputati Parlamentari LEGISLATURA
XVIII SESSIONE, DISCUSSIONI, TORNATA DEL 7 MAGGIO 1891 LX. TORNATA DI GIOVEDÌ
7 MAGGIO 1891 - Votazione di tre disegni di legge.
Presidente. L'ordine del giorno reca votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge : Autorizzazione di spesa per provvedere ad una inchiesta disciplinare ed amministrativa nella colonia Eritrea. Autorizzazione della spesa di lire 3,000,000 da iscriversi al capitolo n. 39 (Spese d'Africa) dell'assestamento del bilancio 1890-91 del Ministero della guerra. Modificazioni all'assestamento della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91. Si faccia la chiama. Fortunato, segretario, fa la chiama. Hanno preso parte alla votazione: Amato Pojero, Ambrosoli, Antonelli, Arbib, Arcoleo, Armirotti , Artom di Sant'Agnese, Baccelli, Balenzano, Berio, Bonacci, Bonardi, Bonasi, Borgatta, Borromeo, Branca, Brin, Brunetti, Bufardeci, Cadolini, Calvanese, Canzio, Capilongo, Cappelli, Carcano, Casana, Casati, Cavalieri, Cavalletto, Cavalli, Cavallotti, Cefaly, Cerruti, Chiala, Chiapusso, Chiaradia, Chimirri, Chinaglia, Cipelli, Cocco Ortu, Coffari, Colombo, Comin, Ceppino, Costantini, Cremonesi, Cuccia, Curcio, Curioni, Daneo, Danieli, D'Arco, De Biasio Vincenzo, De Dominicis, De Giorgio, De Lieto, Della Rocca, De Murtas, De Puppi, De Riseis Giuseppe, De Seta, Di Biasio Scipione, Di Breganze, Di Collobiano, Diligenti, Di Marzo, Dini, Di Rudinì, Di San Donato, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofri, Elia, Ellena, Episcopo, Ercole, Fabrizj, Falconi, Faldella, Ferracciù , Ferraris Maggiorino, Ferri, Finocchiaro Aprile, Fornari, Fortis, Fortunato, Franceschini, Franchetti, Frascara, Frola, Galli Roberto, Gallo Niccolò, Gamba, Garibaldi, Gasco, Giampietro, Giolitti, Giorgi, Giovagnoli, Giovanelli, Giusso Grassi Pasini, Grimaldi, Guglielmi, Indelli, Laj, Lanzara, Lazzaro, Levi, Lovito, Lucca, Lucifero , Luzzatti, Mafia, Maranca Antinori, Marazzi Fortunato, Marchiori, Mariotti Filippo, Marietti Ruggero, Marzin, Maury, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mei, Menotti, Merello, Mezzacapo, Mezzanotte, Miceli, Moceani, Montagna, Monticelli, Morelli, Morin, Mussi, Nasi Carlo, Nasi Nunzio, Nicotera, Oddone Giovanni, Oddone Luigi, Pais-Serra, Panizza Giacomo, Papa, Pascolato, Pelloux, Penserini, Perrone di San Martino, Picardi, Piccaroli, Pinchi, Plebano, Poli, Polvere, Pompilj, Puro, Quattrocchi , Quintièri, Rampoldi , Rinaldi Pietro, Riola Errico, Rizzo, Rolandi, Romanin Jacur, Rossi Rodolfo, Roux, Ruggieri, Salandra, Sampieri, Sanfìlippo, Sani Giacomo, Sani Severino , Saporito, Silvestri, Simonelli, Sineo, Sola, Solinas Apostoli, Sonnino, Spirito Squitti, Stellati Scala, Strani , Suardi Gianforte, Suardo Alessio, Tacconi, Tajani, Tasca Lanza, Tegas, Tittoni, Tommasi Crudeli, Tondi, Torelli, Torrigiani, Tripepi, Trompeo Turbiglio Sebastiano, Vaccaj, Vendemini, Vendramini, Vetroni, Vienna, Vischi, Visocchi, Vollaro Savario, Zaoolini, Zeppa, Zucconi.
VIRTUAL TOUR MUSEI CAPITOLINI SALA DELLA LUPA
CAMPAGNANO

LO STATUTO DI CAMPAGNANO DEL SECOLO DECIMOTERZO
Dello Statuto di Campagnano del Secolo decimoterzo
ci è stato conservato nel suo originale, scritto per mano di notaio sopra
un rotolo di pergamena. È conservato in Roma nell'Archivio
Orsini insieme a quelli di Vicovaro del 1293 e di Cave del 1306. Lo statuto
di Cave mi fu indicato dal prof. Tomassetti e gli altri due dal prof. Casanova
ora defunto. Il Coppi ne fece anche stampare un breve trattato, ma la brevità
non riusci a salvare il frammento dall'essere riprodotto molto infedelmente.
Dopo il Coppi lo statuto venne ricordato dal prof. Tomassetti nell'opera Della
campagna romana nel medioevo. Sebbene nessuno lo avesse fatto finora oggetto
di speciale studio, esso è stato varie volte citato dagli eruditi. Lo
Statuto inedito della città di Bracciano , diede in luce un decreto col
quale il cardinale Ascanio Sforza, tutore di Giordano Orsini, nel 1552 estese
a Bracciano lo statuto di Campagnano. Lo stesso cardinale Ascanio Sforza lo
mise in vigore in Anguillara, in Trivignano e in Cerveteri, non so se pei suoi
pregi intrinseci, o per ragioni di opportunità. Il professor Re a ragione"
stimò che lo statuto di Campagnano avesse avuto un'applicazione ancora
maggiore, e da questa circostanza indusse : « che la classificazione degli
statuti italiani è in realtà assai più facile di «
quanto a prima vista non sembri » . E un anno dopo il prof. Carlo Calisse
opinava che lo statuto di Veiano fosse tra quelli, che hanno a base lo statuto
di Campagnano . Tuttavia questo non è lo statuto del secolo XIII, come
hanno creduto il Re ed il Calisse, bensì quello che vigeva nel secolo
XVI, e sebbene non se ne conosca alcuna copia, riesce facile dimostrare, come
esso fosse molto diverso da quello sancito nel secolo XIII. Così per
esempio nel De Luca , il passo dello statuto di Campagnano riguardante l'esclusione
delle femmine dal succedere è uguale non solo alle disposizioni degli
statuti di Cervetri e di Bracciano , già ricordati, ma anche ad altri
, mentre un passo corrispondente sarebbe vano cercarlo nello statuto di Campagnano
del secolo XIII. Anche lo statuto di Campagnano subì quell'evoluzione
che generalmente si riscontra negli statuti di giurisdizione feudale. Ai tempi
delle grandi Libertà comunali, il popolo dei castelli feudali non fu
estraneo alla compilazione delle proprie leggi. Per quanto i signorotti si accerchiassero
di mura e di fosse, non poterono impedire che dai comuni vicini qualche raggio
di libertà penetrasse nei loro possessi: onde vennero a concessioni svariatissime,
che recano una grande varietà negli statuti, negli ordinamenti e nei
bandi promulgati dai baroni italiani. Perciò, qualora si voglia trattare
degli statuti, siano pure di giurisdizione feudale, oltre alla località
è necessario tener presente' l'epoca, in cui furono emanati. Preme tanto
più adottare un siffatto criterio, perchè la vita dei molteplici
Stati in cui fu spezzata la nostra penisola, si svolse spesso parallelamente
e in condizioni assai somighanti per molti riguardi. Prima fiori in essi un
regime libero, al quale gradatamente andò subentrando la tirannia; e
si manifestò tendenza a questa, anche dove continuò ad esistere
la forma repubblicana. Tale trasformazione si verificò in tutti gli Stati
itahani, non importa se prima o dopo, se in una forma o in un'altra. A Roma
fino al secolo XV la sovranità effettiva, non parlo della formale, risiedette
nell'aha nobiltà feudale, come a Milano e in altre città . Con
Cola di Rienzo si ebbe un tentativo, che per poco non riuscì, di fondare
un libero ed ordinato governo democratico.Nel secolo XV la supremazia del pontefice
non ebbe più rivali, e non tardò a trasformarsi in potere assoluto.
Anche nella legislazione i diversi Stati italiani ebbero uno sviluppo molto
rassomigliante. Il diritto longobardo per lunghi anni prevalse in gran parte
della penisola, prima fondendosi col diritto romano e poi soggiacendo alla influenza
di esso. Nell'Italia media il diritto longobardo ebbe i suoi bei giorni. Pur
nel secolo undecime il monastero di Farfa si reggeva ancora con quel diritto
. Perciò non può essere esatto il sistema del Rosshirt, il quale
divide gli statuti italiani in tre gruppi, riconoscendo in quelli della Italia
settentrionale l'influenza longobarda, in quelli della media la romana, e in
quelli della meridionale la longobarda, la franca e la greca . La località
dunque non deve certo trascurarsi, ma è anche necessario tener conto
dell'età in cui lo statuto fu promulgato e in questa sentenza mi conferma
il confronto di non pochi statuti. In quelli compilati ai tempi delle grandi
libertà comunali, non solo l'elemento romano è più scarso,
ma lo statuto assume presso a poco l'aspetto di un patto tra il barone e il
popolo. Questo viene espressamente convocato, ed un notaio redige la carta.
Ne consegue che di regola ha forza obbligatoria pure per il signore, e talvolta,
come nello statuto di Nonantola , in quelli di Vicovaro e di Campagnano , si
stipula una multa nella quale incorre anche il barone, se viola le leggi sancite.
L'intervento poi del popolo nel formare lo statuto si esplica in vari modi.
Ora lo statuto trae origine dal consenso del barone a qualche domanda dei suoi
vassalli, come quello di Pontecorvo dell'anno 1190 (Tosti, Storia della badia
di Montecassino,Roffrldus Dei Grada cardinalis et Cassinensis 2* ed., II, 277),
ora non è che il riconoscimento delle consuetudini esistenti, come quello
di Atina del 1195 , ed ora è il barone stesso che nella redazione dello
statuto procede insieme ai sapienti del castello, come in quello di Rivalta
del 1293 (Claretta, Sugli antichi signori di Rivalta, e sugli statuti del secolo
XIII da loro accordati, p. 139 ). Si va ancora più oltre. Lo statuto
spesso è compilato per volere del signore e del popolo, come quello inedito
di Vicovaro (1273). Gli statuti di Vallombrosa furono redatti soltanto per volere
degli abitanti di tutta la curia (Statuti di Val d'Ambra e Vallombrosa: In nomine
Domini amen. Millesimo ducentesimo quinquagesimo tertio ). In Montagutolo lo
statuto fu «facto et ordinato et composito per li massari del decto comune
sotto gli anni di N. S. 1280 ... ad onore del comune di Siena e dei conti di
Civitella» . Parimente lo statuto inedito di Cave del 1305 fu redatto
dal pubblico notaio anche per mandato del sindaco rappresentante del popolo
, e così vennero compilati quelli di Cordovado del 1337 , di Moggio del
1337 , di Valvasone del 1359 , di Montenars del 1373 , di Ponzanello del 1470
. Ricordo infine uno statuto del 1477 , che fu compilato dagli statutari delle
università soggette all'abbazia di Farfa e fu presentato all'abate per
la sola conferma. Ma nel quattrocento le libertà declinarono sempre più
rapidamente, e già nei castelli feudali si compilavano statuti come quello
di Tarzo del 1444, in cui si sancisce che « omne eius verbum prò
statuto habeatur, et observetur inviolabiliter, et quod statuta intelligantur
semper ad beneplacitum ipsius episcopi » . Venuto poi il cinquecento,
questo linguaggio diventa normale, e nelle terre feudali si rispecchia l'assolutismo
degli Stati maggiorii Il popolo viene spogliato di ogni potere, ed il barone,
nel dettare le norme legislative, comanda. Gli statuti, salvo rarissime eccezioni,
rimangono isolati dalla vita vera e viva del popolo. Talvolta è il barone
stesso che, chiuso con giureconsulti solimi Deum prue oculis habentes, redige
lo statuto come fece Giorgio Santacroce nel 1571 per Velano (Copia manoscritta
che si conserva nell'Archivio di Stato, p. 4. C. Calisse, Statuto inedito di
Veiano in Studi e documenti di storia e diritto, a. VII, p. 503). Tal' altra
con un decreto estende uno statuto, che già si trova in vigore altrove.
Cosi, abbiam già veduto, proce- deva il cardinale Ascanio Sforza. Ottavio
Farnese nel 1558 fece stampare gli statuti per Castro e Ronciglione. Sono preceduti
da un dialogo tra il duca Ottavio ed un Pietro Artemio, priore di Gradoh. In
questo dialogo si dice in sostanza che, sebbene molti abbiano governato col
ferro e col fuoco, pure il duca preferisce di cattivarsi i suoi sudditi, reggendoli
con buone leggi (Di questo statuto un esemplare sì conserva nella biblioteca
del Senato e un altro nell'Archivio di Stato. Ecco il dialogo : OCTAVIUS FARNESIUS,
DUX ILLUSTRISSIMUS.) Il dialogo è seguito da altri versi in lode di Gerolama
Orsini, madre di Ottavio, che finiscono con una invocazione a Giove, perchè
conservi a Castro e Ronciglione il duca Ottavio e la sua madre. Lo stesso carattere
hanno generalmente gli altri statuti di questo secolo e dei successivi. Basta
ricordare quello che i conti Brancaleoni diedero al castello di Piobbico nel
1518 (Manoscritto esistente nell'Archivio di Stato. Nel proemio si legge : «...
Noi Roberto, Guido, Federico, Manfredo e Paris Gallas « dei Brancaleoni
conti del Piobbico, amatori ed osservatori della giustizia, volendo provvedere
al comodo pubblico e privato del nostro governo, comandiamo a detto popolo e
comunità, che siano «osservate onninamente le presenti constituzioni
e rubriche... , quello di Genga del 1582 (Manoscritto nell'Archivio di Stato.
), di Collalto del 1583 (Statuta Collalti cura Francisci Ferro edita, pp. 65
e 67. ), di Castel Gandolfo del 1588 (Presso l'Archivio di Stato.), di Torrita
del 1593 (Manoscritto nell'Archivio di Stato. ), di Castiglione e Chiusi del
1.750 (Furono stampati a Siena l'anno 1750. ), del castello di Posta del 1755
(Manoscritto nell'Archivio di Stato.), e finalmente quelli concessi dal conte
di Carpegna nel 1803 (Archivio di Stato, cartella 218.). Nondimeno si trova
ancora qualche statuto, alla formazione del quale il popolo non è del
tutto estraneo. Gli statuti di Civitalavinia del 1 567, ad esempio, furono compilati
da due statutari eletti dalla comunità, ma per ordine e mandato del signore
del castello Giovan Giorgio Cesarini (Manoscritto nell'Archivio di Stato : «
Civitae Laviniae, d. Ioannis « Georgi! Caesarini, et perpetui domini magistrum
d. Alexandrum de Alexandris, Caesarem de Tiberiis notarium egregium »).
Se non che, oltre ad essere questa un'eccezione assai rara, trattasi di un intervento
abbastanza effimero. Anzi gli statuti si andarono facendo sempre più
rari, ed i baroni preferirono di dare le norme legislative con bandi, editti
e .decreti. Rammento soltanto i bandi generali emanati nel 1658 da don Giuseppe
Angelo Aquitano Cesi (Se ne trova un esemplare nell'Archivio di Stato (498),
quelli del 1779 di don Agostino Chigi, principe di Farnese , il bando del duca
di Monterotondo del 1707 , quelli di Alessandro Boncompagni Ottoboni da osservarsi
nella terra di Piano del 17^5 , il decreto emanato dal conte di Carpegna nel
1803 , e l'editto promulgato a Roccasecca dal principe Pietro Gabrielli . Ora,
sebbene le consuetudini baronali d' Italia non portassero come altrove a diritti
crudeli ed insolenti, è facile immaginare a quanti eccessi dovessero
trascorrere tutti questi signorotti, la cui volontà era legge, e il cui
arbitrio illimitato era l'unico criterio nell' interpetrare gli statuti, i bandi
e le altre disposizioni legislative. Il concetto unitario dello Stato, risorto
col diritto romano, sviluppatosi cogli statisti del cinquecento, potè
solo a fatica attuarsi, e nel governo della Chiesa ebbe per gran nemico il nepotismo.
Il Theiner fa risalire il principio del dominio reale dei papi alla bolla di
san Pio V, che proibì nuove infeudazioni . I pontefici, è vero,
sancivano le Costituzioni e bandi da osservarsi in tutto lo Stato ecclesiastico,
ma il frequente ripetersi di siffatte leggi mostra per sé la riluttanza
dei baroni ad accoglierle. I bandi di Benedetto XIV del 1747 furono preceduti
nel 1723 da queUi di Innocenzo XIII. In essi si sanciscono nuovamente le costituzioni
di Pio IV, di Pio V e di Alessandro VIII, l'editto di Clemente XI e la costituzione
di Clemente XII. A qulli di Innocenzo XIII è allegato un bando del 1745
sopra il portar ter:(aroli ed archibugi, e che avrebbe dovuto aver vigore in
tutto lo Stato pontificio. Tanto poi Innocenzo XIII , quanto Benedetto XIV disposero
che i loro bandi, contenenti norme penali e di polizia, dovessero essere osservati
anche nei luoghi baronali. Ma con tutto ciò i pontefici non riuscirono
a spezzare le diverse giurisdizioni, che inceppavano l'autorità sovrana,
fino a che Pio VII, seguendo l'impulso della grande rivoluzione, col motupro-
prio del 1815 diede al feudalesimo un colpo definitivo. Questa istituzione già
decrepita crollò quasi contemporaneamente in altre regioni della penisola
, ed i popoli itahani cominciarono a veder verificati i loro voti comuni in
materia di riforme legislative. Questa digressione, forse un po' lunga, era
necessaria per mettere in chiaro quanto l'epoca abbia influito sui statuti italiani,
compresi quelli di giurisdizione feudale. Poco più sopra nel fare una
comparazione tra parecchi statuti, si è tenuto conto soltanto dell'anno
in cui furono emanati. Ne è risultato che quelli di una stessa epoca,
sebbene appartenenti a regioni distinte, hanno grandissima affinità specialmente
nel modo di redazione. Invece una differenza sostanziale si scorge in due statuti
sanciti per lo stesso castello, ma in secoli differenti. Un esempio notevole
di tale differenza ci offre il paragone tra lo statuto di Campagnano del secolo
XIII e quello che ebbe vigore in seguito. Quest'ultimo probabilmente fu redatto
sulla metà del secolo XV, quando le città della Tuscia, come già
osservò il professor Calisse (Statuti ài Civitavecchia negli Studi
e documenti di storia e diritto), seguendo il movimento generale, riordinarono
i loro antichi statuti. Ci è forza limitarci ad una semplice ipotesi
intorno a ciò, perchè non si conosce alcuna copia dello statuto
e non si può affermar nulla di sicuro sulla sua data precìsa,
ma si può dire invece quale ne fosse l'organismo, avendo sotto gli occhi
lo statuto di Bracciano che, come s'è visto, trae la sua origine da quello
dì Campagnano (Una copia è conservata nella biblioteca Vaticana,
un'altra nell'archivio Orsini e una terza presso il duca Torlonia. V. Camillo
Re, Studi e documenti di storia e diritto,). Esso comprendeva tutto il campo
del diritto civile e penale colle relative procedure, non omessi i provvedimenti
dì polizia e dì finanza : era diviso in quattro libri : cìvilium,
extraordinariorum, de damnis datis, criminalium ; e quésti in numerose
rubriche, tanto prolisse che qualcuna oltrepassava una pagina e mezzo di gran
formato : vi sì scorge la mano dì un giureconsulto, che, immemore
del precetto di Seneca , nel compilare un codice dì legislazione non
sa staccarsi dalla disputa scolastica. ai quali nel 1270 il comune di Campagnano
venne con Riccardo Annibaldi, e fu accettato dopo essere stato riformato e corretto
dallo stesso Annibaldi e dal popolo di Campagnano . Questo statuto, che nel
suo complesso è abbastanza bene ordinato, tratta prima molto diffusamente
dei reati, e in ciò esso rassomiglia ad altri statuti contemporanei.
Insieme alle disposizioni penali ve ne sono altre di polizia, e specialmente
di polizia rurale. Seguono parecchie norme, secondo le quali si deve procedere
e por termine alle questioni civili. Vengono infine norme molto disparate, come
fu sempre nel libro extraordinarioriim degli statuti. Esaminando un po' più
addentro i due statuti, la differenza si fa ancora più spiccata. Nel
posteriore, il primo libro civiìmm comprende anche gli officia, e ventisette
rubriche parlano del solo vicario : in quello del secolo XIII, come si vedrà
meglio in seguito, neppure una parola a tale riguardo. Nel libro crimìnal'mm
invece la differenza tra i due statuti di Campagnano è incontestabilmente
minore ; ma non dovrà ciò ripetersi dal fatto che gli statuti
in questa materia mantennero più lungamente la veste barbarica ? Quindi
non può asserirsi, ma è probabile che lo statuto del secolo XIII
fosse il seme, da cui si svolse quello dei secoli seguenti. Né deve far
meraviglia, quando si pensi che pochi anni dopo la compilazione di quello statuto,
nel 1287, Pietro Annibaldi proconsul Romanorum, che era succeduto nella signoria
di Campagnano, a richiesta degli abitanti di questo castello faceva concessioni
in materia di alienazione d'immobili e di dote (p. 78, tratto anch'esso dall'archìvio
Orsini. ). Nel Colosseo, Invece lo statuto di Campagnano del secolo XIII ha
una origine tutta sua propria. Fu redatto insieme coi patti dove allora gli
Annibaldi avevano posto la loro dimora, ne fu redatto un atto pubblico dallo
stesso lohannes domine Francisce, che aveva scritto lo statuto. Non è
poi difficile immaginare quante altre aggiunte e quali modificazioni abbia subìto
lo Statuto, dopo che nel 1370 Campagnano giurò vassallaggio al popolo
romano, e quando più tardi passò agli Orsini. Insomma lo statuto
di Campagnano del secolo XIII e quello del secolo XVI riflettono due epoche
differenti, e la loro diversità è sostanziale. Lo statuto del
secolo XIII è scritto per mano di notaio insieme ai patti che vennero
stipulati nel 1270 tra il popolo di Campagnano e Riccardo Annibaldi; e qui sorge
naturale una domanda: prima del 1270 il castello godeva libertà, o già
viveva sotto il giogo più o meno grave di un barone ? I documenti difettano,
e perciò è d'uopo rassegnarsi all'ipotesi più probabile,
deducendola dalle condizioni generali del tempo e dai documenti posteriori.
Invece si può determinare con certezza il nuovo stato, che gli abitanti
del castello acquistarono dopo i patti del 1270. In base ad essi esporrò
le condizioni del castello, i rapporti tra gli abitanti ed il signore, i loro
diritti e doveri reciproci. Esaminerò infine rapidamente le singole norme
dello statuto. Su Riccardo Annibaldi, cardinale di Sant'Angelo, partigiano accanito
di Carlo d' Angiò e amico di S. Tommaso d'Aquino, abbondano le notizie
(Gregorovius, Gesch. d&r Stadi Rom). Si sa invece pochissimo di Campagnano
fino al 1270 (Tomassetti, Della campagna romana nel medioevo,). Situato sulla
riva destra del Tevere, in quella parte della provincia di Roma che nel medioevo
fu detta Tuscia Romana, vuoisi che il suo nome derivi dal fundus campanianus
uno dei fondi che componevano la donmsculta Capracoro. Allo scomporsi di questa
donmsculta Campagnano deve l'origine sua come castello. Per la prima volta viene
chiamato ca- striim in una bolla di Anacleto II del 1130 , e annoverato tra
i beni del monastero di S. Paolo. Il castello ebbe un rapido sviluppo, perchè
la sua posizione elevata, salubre e forte, attirò gli emigranti da Capracoro,
l'erede dì Veio, fondata in luogo malsano e poco riparato . Fino al 1270
mancano altre notizie. L'ipotesi più probabile è che si fosse
elevato a comunità di uomini liberi come parecchi altri castra delle
tre Provincie in cui allora si divideva il governo della Chiesa . Più
di un argomento mihta a favore di questa ipotesi. Oltre che un tal fatto corrisponderebbe
alla tendenza dei tempi, nei patti con Riccardo Annibaldi non v'ha nessun indizio
che il castello prima del 1270 fosse sottoposto alla giurisdizione di altro
barone. Dal che si può dedurre che gli abitanti di Campagnano non erano
legati a nessuno con vincolo di vassallaggio o almeno che questo si era tanto
rallentato da potersi ritenere come inesistente. Altrimenti come potevano giurare
fedeltà e vassallaggio a Riccardo Annibaldi ? Né può supporsi
che già fossero sotto la giurisdizione dello stesso Annibaldi. In tal
caso se ne avrebbe certo qualche cenno. Invece si dice espressamente che tutti
i diritti del comune e dei privati vengono trasferiti nella persona di Riccardo
Annibaldi . Questo vuol dire che prima non li aveva. E tali diritti gli vengono
ap- punto trasmessi dal sindaco eletto da tutti gli abitanti, i quali non avrebbero
potuto disporre così dei diritti sovrani, se non li avessero posseduti.
Faccio infine un'altra osservazione. Neil 130 il castello apparteneva al monastero
di S. Paolo. Ma questo nel secolo XIII perdette il dominio di molte terre, come
ad esempio Castelnuovo di Porto , Piano , S. Severa e Mentana . Lo stesso dovette
accadere per Campagnano, il quale forse rimase libero, perchè le sue
floride condizioni gli diedero agio di resistere ai primi urti della prepotenza
feudale. Tuttavia i piccoli castelli diffìcilmente mantenevano la libertà
acquistata, ed o venivano E qui è d'uopo ricordare come nel secolo XIII
il numero dei servi fosse ridotto a proporzioni minime . Oltracciò molto
probabilmente Campagnano si era elevato a comune libero, e ben disse il Cantù
che se a noi Italiani i comuni non lasciarono una patria, lasciarono la dignità
di uomini. In tutto lo statuto non vi è un'espressione che possa in qualche
modo alludere a persone cui non fosse riconosciuta la piena personalità.
Anzi vi si trova . che ai servi erano sottentrati i domestici o inservienti
nel senso moderno . A tutti poi indistintamente è garantita quella libertà,
che può dirsi di locomozione : ognuno coi suoi beni mobili può
andarsene dovecchessia, e solo per poter possedere il feudo, deve abitare nel
castello . Ognuno può centrar matrimonio, dove più gli piace,
mentre in altri luoghi venivano imposte molteplici tasse, e lontani non erano
i ricordi dei più gravi diritti feudali. Né viene negato a nessuno
il diritto di vendere vino e frumento, tranne in caso di guerra e quando il
signore credesse impedirlo per il bene del paese. E perchè il suo zelo
non si facesse eccessivo, si aggiunge che non può mai percepir nulla
su quanto si vende . Del resto in Italia, dove più dove meno, queste
Libertà erano penetrate anche nei castelli avvezzi alla signoria baronale.
Negli ordinamenti di Vicovaro, per esempio, è espressamente dichiarato
che ognuno possa liberamente venire ad abitare nel paese o andarsene . Un esame
più minuto dei doveri personali mostrerà ancora meglio che i patti
con Riccardo Annibaldi assi- curarono buone condizioni ai singoli. Naturalmente
per il giuramento prestato tutti erano obbligati alla fedeltà verso il
signore: chi manca alla fedeltà, è reo di tradimento, «
proditio », e viene punito ad arbitrio del signoce . Anche presso gli
antichi Germani i traditori, « proditores » , erano puniti colla
sanzione suprema, e per essi era esclusa la composizione . Inoltre il giuramento
di fedeltà obbligava al riconoscimento della giurisdizione feudale ,
e un tal diritto viene gelosamente custodito dal cardinal Riccardo. Colui che
adisce un'altra curia, commette un reato, «maleficium», che in nessun
modo deve andare impunito . Dei molti obblighi personali, che avevano i vassalli
verso i loro signori, si può asserire che gli uomini di Campagnano, ne
avessero un altro solo verso gli Annibaldi, cioè quello di prestare il
servizio militare, e, per un giorno, a proprie spese . Su questo punto non si
fa alcuna delle restrizioni ammesse dalla consuetudine feudale . Né gli
altri baroni romani dovevano seguire una costumanza diversa, che dei loro vassalli
si servivano per abbattere i rivali, qualora venissero a contesa, sia nella
stessa Roma, sia fuori . Giova ripetere che il popolo di Campagnano era tenuto
al solo servizio militare. Sebbene nello statuto si dica servigio, non si può
certo chiamar tale l'obbligo di riattare le vie interne ed esterne e di porre
in assetto il castello . Anzi insieme a questo dovere puramente civico si pattuì
che il signore non potesse imporre alcun donativo, «datum», né
raccogliere colletta, « collectam » : il qual patto trovasi molto
raramente nelle signorie feudali. Basta vedere quanto dispongono gli ordinamenti
di Vicovaro . Un altro obbligo soltanto fu imposto agli abitanti di Campagnano,
che si ritrova anche altrove, e nel quale si può scorgere un residuo
del diritto di albergaggio ; anzi nello statuto non venne considerato come un
servigio. Quest'obbligo consisteva nel fare i letti, quando venisse in Campagnano
il signore, e, finché fosse in vita il cardinal Riccardo, si dovevano
fare non solo per lui, ma anche pei suoi nipoti del ramo paterno, « de
domo paterna » . Questi furono i doveri personali, ai quali nel 1270 gli
abitanti di Campagnano si obbhgarono verso l'Annibaldi. La condizione dei singoli
non divenne certo intollerabile, e fu migliore di quella in cui vivevano gli
abitanti di altri feudi anche dell'Italia media. È vero che questi dai
loro baroni non furono sottoposti a tutte quelle angherie, a tutti quegli abusi,
che desolarono altre regioni; però molte erano le prestazioni che da
loro si esigevano. Negli ordinamenti di Vicovaro se ne enunciarono moltissime
e di varie specie. La maggior parte consistette in opere, per le quali, tranne
in pochissimi casi , si ha diritto ad un compenso. Ma il giuramento di fedeltà
oltre ad essere fonte di diritti per l'Annibaldi, era anche fonte di doveri.
Nello statuto fu disposto che la curia dovesse difendere gli abitanti di Campagnano
per quanto poteva, dovesse rendere loro giustizia, ben guidarli e conservare
le buone consuetudini . È notevole come in questa disposizione si trovi
infiltrato il concetto della sovranità secondo il diritto canonico .
Nel 1270 non solo furono regolati da norme fisse i rapporti tra gli abitanti
di Campagnano e Riccardo Annibaldi, ma questi si obbligò di governare
secondo uno statuto. Una copia di esso fu conservata presso la curia, un'altra
presso il comune, mentre l'originale fu depositato in archivio, acciocché,
se fosse sorto dubbio, avesse potuto servire come termine di confronto . Questo
statuto forse proposto dall' Annibaldi al popolo di Campagnano ed accettato
con modificazioni, avrà esso avuto nessuna analogia con le leggi, che
allora vigevano in Roma ? Tuttavia non manca qualche speciale affinità
tra lo statuto di Campagnano e quelli di Roma . Inoltre é necessario
tener presente quanto fa osservare lo Sclopis: nei patti deditizi dei comuni
si scorge il desiderio e la cura di conservare le vecchie consuetudini in tutto
che appartenesse all'amministrazione della giustizia . E non di rado i comuni
riuscivano ad ottenere il loro intento, perché il regime amministrativo,
a differenza di quello politico, sebbene si trovi in uno stato di continuo divenire,
difficilmente si cambia. Ora è stata sostenuta l' ipotesi che Campagnano
nel 1270 fosse un comune Libero, e che per la necessità dei tempi avesse
dovuto sacrificare la propria indipendenza all'Annibaldi. Il popolo, che non
fu estraneo alla compilazione dello statuto, non avrà trascurato di far
sancire le proprie consuetudini, almeno per quanto gli fu possibile ; come un
secolo dopo nell'atto di vassallaggio ai rappresentanti del popolo romano, si
fece promettere che gh antichi statuti anche in seguito sarebbero stati mantenuti
in vigore . Octo Boni Homines antepositi dictì Castri. Quatuor Conestabiles
dicti Castri. iurantium vaxallagium et fidelitatem in manibus dicti scyndici
sunt hec, vidilicet : Colutia Petri Cacciate Rubeus Velli Petronis Petrus Colecta
Lucas Nutii Antelle Paulus Cecchi Pedecini Nutius Colutii Giralli Colutia Artini
Angilutius Lelli Perne Magister lacobus Roscelli net. Nardolus Coluscie Mannelli
Angelus Rubai dictus Ingioerà Vellus Rubei dictus Barbaccia Colutia pappitene
camerarius coraunis. Paulutius Lelli Lemmi Nutius Cole Andreocte lohannes Tasche
Antonius Petucchi Poncellus Castellutii Petrus Nutii Mannotie Nutius Cincii
Floris dictus Liscius Nardus Topera Carosus Lutii Cincius Namorati Colytia Petri
Colecte lannoctus Zarlli Antonius dictus Falgliolar Petrus dictus Crina Antonius
Cole Florutie Petrus Rubei Velli Petroni Paulus Velli Vanne Putius Laurentii
Vellotìus Velli Cresci Bartholomeus Velli Cole sutoris lohannes Bucciarelli
Paulus pappitene Paulus Gualli Theolus Meuli murator Lellus Mathie lacobus Berardi
Rentius Lamandi Antonius fratris lannis Ceccharellus Angeli Bone , Cecchus
Quatuoroculi , Cecchus Cole sutoris Symon Palotii Vellotius Picchocchi
Thofanus calzolarius lohannes Pauli Grappe Cecchus Iucche Petrus Copitelle Lellus
Vellutii Angeli Bone Angelus frater eius Magister Lucas Laurentii notarius Blaxius
Cecchi Petri Luce Andreotius Petri Altaville Petrus eius fìlius Cecchus
Nutii Antelle Paulus Cecchi Florutie Nicolaus Nardi de M...lgliano lohannes
Floris Lellus Mande lohannes Petri Colecte Antonius Guastapane Antonius Palocii
Nicolaus dictus Tiralocha Antonius dictus Caporoso Viestrus lohannis lohannes
Lelli lohannis Paulus Lelli lohannis Paulus Petri Colecte Colutia Cole Gemme
Nicolaus dictus Carnelevare Paulus Nutii Cecche lohannes Contìs Lellus
Nutii Antelle Blaxius Bocti Vannicellus Gerardi lacobus Vellocii Colutia Scactre
Petrus Stephani calzolarius lohannes Clodii Fran- cionus Rentius Cecchi Angeli
Marci Cecchus filius eius Antonius Lelli dictus Scatapessa lohannes Capocìe
Colutia , Gìralli Dioteaiuti Petri Bone Ceccharellus Sarti Nutius Omniasancti
Paulus Lamandi Johannes Gualli Cecchus eius frater Stephanus Namorati Stephanus
de Castilglioni Ceccharellus Franceschoni Cecchus Velli Verotie Cecchus Andree
Thome Cresci Dominicus Lelli dictus Nerello Paulus Rubei Andree Nardus Theoli
Symeonus. calzolarius lannolus Cecchini Tosi Paulus Cecchi dictus Pi^arolus
Petrus Coluscie Vanne Nardus Thome Paulus Andree presbyteri Angelus Bartholomei
Nicolaus Prungi Johannes Lelli Nardi Johannes Cioli Lellus Nutii Floris Dominicus
Petrononi Cincius Sancte Petre Cecchus Licscii Andreas Stephani Licscii Petrus
Stephannoni Dominicus eius frater Lellus Rubei Marre Johannes Stephanutii Lellus
Colutie Scalardi Petrus Licscii Marcus Alexii Johannes eius fìlius Benedictus
Mat ... li Julianus Johannis Cianche Johannes Cincii Vellotie Lucas Carosi Antonius
Santie Lucole Blaxius Johannis FIorutie Vellotius Petri Gemme Coluscia Cole
sutoris Lucas Thome Lelli Petri Jannolus Pancratii Antonius eius frater Nardus
Gerardi Cioctus Thomarelli Sanctrus Nardi Topere Donadeus Funarius Stephannutius
Nicolai Cyncii Petrus Nardi Thome Nutius Manotie Johannes Rubei Velli Petronis
Paulus Petri dictus Liccia lacobus Colutie Pappitelle Antonius Lelotii Piscicone
Alexius macellarius Johannes Petri Cecche dictus Toda Marthellonus Nutii Mattheule
Johannes Jacobi Rubei Cincius Luce Paoli Cecchonus Renzii Angelus frater eius
Lellus Janocti Fabaronis Lellus Velluti! Sarli Nicolaus Carosi dicti Mutii Johannes
Andree Petri Julianus Johannis de Scrofatio Angelus eius frater Rentius Ciocti
Petrus Cincii Namorati Lucas Coluscie Licscii Paulus Jacobi Ricii Coluscia Locii
Marcus Tucoli Antonius Ceccharelli Franceschoni Cecchus Petani. Actum in dicto
castro Campangiani, in dieta ecclesia, presentibus hiis testibus, scilicet Nardo
Berardi speciario de regione Pontis, Ni- colao Theballi de regione Pince, Antonio
Guerronis, Tutio Matthei Bocti de regione Parionis, et Nutio Nardi Buccabelle
de regione Campitelli, ad hec specialiter vocatis et rogatis. Ego Johannes domini
Jacobi Petri Angeli Rufìni civis romanus imperiali auctoritate notarius
publicus, quia predictis omnibus et singulis interfui, ea scripsi et publicavi
rogatus, et meum signum apposui consuetum.
Nel medio evo crollarono le antiche abitazioni della città Ficulense,
e furono abbandonate anche quelle nuovamente costruite, quando i potenti Capocci
e poi gli Orsini piantarono le loro torri strategiche sulle vie Nomentana e
Tiburtina. Fu la prepotenza dei feudatari, più che la forza dei barbari
e più che la neghgenza dei possessori, la vera causa della decadenza
economica ed agricola della nostra campagna ; e in questa via più che
altrove ne abbiamo evidente la testimonianza. Si potrebbe qui disegnare, come
in una pianta stratigrafica, la successione dei periodi cronologici di questa
regione: del periodo cioè di concentramento agricolo, del successivo
di dispersione, ed infine di quello, che può dirsi di rifugio e di riconcentramento
nei comuni vicini. Ma seguitiamo la nostra analisi storica, per ordine topografico.
Casemiove. La tenuta, cosi denominata per opposizione all'altra posta dirimpetto,
come già ho fatto notare (Vittorie già Casalvecchio), di rubbia
113, fu già dei monaci di S. Paolo, poi in parte del monistero ad aqims
Saìvias, in parte della ricca famiglia Alberini , poi dei Moroni e Bolis
. La limitata superficie e la situazione quasi in piano resero questo fondo
estraneo alle vicende degli altri confinanti. Olevano-Torricella, Monte Gentile.
La prima, con due nomi, è una fertile tenuta di 107 rubbia, in posizione
favorevole, sul margine destro della via Nomentana, sul 12° chilometro da
Roma, omessa nella pianta dello stato mag giore. Non è priva di antichi
marmi, che attestano la pertinenza di essa alla contrada Nomento-Ficulense ;
ma le memorie più abbondanti di essa sono del medio evo, e le ordinerò
con quelle di Monte Gentile, perchè, come ora si vedn\, spettarono ambedue
ai Capocci. Sul colle detto Monte Gentile, posto n 16 chilometri da Roma, sul
destro lato della via, veggonsi i ruderi di un castello, di piccole proporzioni,
ma di forte struttura. Domina esso la via verso Roma e la campagna verso la
via Tiburtina ; potè quindi esser munito da qualche Orsini di nome Gejitile,
fin dal secolo XIV, cioè dal tempo in cui gli Orsini ebbero Mentana,
della quale questo fortilizio sembra un eccellente avamposto. L'alleanza degli
Orsini coi Capocci, favorita dalle parentele, di cui fra poco si vedranno notizie
sincroniche, metteva questo luogo in comunicazione colla via Tiburtina, sulla
quale il non lontano Castel Arcione formava l'acropoli della famiglia Capocci,
come Mentana lo fu poi della Orsina. La piccola tenuta annessa,, che è
di 54 rubbia, porta anche il nome di Fontana Papa .
CASTEL GANDOLFO
DIZIONARIO DI ERUDIZIONE STORICO-ECCLESIASTICA DA S.PIETRO SINO AI NOSTRI GIORNI SPECIALMENTE INTORNO AI PRINCIPALI SANTI, BEATI, MARTIRI, PADRI, AI SOMMI PONTEFICI, CARDINALI E PIÙ CELEBRI SCRITTORI ECCLESIASTICI,EC.EC.EC . COMPILAZIONE DEL CAVALIERE GAETANO MORONI ROMANO SECONDO AIUTANTE DI CAMERA DI SUA SANTITÀ PIO IX. VOL.LI. IN VENEZIA DALLA TIPOGRAFIA EMILIANA MDCCCLI.
Diario di Roma e delle Notizie del giorno del 1848. Villa Torlonia a Castel Gandoifo dissi di sua nobile villa e a Conservatorio o Ritiro del Sacro Cuore di cui parlai ancora a Orfanotrofio, delle sue generose e caritatevoli cure per esso. Passando per una lunga galleria dipinta a frutti e fiori sulle pareti con quadretti del Bigioli, e nella volta con quadretti di Palmerola, si giunge all'appartamento composto di 4 camere. Nella prima: il Consoni dipinse la Poesia, la Storia, l'Astronomia, l'Eloquenza, la Filosofia; le altre camere hanno diversi abbellimenti. Ritornando alla galleria, da essa si entra nella sala pompeiana architettata dal Caretti e da lui ornata, ove sono anche i dipinti di Prampolini, rappresentanti le nozze Aldobrandine, la partenza d'Adone e altre antiche composizioni. Segue la camera dedicata alle illustri romane, ove dipinse parecchie storie il Quattrocchi, tutte allusive a celebri fatti di chiare donne: in altre camere sono dipinti di Gagliardi, e bambocciate di Diofebi. Pietro Vitali ci die, Marmi scolpiti esistenti nel palazzo del duca d. Gio.Torlonia, incisi e descritti.
ARALDICA LAZIO-LATINA STEMMARIO LATINESO
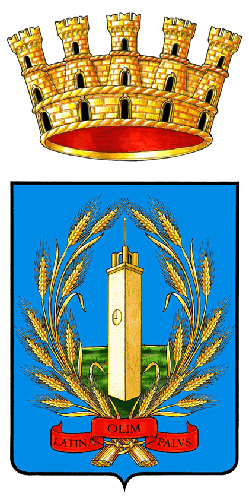
FAMIGLIE NOBILI E RINOMATE
Bisignano o Bisignani - Bonaccorsi - Carli - Cattani - Chiesa
(Della) - Forges Davanzati - Landi Vittori - Mancini e Mancini Ridolfini Corazzi
- Morlani Carrara Beroa - Pace - Pellicani - Quattrocchi
Colucci - Zanna (De) - Acquaderni - Alessandri
- Alimonda - Amadei - Arcelli Fontana - Astancolle - Farfoglia - Fesch (De)
- Festi (De) - Filipponi - Franceschini - Genova - Giovanelli - Iordanow (De)
- Landi Vittori - Lapi - Leoni - Leopardi - Leopardi Dittajuti - Lotteringhi
Della Stufa - Luca (de) Resta - Lugo - Mackinnon - Maestri Molinari - Marchetti
Degli Angelini Milzetti - Marzani - Masotti (De) - Melchiori (De') (Della Zuanna)
- Melloni - Milani Corniani Degli Algarotti - Mistruzzi Di Frisinga - Monda
- Morosini Navarini - Nordis (De) - Oliva - Palica - Pasquali - Pavoni - Pilosio
Di Castelpagano - Pisani - Porta (Dalla) - Prato (Da) - Ricci - Rocca (La) -
Rossi (De) - Salvo e Salvo Ugo - Sanminiatelli - Stahly - Torre (Dalla) - Vio
(De) - Vollaro - Zuccato
http://www.retaggio.it/araldica/lazio/latina/
VIDEO
Ultrajazz - Apollinaire - Calligrammi Inno a Roma
VELLETRI
Questo documento fornisce
di riferimento pronto per il Dublin Core Metadata Element Set, versione 1.1.
Per la documentazione più dettagliata e collegamenti a informazioni storiche
versioni, consultare il documento "DCMI metadati Termini" .
omeka-xml - www7.tau.ac.il/omeka/italjuda/items/browse/show/6?page=41...
La prima attestazione di una presenza ebraica a Velletri è del 1461,
..... al governatore Giuliano Quattrocchi
di provvedere con tutti i rimedi e le pene ...... Superata nel medioevo dalla
vicina Corneto, fu rinominata assieme a quella ...
Velletri . Provincia di Roma. Sorge sulla via che dai Colli Albani scende lungo il margine della Pianura Pontina dirigendosi a Terracina. Fu staccata da Gregorio IX da ogni dipendenza dalla città di Roma e posta direttamente sotto il papato. Sino all’inizio del XIV secolo V. mantenne piena autonomia, ma durante il periodo avignonese il Comune di Roma prese il sopravvento. Velletri, però, riacquistò la primitiva posizione con il ritorno della Sede Apostolica in Italia e nel XVI secolo passò sotto il dominio della Chiesa. Gli Ebrei risultano stanziati a Velletri sin dal XIV secolo, quando vivevano riuniti in una comunità con propri rabbini, esercitando il commercio del denaro e pagando un tributo annuo al Comune e a Roma. Nel 1391 i Conservatori e i Banderesi, per ricompensare l’obbedienza al Comune, concessero ai veliterni e agli ebrei qui residenti la facoltà di recarsi a Roma o nel suo territorio, senza subire molestie, nonostante i processi in corso e le sentenze pronunziate contro il Comune o i singoli ( processi che, durante lo scisma e la lotta tra il papato e la città, furono numerosi). In questa occasione gli ebrei furono obbligati a contribuire finanziariamente ai giochi di Testaccio (mentre i veliterni vennero costretti a partecipare ai giochi stessi). Nel 1401 fu, poi, concesso agli ebrei locali di limitare il proprio contributo fiscale al pagamento imposto al Comune e venne concessa loro l’esenzione dal segno. Dopo la metà degli anni Venti del secolo, inoltre, il medico ebreo veliterno Emanuele di Magister Menaguzoli ricevette licenza quinquennale per curare pazienti cristiani. Nel 1443 gli Israeliti di Velletri , firmarono insieme ad alcuni correligionari di altre città l’accordo con la Camera Apostolica per abrogare i provvedimenti restrittivi della bolla di Eugenio IV e, da un documento del 1472, risultavano quattro case ebraiche a Velletri. Nel 1542 Elia di Montopoli e Leone da Ceprano, feneratori a Velletri, ricevettero la tolleranza per operare come cambiavalute nel loro banco, ma l’anno successivo il neofita Domenico Sancio (ex Prospero di Musetto da Piperno) ebbe l’incarico di indagare in merito alle accuse di frode e di immissione di monete false mosse contro gli ebrei di una serie di località, tra cui Velletri. Nei secoli XV e XVI gli ebrei di Velletri furono obbligati a vivere in un dato luogo della città, protetti dalle leggi locali, come risulta dal III Capitolo degli Statuti, che imponeva alle autorità di difenderli da ogni violenza, ingiuria o vessazione e stabiliva che dovessero essere riconosciuti come cittadini. Nel 1547, dietro proposta dei feneratori Simone de’ Benedetto di Civita, Beniamino de’ Melone da Marino, Magister Elia Bendetto da Montopoli e Salvatore di Abramo di Cori, fu concessa agli Ebrei l’apertura di un banco feneratizio, per prestare ai locali all’interesse del 24% annuo (per prestiti inferiori a 3000 scudi) e del 50% annuo (per le somme dai cinque giulii in giù). Gli Ebrei continuarono ad esercitare l’attività feneratizia sino al 1552, quando il Comune deliberò di espellerli, sostituendoli con un Monte di Pietà, che, tuttavia, funzionò stabilmente solo nel XVII secolo. A quanto si deduce dalle fonti, un’espulsione vera e propria qui non ebbe luogo o, comunque, non tutti gli ebrei abbandonarono la località, dato che, nel 1559, l’Università degli Ebrei di Velletri fornì a proprie spese la bandiera della milizia cittadina, stipendiandone il tamburino e, dal 1558 al 1571, sono registrate svariate circoncisioni. Nell’elenco delle sinagoghe che pagarono il tributo alla Casa dei Catecumeni di Roma negli anni 1560-1565, quella di Velletri figura con 10 e poi 12 scudi. Nel 1569, Pio V decretava l’espulsione di tutti gli ebrei dallo stato pontificio, ad eccezione di Roma e Ancona; tuttavia, dall’elenco delle circoncisioni menzionato sopra, si deduce che a Velletri fossero state concesse sino al 1571 delle proroghe al decreto, per cui gli israeliti dei paesi vicini si sarebbero riuniti nella località in attesa di trovare una sistemazione definitiva altrove. Numerosi ebrei di Velletri si trasferirono a Roma, come attesta il cognome “Velletri” presente fra gli ebrei romani sino al XX secolo. Dopo che papa Sisto V ebbe accordato agli ebrei di vivere nelle città e “castelli” dello stato pontificio, nel 1586, si ritrovano presenze ebraiche a Velletri : nel 1587, vennero date concessioni per aprire banchi feneratizi ad Angelo, figlio del rabbino Ventura, ad Angelo del fu Lustro, a Crescenzio da Ceprano (Frosinone), a Gioello De Melozzo e a Leuccio di Angelo De Lea. Gli ebrei rimasero a Velletri sino all’espulsione definitiva dalle località dello Stato Pontificio (salvo Roma, Ancona ed Avignone) decretata da Clemente VIII nel 1593. Quartiere ebraico. Il quartiere ebraico era ubicato nella Decarcia Portella-Collicelo (o Colicello), tra le vie della Stamperia, della Trinità e del Serpe. "Sinagoga". La sinagoga era ubicata in via della Stamperia; nel XX secolo, dell’antico edificio era rimasta in piedi una delle pareti esterne, con in cima un rosone a forma di stella di Davide (Maghen David. Vita culturale. Tra il 1418 e il 1424 Meshullam Forte di Velletri, figlio di Yehiel di Terni, copiò alcuni codici contenenti le preghiere penitenziali (Selichoth) secondo il rito romano, la Logica di Petrus Hispanus; la seconda parte del formulario delle preghiere o Machazhor secondo il rito romano e un altro Machazhor, sempre di rito romano. Il manoscritto in lingua italiana, ma in caratteri ebraici, facente parte della biblioteca di Shemuel David Luzzatto, contenente il testo Chokhmat Nashim. La saggezza delle donne) fu scritto a Velletri nel 1565 (in onore della moglie del rabbino Mordekhai Dato) dal rabbino Yehiel Manoscrivi, che soggiornò nella località per un periodo. "Bibliografia Esposito". Una descriptio relativa alla presenza ebraica nel Lazio meridionale nel tardo Quattrocento, in Latium, Rivista di Studi Storici 2 (1985), pp. 151-158. Freimann, Jewish Scribes in Medieval Italy Alexander Marx Jubilee Volume, New York 1950, pp. 231-342. Gabrieli. Alcuni Capitoli del 1547 per un Banco di prestito a pegno tenuto dagli Ebrei in Velletri, (Velletri 1917). Loevinson. La concession de banques de prêts aux Juifs par les Papes des seizième et dix-septième siècles, in REJ XCV (1933), pp. 23-31. Pavoncello. Il IV Centenario dell’espulsione degli Ebrei dalla Campagna Romana, in Israel LIV, nº 16 ( 20 Febbraio 1969). Pavoncello. Le comunità ebraiche laziali prima del bando di Pio V, in Lunario Romano 1980: Rinascimento nel Lazio, Roma 1980, pp. 47-77. Pavoncello. Gli ebrei nella provincia romana, in Le Judaisme Sephardi. 31 (Janvier 1966), pp. 26-30. Pavoncello, Ricordi di ebrei in Velletri, in RMI39 (1973), pp. 359-368. Ravenna. Appunti storici sulle comunità del Lazio, in RMI 17 (1951), pp. 305-311; pp. 377-382. Simonsohn. The Apostolic See and the Jews, 8 voll., Toronto 1988-1991. Tersenghi, A. Il Monte di Pietà di Velletri ed i suoi capitoli costitutivi del 1402, in Archivio della r. Società Romana di Storia Patria, Vol. XLI, fasc. I-IV (1918). Vogelstein, H.- Rieger, Geschichte der Juden in Rom, Berlin 1895.La traslitterazione, viene riportata in Freimann. Jewish Scribes in Medieval Italy. Alexander Marx Jubilee Volume. Pavoncello. Le comunità ebraiche laziali prima del bando di Pio V, p. 74. Falco, G. Il Comune di Velletri nel Medioevo, in Archivio della Società Romana di Storia Patria, XXXVI (1913), pp. 412-13; pp. 439-40, cit. in Pavoncello. Le comunità ebraiche laziali, pp. 73-74. Simonsohn, S.The Apostolic See and the Jews, doc. 497. La comunità di Velletri e, talvolta, alcuni ebrei singoli a V. vengono menzionati più volte nei documenti relativi alle tasse, tra cui la vigesima e la tassa speciale per le spese turche (1542) nell’arco degli anni dal 1486 al 1544. Ivi, doc. 1061, 1095, 1316, 1778, 2076, 2130, 2133, 2186, 2302, 2306, 2313, 2413, 2423, 2424, 2553. Ivi,doc. 638 Vogelstein, H.- Rieger, P.Geschichte der Juden in Rom, Berlin 1895, II, p. 12; per i particolari relativi alla bolla, si veda la voce “Roma” della presente opera. Esposito, A.Una descriptio relativa alla presenza ebraica nel Lazio meridionale nel tardo Quattrocento, in Latium, Rivista di Studi Storici, 2 (1985), p. 155. Simonsohn, S., op. cit., doc. 2158, 2160, 2178. Ivi, doc. 2698; Gabrieli. Alcuni Capitoli del 1547 per un Banco di prestito a pegno tenuto dagli Ebrei in Velletri, Velletri 1917, pp. 11-16; per il testo dei capitoli, si veda ivi, pp. 21-35; Tersenghi. Velletri e le sue contrade, Velletri 1910, citato in Pavoncello, Ricordi di ebrei in Velletri, p. 360, n. 7. I Capitoli e i paragrafi degli Statuti di Velletri riguardanti gli ebrei, tratti dalla ristampa del 1752 del testo stampato nel 1544 a Velletri, sono stati riportati dal Pavoncello,pp. 364-368. Tra l’altro, vi si legge che gli ebrei non potevano pigiare uve pregiate, ma solo il mosto; era proibito alle donne cristiane di allattare bambini ebrei; era proibito agli ebrei e alle ebree di lavorare dentro e fuori delle proprie case di domenica e nei giorni delle principali festività cristiane; era proibito agli ebrei di uscire di casa il Venerdì Santo, senza il permesso delle autorità locali, sino al termine delle pubbliche funzioni nelle chiese. Le trasgressioni a tali divieti sarebbero state punite con multe pecuniarie. Un Capitolo – De Sciattatione - era dedicato alla macellazione rituale,secondo le disposizioni dei Priori; un altro Capitolo proibiva alle donne ebree di portare ornamenti d’oro e d’argento sugli abiti. Come segno di riconoscimento le ebree dovevano portare sul capo un velo di color croco e gli ebrei un tabarro rosso (dal quale i medici, tuttavia, erano esonerati). Era proibito agli ebrei di costruire o riparare fonti o strade cittadine (salvo quelle relative alle proprie vie e abitazioni); infine, prima di intraprendere qualsiasi opera, essi dovevano giurare sulle Sacre Scritture di non agire con falsità, inganno o malizia. Negli anni Quaranta del XVI secolo, si trova un altro cenno all’insediamento di Velletri, quando, nel 1542, il banchiere romano Salomone di Magister Isacco Zarfatti pagava la vigesima alla Camera pontificia per conto della comunità di Velletri (Vogelstein-Rieger, op. cit, II, p. 118). Cfr. Pavoncello. Gli ebrei nella provincia romana, p. 30, n. 36 (dove viene citata l’opera di Vogelstein e Rieger, con un errore nell’indicazione della pagina). Pavoncello. Ricordi di ebrei in Velletri, p. 361 (v. , in particolare, ivi, nn. 8 e 9); Idem. Le comunità ebraiche laziali, p. 75; cfr. il registro delle circoncisioni eseguite da Yehiel Coen Manoscrivi, in Ravenna. Appunti sulle comunità del Lazio, pp. 306-308. Sul Monte di Pietà di Velletri, cfr. Tersenghi. Il Monte di Pietà di Velletri ed i suoi capitoli costitutivi del 1402, in Archivio della r. Società Romana di Storia Patria, Vol. XLI, fasc. I-IV (1918). Tali dati si rilevano dal Memoriale indirizzato alla “Ill.ma Congregazione particolare deputata dalla SS. Di N.S. Pio VI”, nel 1789, basato dall’archivio della chiesa della Madonna dei Monti, alla voce “Sinagoghe”, per gli anni 1560-1565, citato da Pavoncello. Le comunità ebraiche laziali, p. 48. I dati del Memoriale relativi a Velletri sono riportati in Pavoncello. Il IV Centenario dell’espulsione degli Ebrei dalla Campagna Romana. Ravenna, Appunti sulle comunità del Lazio Pavoncello, Ricordi di ebrei in Velletri, p. 361; Idem. Le comunità ebraiche laziali, p. 75. Loevinson. La concession de banques de prêts aux Juifs par les Papes des seizième et dix-septième siècles, p. 28. Angelo figlio del rabbino Ventura, Gioiello e Leuccio risultavano residenti a Roma prima del Breve di Sisto V. Pavoncello, N., Ricordi di ebrei in Velletri, p. 362. Ivi, p. 368.Freimann, A., p. 296, nº 313. Pavoncello. Ricordi di ebrei in Velletri, p. 362 ; Ravenna, A., op. cit., p. 305. Velletri è in Provincia di Roma. Posta su di un colle tufaceo alla confluenza di due valli, sulla via Casilina, Velletri è di origine altomedievale ed è ricordata con il nome attuale nel secolo XII. Ha visto nel corso della sua storia l’avvicendarsi di molti signori: Canonici della Basilica del Laterano, Conti, Sforza, Barberini e Pamphilj. Un Salomone di Angelo, figlio di Abramo di V., attivo a Perugia nel 1449, attesta la presenza di ebrei nel borgo laziale almeno dalle prime decadi del XV secolo. Nel 1472 abitavano a Velletri sette famiglie ebraiche, la più eminente delle quali era quella di un Mastro Salomone, il cui contributo per la tassa della vigesima era di 50 ducati, mentre quello delle altre famiglie assommava soltanto a 18 ducati. Nel 1486 la piccola comunità, insieme ad altre di Campagna, ricusava di partecipare al sussidio imposto da Innocenzo VIII agli ebrei delle sue province. L’atteggiamento non solo dispiacque al papa, ma avendo egli anche estrema necessità del denaro, comandò al governatore Giuliano Quattrocchio di provvedere con tutti i rimedi e le pene opportune perché il contributo fosse immediatamente pagato. Nella prima metà del secolo XVI, ebrei originari di Velletri abitavano a Norcia e ad Ascoli Piceno, qui con altri correligionari provenienti dall’Italia centro-meridionale (Campli, Sulmona, Lanciano, Ortona, Teramo, L’Aquila) "Bibliografia" - De Bianchi, G., Storia di Valmontone, Valmontone 1981. Gobbi, O., Emigrazione, conversione, riconversione ebraica nel Piceno, in La presenza ebraica nelle Marche. Secoli XIII-XX, a cura di S. Anselmi, V. Bonazzoli, Ancona 1993, pp. 109, 116 (Quaderni di «Proposte e ricerche», n. 14). Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, 8 voll., Toronto 1988-1991. Toaff, The Jews in Umbria, Leiden-New York-Köln 1993-94. Cfr. De Bianchi, G., Storia di Valmontone, Valmontone 1981. Toaff, A., The Jews in Umbria. 2. 1435-1484, Leiden 1994, p. 579, doc. 1119. Simonsohn , S., The Apostolic See and the Jews. Documents: 1464-1521, Toronto 1990, p. 1199, doc. 960*; p. 1343, doc. 1061. Toaff, A., The Jews in Umbria. 3. 1484-1736, Leiden 1994, p. 1180, doc. 2294; Gobbi, O., Emigrazione, conversione, riconversione ebraica nel Piceno, in La presenza ebraica nelle Marche. Secoli XIII-XX, a cura di S. Anselmi, V. Bonazzoli, Ancona 1993, pp. 109, 116 (Quaderni di «Proposte e ricerche», n. 14)
VEROLI
Veroli . Provincia di Frosinone. Posta nel Lazio meridionale, su uno sprone degli Ernici che domina la regione collinosa circostante, Veroli fu sede dei ducati di Campagna e Marittima. Tradizionalmente legata agli interessi della Chiesa, riprese ad essere garantita nella propria autonomia dopo il ritorno dei papi da Avignone. Nel 1556 fu assalita dal duca di Alba, in lotta con Paolo IV. La prima attestazione di una presenza ebraica a Veroli è del 1461, quando Moise Angelelli e Gentilisca da Veroli e Mele Gayeli da Gennazano furono accusati di aver procurato i servizi di un assassino. Moise fu assolto e Mele fu multato. Al 1472 risale un documento attestante un nucleo ebraico a Veroli, quando venivano registrate qui quattro case. Un altro cenno alla presenza ebraica si ritrova, poco meno di una decina d’anni più tardi, quando Shabbetay di Mordekhay da Sulmona portava a termine nella località un manoscritto. Nel XVI secolo, gli Statuti cittadini si diffondevano sulle norme da tenersi nei confronti degli ebrei: nel terzo Libro si proibiva di mangiare in loro compagnia e di far macellare le loro carni nei mattatoi cristiani o vendervi le carni mattate dagli ebrei. Inoltre, all’articolo 76 del quinto Libro si specificava che se uno riconosce qualunque oggetto tenuto in pegno presso i Giudei, questi sono tenuti, se interrogati, a dire il nome di chi lo ha dato in pegno o colui che lo ha riconosciuto, altrimenti l’oggetto è ritenuto come rubato ed il Giudeo incorre nella pena come se lo avesse rubato. All’articolo 79 dello stesso Libro si stabiliva, poi, che per togliere l’ingiustizia degli ebrei, i termini a qualunque titolo concessi ai cristiani, sia in giudizio che fuori, stabiliti o da stabilirsi, per qualsiasi titolo, forma, modo, sono vantati sia per prestito di danaro che per qualsiasi altro motivo, non valgono se non per soli quattro anni. Infine, all’articolo 86 si leggeva: poiché i giudei sogliono comprare dai cristiani vino nuovo e mosto, sogliono pigiare a spremere le uve di cui parte del vino va ai Cristiani, può accadere che dal vino toccato e spremuto dai giudei si consacri dolosamente e disonestamente il sangue di Dio. Perciò per opporci a tali fatti ogni cittadino che venda ai giudei il vino o l’uva da loro pigiata, non può riporne alcunché, né può venderlo o scambiarlo con nessun cristiano. Deve invece venderlo tutto agli stessi giudei, i quali devono tutto comprarlo. Negli ultimi decenni prima dell'espulsione dallo Stato della Chiesa (1569) abitavano a Veroli alcuni ebrei, menzionati come contribuenti di diverse tasse, tra cui la vigesima. Alcuni furono prestatori, come per esempio i soci Emanuello di Guillelmo e Helia de Latis nel 1549 ed Emanuele di Gentilomo e Maestro Angelo, un medico, nel 1554. Nell’elenco delle sinagoghe che, dal 1560 sino alla Bolla di espulsione del 1569, corrispondevano la tassa alla Casa dei Catecumeni di Roma, figurava quella di Veroli, prima con 10 e poi con 12 scudi: secondo una fonte dell’inizio del Novecento, la sinagoga sarebbe stata collocata in “Contrada Selle”. Nel 1588, in seguito alla Bolla di Sisto V, veniva fatta a Moise del fu Isacco una concessione per un banco feneratizio. Il ricordo della permanenza a Veroli è rimasto nel cognome “Di Veroli” adottato da svariate famiglie ebraiche romane. "Bibliografia Esposito", Una descriptio relativa alla presenza ebraica nel Lazio meridionale nel tardo Quattrocento, in Latium, Rivista di Studi Storici 2 (1985), pp. 151-158. Loevinson, La concession de banques de prêts aux Juifs par les Papes des seizième et dix-septième siècles, in REJ XCV (1933), pp. 23-31. Pavoncello. Il IV Centenario dell’espulsione degli Ebrei dalla Campagna Romana, in Israel LIV, nº16 (20 Febbraio 1969). Pavoncello. Le comunità ebraiche laziali prima del bando di Pio V, in Lunario Romano 1980 : Rinascimento nel Lazio, Roma 1980, pp. 47-77. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, 8 voll., Toronto 1988- 1991. Stirpe, Una sinagoga a Veroli, in Lazio ieri e oggi (1984). Stirpe, La scuola degli ebrei di Veroli nel cinquecento, in Lazio ieri e oggi (1987), pp. 16-17. Simonsohn, The Apostolic See, doc. 876. Esposito. Una descriptio relativa alla presenza ebraica nel Lazio meridionale nel tardo Quattrocento, p. 157; si veda Pavoncello, Le comunità ebraiche laziali, p. 52; Simonsohn, ivi, Doc. 960. Si tratta del manoscritto n. 4 già della Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma. <em>Catalogo dei Codici orientali, a cura del ministero della Pubblica Istruzione, fascicolo I, Roma 1878, p. 42, cit. in Pavoncello, op. cit., p. 53, n. 12. Ivi, pp. 53-54. La fonte cui attinge il Pavoncello è una traduzione dei paragrafi relativi agli Ebrei degli Statuti di Veroli , fattagli pervenire da studiosi locali, su cui si veda ivi, p. 54, n. 13. Simonsohn, doc. 1316 e segg. 2842, 3212. (Pavoncello) Il IV Centenario dell’espulsione degli Ebrei dalla Campagna Romana, p. 3. La stessa notizia è riportata anche in Pavoncello, op. cit. 54. Caperna, Veroli, Storia di Veroli, 1907, p. 253, cit. in Pavoncello, op. cit, p. 52. Sulla sinagoga verolana, v. Stirpe, Una sinagoga a Veroli, in Lazio ieri e oggi20 (1984), pp. 54-56; Idem. La scuola degli ebrei di Veroli nel cinquecento, in Lazio ieri e oggi (1987), pp. 16-17. Loevinson. La concession de banques de prêts aux Juifs par les Papes des seizième et dix-septième siècles, p. 29. La stessa concessione viene menzionata, ma con datazione e dati bibliografici errati, anche in Pavoncello, op. cit., p. 54. A Veroli è stata rinvenuta traccia di una famiglia recante il cognome “Efrati”, trasferitasi a Sora e, dopo l’espulsione del 1569, a Roma. Pavoncello, op. cit p. 54 e ibidem, n. 14.
VALLECORSA

Vallecorsa. Provincia di Frosinone. Centro dei "Monti Ausoni" Monti Ausoni, situato nel "Basso Lazio", che sorge sopra un rialzo lungo una valle di passaggio che mette in comunicazione la valle Latina (la Ciociaria) con la piana di Fondi. Appartenne alla famiglia dell’Aquila, poi a quella dei Caetani fino al Quattrocento, quando divenne possesso dei Colonna ai quali rimase fino alla devoluzione dei feudi. La prossimità con il regno di Napoli, richiamò a Vallecorsa ebrei d’oltreconfine in occasione della loro espulsione da parte di Ferdinando il Cattolico nel 1511 e di Carlo V nel 1541. Nel maggio 1531 Benedictus Iacob, abitante a Velletri, acquistò un immobile a Sezze nel quartiere di S. Andrea da maestro Sabato Sacerdote e da Vitus Ioseph hyspanus. L’8 giugno 1543 Salomone di Sacerdote e suo genero David de Traietto ottennero la facoltà, di durata triennale, di esercitare il prestito a interesse nella cittadina e il 22 dicembre dello stesso anno ebbero uguale licenza i fratelli Ventura e Mosè di Graziele di Fondi. Il 28 dicembre 1548 i due ottennero da Salomone di Abramo di Lipari, detto Scimmi, un prestito di 118 scudi, compresi gli interessi, che si impegnarono a restituire entro un anno. Salomone di Sacerdote e suo genero ebbero nel 1544 dalla Camera Apostolica la conferma della condotta sottoscritta con la cittadinanza locale e la licenza fu rinnovata al primo per un altro biennio nel 1549. Nel 1551 ebbero l’autorizzazione di prestare su pegno qui e a San Lorenzo, per la durata di un triennio, i fratelli Mosè ed Elia di Fondi e una simile concessione, triennale, fu confermata nel 1552 anche a Ventura di Graziele. Il registro della vigesima dell’anno 1550 annota la presenza a Velletri di Ventura et fratelli, la cui tassa era di 2 ducati, e di David di Traietto, tassato per 1 ducato e 60 bolognini. Di lì a qualche anno Ventura di Graziele trasferì la propria dimora a Frosinone e qui, il 30 gennaio 1556, fu inquisito per avere violato in materia di prestito, di beni immobili e di familiarità con i cristiani, la bolla Cum sit absurdum emanata da Paolo IV il 14 luglio dell’anno precedente. Per quanto riguarda il prestito, egli ammise di avere dato denaro a interesse ai cristiani dopo la bolla, ma di averlo fatto in forza di una nuova licenza concessagli da Paolo IV il 3 luglio; quanto al periodo precedente, egli aveva esercitato il prestito senza licenza, perché aveva perso il documento per strada quando era andato ad abitare da Velletri a Frosinone. Ventura confermò di avere posseduto in quel di Velletri un oliveto con molti alberi, una <em>possessione de grano, <em>tre mezzi bovi in sòccita e cinque somari alla parte, ma di aver venduto tutto entro il termine stabilito, come risultava dagli strumenti notarili esibiti alla corte. Per quanto riguardava il terzo reato, ammise che sua moglie aveva mandato la figlia Stella a mastro Simone arracamatore in casa de notar Antonio ad imparare a raccamare. Egli fu prosciolto dall’accusa relativa alla vendita degli immobili, ma venne condannato a una multa di 25 ducati d’oro, ridotta poi a 8, per avere prestato denaro senza licenza e per avere tollerato che la figlia Stella andasse a scuola di ricamo dai cristiani e conversasse con loro. Bibliografia. La Terra Nostra Vallecorsa, Roma 1984. De Rossi, La comunità ebraica di Terracina (sec. XVI), Cori 2004. Scarica, Prime indagini sugli ebrei a Sezze tra medioevo e rinascimento (da una ricerca nei protocolli notarili), in Medioevo e rinascimento, ser. NS, 17 (2006), pp. 101-124. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, 8 voll., Toronto 1988-1991. Stirpe, Presenza ebraica nel Lazio meridionale, in Latium, Rivista di Studi Storici, 5 (1988). pp. 19-33. Stirpe, Gli ebrei di Campagna e Marittima e l’editto di Paolo IV, in Scritti in memoria di G. Marchetti Longhi, Anagni 1990, pp. 291-329. La Terra Nostra Vallecorsa, Roma 1984. Scarica, Prime indagini sugli ebrei a Sezze, p. 122. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, doc. 2243, 2239. De Rossi, La comunità ebraica di Terracina, p. 116, n. 308. Il debito fu soddisfatto il 4 marzo 1550 da Mosè di Graziele. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, doc. 2347, 2813, 2965. Stirpe, La presenza ebraica nel Lazio meridionale, p. 29. Stirpe, Gli ebrei di Campagna e Marittima, pp. 302-304.
CEPRANO
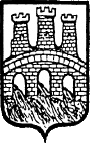
Ceprano . Provincia di Frosinone. Ceprano, che sorge a ridosso dei monti Lepini e domina la valle del Sacco, apparteneva alla provincia pontificia di Campagna e Marittima e fu prima un feudo della famiglia dei Conti, signori di Ceccano, dal 1559 dei Santacroce e dal 1625 dei Colonna. Prospero di Emanuele di Ceprano fu nominato nel 1524, insieme a Mosè di Benedetto di Cori e Samuele di Mele di Ferentino, collettore della tassa della vigesima imposta alle province di Campagna e di Marittima. Quella di Emanuele era una famiglia assai attiva nel prestito: nel 1542 Leo di Emanuele di Ceprano ed il socio Elia di Montopoli erano banchieri a Velletri, esentati dall’obbligo di portare il contrassegno e, nella stessa città, operava anche il fratello di Leo, Gisele. Nel 1546 Leo e Angelo di Emanuele furono incaricati di raccogliere i contributi dovuti dagli ebrei di Sabina, Sezze, Anagni, Ferentino, Tivoli, Terracina, Vetralla, Alatri, Piperno e Genazzano, che non erano stati raccolti dai precedenti esattori, il medico Sabato di Sacerdote e Sabato di Ventura. Benedetto di Mele di Ceprano era , invece, prestatore a Ripi nel 1545: a Ceprano, dove abitava, egli pagò per la vigesima 10 ducati e 80 bolognini, più 90 bolognini di interesse. Banchiere in questa località era, invece, nel 1545 con facoltà triennale, Raffaele di Angelo di Bauco. Il 5 dicembre 1555 Benedetto di Mele e Lazzaro di Sacerdote furono sottoposti a procedimento giudiziario a Ceprano con l’accusa di aver fatto diverse usure, in violazione della bolla Cum nimis absurdum emanata da Paolo IV il 14 luglio di quell’anno. Secondo l'accusa, essi speculavano sulla compravendita di bovi, mezzi bovi, quarti di bovi acquistati in cambio di grano o di denaro, ma essi si difesero appellandosi ad una speciale concessione che li autorizzava non solo a fare usure in qual modo lì piace, ma anche a praticare prestiti ad interesse e su pegno di qualsiasi genere, compresi quelli di necessità. Per questa ragione sia Benedetto che Lazzaro, ed il loro fattore Ventura di Ripi, erano stati già assolti dal vescovo di Veroli il 19 novembre. Quanto al resto, essi avevano osservato e osservavano gli altri capitoli della bolla: avevano venduto <em>in credenza i rispettivi beni stabili (entrambi la propria casa di abitazione ed un orto ciascuno) per la somma totale di 135 ducati e, come altri ebrei, si erano serviti di cristiani a lavare panni e a portare acqua in casa, pagando sempre botta per botta il prezzo richiesto ed anche, talvolta, qualcosa in più. Avevano venduto, poi, certi pannetti che avevano in casa, di proprietà di un loro parente di nome Sabato, avevano osservato e osservano gli statuti di Ceprano sebbene prima non vi fossero tenuti in virtù della speciale concessione in loro possesso ed avevano continuato a prestare denaro dopo la bolla con l'interesse di un baiocco per ducato e anco gratis et amore. Sollecitata, quindi, la sentenza assolutoria, questa fu emessa il 12 dicembre. "Bibliografia Iacovacci". Da Fregelle a Ceprano. La storia del mio paese, Ceprano 2005 (ristampa copia anastatica). Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, 8 voll., Toronto 1988-1991. Stirpe, Gli ebrei di Campagna e Marittima e l’editto di Paolo IV, in Scritti in memoria di G. Marchetti Longhi, Anagni 1990, pp. 291-329. Stirpe, Presenza ebraica nel Lazio meridionale alla metà del Cinquecento, in Latium, Rivista di Studi Storici, 5 (1988), pp. 19-33. Iacovacci, Da Fregelle a Ceprano. La storia del mio paese, Ceprano 2005 (r.a.). Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, n. 1316. Ivi, doc. 2158, 2160, 2178, 2564, 2601. Stirpe, Presenza ebraica nel Lazio meridionale, p. 33. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, n. 2521. Stirpe, Gli ebrei di Campagna e Marittima, pp. 301-302.
VALMONTONE

Provincia di Roma. Posta su di un colle tufaceo alla confluenza di due valli, sulla via Casilina, Valmontone, è di origine altomedievale ed è ricordata con il nome attuale nel secolo XII. Ha visto nel corso della sua storia l’avvicendarsi di molti signori: Canonici della Basilica del Laterano, Conti, Sforza, Barberini e Pamphilj. Un Salomone di Angelo, figlio di Abramo di Valmontone, attivo a Perugia nel 1449, attesta la presenza di ebrei nel borgo laziale almeno dalle prime decadi del XV secolo. Nel 1472 abitavano a Valmontone, sette famiglie ebraiche, la più eminente delle quali era quella di un Mastro Salomone, il cui contributo per la tassa della vigesima era di 50 ducati, mentre quello delle altre famiglie assommava soltanto a 18 ducati. Nel 1486 la piccola comunità, insieme ad altre di Campagna, ricusava di partecipare al sussidio imposto da Innocenzo VIII agli ebrei delle sue province. L’atteggiamento non solo dispiacque al papa, ma avendo egli anche estrema necessità del denaro, comandò al Governatore Giuliano Quattrocchi di provvedere con tutti i rimedi e le pene opportune perché il contributo fosse immediatamente (statim et sine mora) pagato. Nella prima metà del secolo XVI, ebrei originari di Valmontone, abitavano a Norcia e ad Ascoli Piceno, qui con altri correligionari provenienti dall’Italia centro-meridionale (Campli, Sulmona, Lanciano, Ortona, Teramo, L’Aquila) Bibliografia De Bianchi, Storia di Valmontone, Valmontone 1981. Gobbi, Emigrazione, conversione, riconversione ebraica nel Piceno, in La presenza ebraica nelle Marche. Secoli XIII-XX, a cura di S. Anselmi, V. Bonazzoli, Ancona 1993, pp. 109, 116 (Quaderni di «Proposte e ricerche», n. 14).Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, 8 voll., Toronto 1988-1991.Toaff, The Jews in Umbria,Leiden-New York-Köln 1993-94.Cfr. De Bianchi, Storia di Valmontone, Valmontone 1981. Toaff, A., The Jews in Umbria. 2. 1435-1484, Leiden 1994, p. 579, doc. 1119. Simonsohn , S., The Apostolic See and the Jews. Documents: 1464-1521, Toronto 1990, p. 1199, doc. 960*; p. 1343, doc. 1061. Toaff, A., The Jews in Umbria. 3. 1484-1736, Leiden 1994, p. 1180, doc. 2294; Gobbi, Emigrazione, conversione, riconversione ebraica nel Piceno, in La presenza ebraica nelle Marche. Secoli XIII-XX, a cura di S. Anselmi, V. Bonazzoli, Ancona 1993, pp. 109, 116 (Quaderni di «Proposte e ricerche», n. 14).
TIVOLI
Tivoli . Provincia di Roma. Città romana (Tibur) e medievale. Nel "Medioevo" Tivoli fu "Sede vescovile" e fortemente implicata nelle contese feudali. Nel "XV secolo" tornò nel patrimonio della Chiesa, del cui "Stato della Chiesa" seguì le sorti. Il documento più antico sulla presenza ebraica a Tivoli risale al 1308, quando in una deliberazione del Comune, relativa all’emissione di severe disposizioni suntuarie, veniva fatto riferimento al prestito ebraico su pegno.In un atto testamentario del 1373 si trova ancora un riferimento all’attività feneratizia ebraica nella località e, alcuni anni più tardi, da un rogito notarile del 1387 risulta che l’ebreo Consilio Dactuli prestava qui denaro su pegno: egli figurava anche nell’elenco di spese registrate dal notaio del Comune nel 1389 e, nello stesso anno, documenti comunali menzionavano un Angelo Dathuli ed altri ebrei, multati per aver partecipato al gioco dei dadi, che era proibito. Sempre nel 1389, l’ebreo Elia di Vitale risultava aver prestato denaro al Comune, venendone rimborsato. All’epoca era attivo nel prestito anche l’ebreo Brunetto, che si era trasferito da Firenze a Tivoli. Nel 1389, veniva imposto l’obbligo del segno distintivo – un tabarro rosso - agli ebrei locali. Il primo documento attestante la presenza di un medico ebreo a Tivoli è, invece, un atto notarile del 1388, in cui Nicola Pometta del Castello dei Colli di S. Stefano promette di pagare 4 fiorini a mastro Salomone Ebreo medico in fisica di Tivoli. Alcuni anni più tardi, troviamo il medico Mosè da Tivoli, che, nel 1405, otteneva la cittadinanza romana, convalidata, l’anno successivo, da papa Innocenzo VII. Più di una ventina di anni dopo, nel 1428, alcune famiglie ebraiche si stabilirono a Tivoli ed al loro stanziamento viene fatto risalire l’allestimento del cimitero e della sinagoga. Nello stesso 1428 furono poi ratificati i capitula tra il Comune di Tivoli e l’Università ebraica, di cui il medico Magister Saban figurava tra i rappresentanti più prominenti. I capitula prescrivevano la cifra da versare da parte degli ebrei per i ludi di Testaccio, per il tributo al popolo romano imposto con i patti del 1259 e per eventuali spese in caso di emergenza. Gli israeliti, d’altro canto, erano esentati da ogni tributo al Comune e non dovevano essere processati se avessero ricevuto in pegno oggetti rubati. Nel 1442 si tenne a Tivoli un incontro dei rabbini italiani, che cercavano di neutralizzare le conseguenze della Bolla di Eugenio IV dello stesso anno. Nel 1475 risultava attivo nel prestito su pegno a Tivoli il medico ebreo Magister Sabatutius (o Sabaritius). Fra i beneficiari di tolleranze della Camera apostolica per poter fenerare a Tivoli nel '500 vi furono: Maestro Consulo de Rosata, medico, Emanuele alias Sbardella, Abramo de Sermoneta, Prospero di Gabriele e Moyse di Moyse, soci in Tivoli (1538); Aleutio di Moyse da Veroli e Pellegrino da Aversa (1542); Abramo di Deodato, figlio di Mathesia da Capua (1542); Consilio de Salomone e suo genero Sabatucio de Gavio da Fondi (1543); Emanuele di Isacco da Aversa (1543, 1544); Maestro Angelo di Gaudio da Fondi e suo nipote Sabbatuccio di Beniamino e Angelo di Aleutio (1543); Ventura di Isacco Bonnani da Fondi (1543); Gayo di Emanuele, Moyse de Moyse da Rieti e Moyse di Angeluno da Loreto (1544); Peregrino di Davide e Emanuele di Isacco di Lazaro da Aversa (1546); Emanuele di Abramo da Cori (1548); Emanuele di Isacco di Lazaro da aversa e Gentildonna; vedova di Pellegrino di Davide, soci a T. (1548); Raffaele e Davide di Moyse da Aversa (1548); ed i fratelli Angelo e Ventura di Sabbatucio (1552). Nel 1549 papa Paolo III prorogò i privilegi degli ebrei a Tivoli e concesse loro un perdono di tutti i delitti in seguito al pagamento della vigesima. Lo stesso venne fatto da papa Giulio III nel 1553. Nell’elenco delle sinagoghe che, dal 1560 sino alla Bolla di espulsione del 1569, corrispondevano la tassa alla Casa dei Catecumeni di Roma, figurava anche quella di Tivoli prima con 10 e poi con 12 scudi. Era originaria di Tivoli la prestigiosa famiglia dei da Tivoli, prestatori attivi in Toscana, il cui membro più noto è David da Tivoli. Quartiere ebraico e ghetto. Il quartiere ebraico era ubicato nei pressi del Vicolo dei Granai, nella zona centrale di Tivoli. Dopo la Bolla "Cum nimis absurdum" (1555), tale quartiere venne separato dal resto della città da due porte, mutandosi in ghetto vero e proprio. Secondo un’indicazione toponomastica settecentesca, il Vicolo dei Granai veniva designato come la “Via dei giudii”, rimanendo così denominato anche in seguito. La sinagoga, che risale al XV secolo, sorgeva "in Palatiis": presumibilmente, la sua ubicazione era all’angolo tra l’attuale Via Palatina e il Vicolo dei Granai. Cimitero. Nel XV secolo fu istituito a Tivoli un cimitero nella località denominata “Magnano”, sito a valle dell’attuale Strada Nazionale Tiburtina. Attività culturali. A Tivoli fu ultimato, nel 1332, il Codice 29 della Casa dei Neofiti, custodito successivamente alla Biblioteca vaticana. Nello stesso anno, Yitzhaq di Yaaqov de Synagoga svolgeva attività di amanuense nella località. Nel 1383, era rabbino a Tivoli Daniel di Shemuel di Daniel-ha Rofe. Nel XV secolo, Mordekhai di Yitzhaq di Tivoli copiava il codice 269 custodito alla Biblioteca nazionale di Parigi. Bibliografia Cabral, Del Re, Delle ville e de’ piu notabili monumenti antichi della città e del territorio di Tivoli, Roma 1779. Cassuto. La famiglia di David da Tivoli, in Corriere israelitico<em>, XLV(1906-7), pp. 149-52; 261-264; 297-301. Freimann, Jewish Scribes in Medieval Italy, in Alexander Marx Jubilee Volume, New York 1950, pp. 230-342. Milano, Storia degli ebrei in Italia, Torino 1963. Mosti. Medici ebrei del XIV-XV secolo a Tivoli, in Atti e Memorie della Società tiburtina di Storia e dell’Arte XXVII (1954), pp. 109-156. Pavoncello. Le comunità ebraiche laziali prima del bando di Pio V, in Lunario Romano 1980: Rinascimento nel Lazio, Roma 1980, pp. 47-77. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, 8 voll., Toronto 1988-1991. Viola, Storia di Tivoli dalla sua origine fino al sec. XVII, tomi 3, Roma 1819. Vogelstein, Rieger, Geschichte der Juden in Rom, I, Berlin 1896. Più precisamente, si tratta di una deliberazione comunale del 28 settembre 1308, aggiunta allo Statuto di Tivoli del 1305, insieme ad altre tre deliberazioni del maggio e dell’ottobre 1308. Federici, ( a cura di), Statuto di Tivoli del 1305 con aggiunte del 1307-8, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 1910, pp. 117-125, cit. in Mosti, Medici ebrei del XIV-XV secolo a Tivoli, p. 116, n. 40; cfr. ivi, pp. 116-120. Tani, Gli ebrei a Tivoli, in Bollettino di Studi Storici ed Archeologici di Tivoli, Anno I (1919), p. 138, cit. in Mosti, op. cit, p. 120, nn. 42- 44; Federici, Atti del Comune di Tivoli dell’anno 1389, in Bollettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, n. 28 (1906), p. 89, p. 93, cit. in ivi, p. 120, n. 45. Federici, Atti del Comune di Tivoli (cit.), p. 98; p. 68; Tani, op. cit., p. 138, cit. in Mosti, R., op. cit., pp. 121-123, nn. 46, 47, 55. Viola, Storia di Tivoli dalla sua origine fino al sec. XVII, tomi 3, Roma 1819, III, 16; Tani, op. cit., p. 138; Idem, Gli archiatri israeliti tiburtini, in Bollettino di Studi Storici e Archeologici di Tivoli, X (1932), pp. 2066-77, cit. in Mosti, op. cit., p. 128, n. 64. Nella stessa nota il Mosti afferma che il titolo dell’ultima opera del Tani citata è improprio, perché né vi vengono menzionati “archiatri” ( nella comune accezione etimologica di medico papale, medico di corte o protomedico) né ne viene attestata l’esistenza altrove. Mosti, op. cit., p. 134; il testo papale, con cui la cittadinanza di Mosè veniva convalidata, si trova in ivi, pp. 137-142; Simonsohn, The Apostolic See, doc. 567. Sul conferimento della cittadinanza romana a Mosè da Tivoli e ad altri Ebrei, si veda anche la voce “Roma” della presente opera. Mosti, op. cit. pp. 143-144. Pacifici, Codice diplomatico di Antonio di Simone Petrarca, Coll. "Studi e Fonti della Società Tiburtina di Storia d’Arte", Tivoli, 1929, p. 85; p. 85; p. 87, citato in Mosti, op. cit., pp. 147-148, nn. 109 e 111. Milano, Storia degli ebrei in Italia, Torino 1963, p. 478. Mosti, op. cit., p. 152. Simonsohn, The Apostolic See, doc. 1888, 2104, 2177, 2237, 2242, 2253, 2288, 2350, 2363, 2649, 2794, 2796-7, 3084. Ivi, doc. 2872, 3156. Pavoncello, Le comunità ebraiche laziali prima del bando di Pio V, in Lunario Romano 1980: Rinascimento nel Lazio, Roma 1980, pp. 47-77, p. 73. Per la famiglia da Tivoli, si veda Cassuto, La famiglia di David da Tivoli, in Corriere israelitico, XLV(1906-7), pp. 149-52; 261-264; 297-301; cfr. anche la voce “Firenze” della presente opera. Tani, Gli ebrei a Tivoli, cit., p. 136; Cabral, - Del Re, Delle ville e de’ piu notabili monumenti antichi della città e del territorio di Tivoli, Roma 1779, p. 127; Pacifici, Tivoli nel Medioevo, in Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte, V-VI (1925-26), p. 47 e p. 87, citato in Mosti, op. cit, p. 146, nn. 103-105. Ivi, p. 144. Ivi, p. 143. Da una lapide rinvenuta nei pressi si apprende della sepoltura di Rachel, moglie del medico Salomone, presumibilmente attivo a Tivoli (si veda Mosti, op. cit. p. 129; p. 143, n. 95). Il Tani indica altri luoghi di sepoltura (presso le torri di Rocca Pia e nel cosiddetto Ortaccio fuori di Porta Cornunda o Cornuta), che, in assenza di riferimenti cronologici, sono stati ritenuti più tardi rispetto al cimitero di Magnano (Tani, Gli ebrei a Tivoli, cit., p. 138, citato in Mosti, op. cit. p. 143, n. 95). Sacerdote, Codici ebraici, in Atti dell’Accademia dei Lincei, Roma 1893, p. 198, citato in Pavoncello, op. cit., p. 71, n. 51; Vogelstein, - Rieger, Geschichte der Juden in Rom, p. 330, n. 3. Sull’attività di amanuense del de Synagoga, si veda Pavoncello, op. cit. p. 71 (senza indicazione della fonte da cui è desunta la notizia). Freimann, Jewish Scribes in Medieval Italy, p. 299 nº 331. Un amanuense di origine tiburtina, Shabbetai di Yehoshua da T. , copiava due codici negli anni Settanta e Ottanta del XV secolo, a Napoli e a Ferentino. Ivi, p. 314, nº 436.
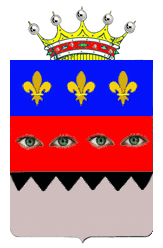
sito a cura di Gilberto Quattrocchio e Patrizia Prodan
altri siti di Gilberto:
siti degli amici di Gilberto:
© copyright Olaf GILBERTO QUATTROCCHIO - PATRIZIA PRODAN